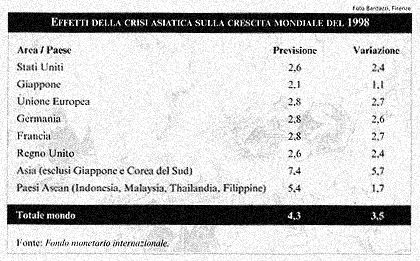Il profilo dell'economia
globale nel 1997 è caratterizzato da un grande spartiacque,
sommariamente databile attorno a settembre. Prima di allora, l'espansione
produttiva era proseguita con grande speditezza, in un clima di ottimismo
generalizzato, alimentato da tre diversi fattori: il prolungarsi della
fase espansiva dell'economia americana, che non accennava a dare segni
di stanchezza, l'apparire di sintomi di ripresa in Europa,, e il perdurare
- sia pure con una relativa perdita di slancio - del "miracoloasiatico".
Questo terzo fattore di crescita mondiale è venuto bruscamente
meno con la fine dell'estate. Un confuso susseguirsi di avvenimenti
ha dato luogo a quella che si definisce come "grande crisi asiatica".-
una sequenza complessa di crisi valutarie, crisi di Borsa, crisi aziendali,
crisi politiche, in progressiva estensione e aggravamento, che ha
coinvolto direttamente oltre una decina di Paesi e indirettamente
l'intera economia mondiale.
Ne sono duramente toccati un Paese come il Giappone, componente essenziale
dell'economia globale, una piazza finanziaria di prima grandezza,
come Hong Kong, imprese finanziarie e industriali di rilevanza mondiale,
come Yamaichi e Hyundai. Il tutto ha gettato un'ombra minacciosa sul
panorama, altrimenti ottimistico e solare, dell'economia mondiale
di mercato; e, pochi giorni prima del Natale, ha indotto il Fondo
monetario internazionale (Fini) a rivedere al ribasso in maniera consistente
le prospettive per il 1998. Già poche settimane più
tardi, tali previsioni riviste sembravano peccare per troppo ottimismo.
Secondo il Fmi, a seguito della crisi asiatica il tasso di crescita
mondiale dovrebbe ridursi di quasi un quinto. Questo "effetto
Asia" risulta fortemente differenziato. Lo subiscono direttamente
le "tigri" del Sud-Est asiatico e, tra le grandi economie,
risulta seriamente colpito il Giappone, già caratterizzato
da bassissimo dinamismo; ma anche per Stati Uniti, Francia, Regno
Unito e Germania la revisione non appare del tutto trascurabile. L'Ocse,
del resto, dopo aver rivisto al ribasso, dal 3,8 al 2,9 per cento,
nella sua analisi semestrale, le stime di crescita per l'area dei
Paesi industrializzati, a dicembre ha operato un'ulteriore correzione,
portando la propria stima al 2,5 per cento.
La possibilità che questi sviluppi sfuggano di mano, imprimendo
all'economia globale un andamento negativo di portata tale da modificarne
sostanzialmente la natura, non appare più soltanto teorica.
La parola "deflazione", da decenni sconosciuta al vocabolario
degli analisti finanziari, è stata frettolosamente riesumata
e ha assunto connotazioni minacciose. Il pericolo di una deflazione
mondiale è stato prospettato in un discorso ufficiale da Alan
Greenspan, governatore della Federal Reserve, la Banca centrale degli
Stati Uniti, ai primi di gennaio di quest'anno.
A torto o a ragione, i fantasmi degli Anni Trenta paiono uscire di
nuovo dalla soffitta della storia, riproponendo interrogativi sulla
natura e la stabilità del capitalismo.
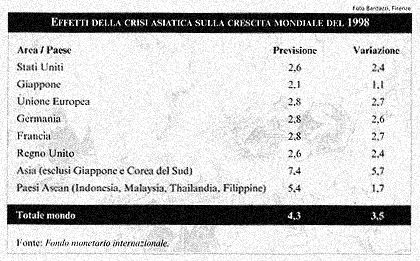
Hong Kong è non un gioiello della corona del capitalismo mondiale,
bensì un ingranaggio importante del meccanismo finanziario
mondiale. E' l'ottava piazza finanziaria del mondo (Milano è
la sedicesima) e la seconda in Asia, dopo Tokyo; il suo sistema di
diritto commerciale fa invidia a molti Paesi europei; la sua efficienza
amministrativa farebbe certo invidia all'Italia, se l'Italia prestasse
veramente attenzione a queste cose.
Sede di una rispettabilissima università, vanta il più
alto tasso mondiale di diffusione di quotidiani (850 ogni mille abitanti,
circa 6 volte più dell'Italia), è il secondo mercato
al mondo per i gioielli di Cartier, la perla degli esportatori di
cognac, una meravigliosa città con alcuni degli alberghi più
belli del mondo e un punto di transito pressoché indispensabile
per i capitali europei, americani e giapponesi destinati a investimenti
in Cina. Solo Hong Kong è in grado di spiegare l'Occidente
alla Cina e la Cina all'Occidente, di tradurre (anche da un punto
di vista linguistico) aspirazioni e istanze dell'uno nei termini dell'altro.
La decisione di cedere Hong Kong alla Cina fu presa quasi vent'anni
fa e il vertice del G7 tenuto a Denver nel giugno 1997 ne ha solo
preso atto in via definitiva. Inevitabile per il Regno Unito da solo,
avrebbe potuto indubbiamente essere capovolta mediante un'azione congiunta
di tutte le potenze occidentali. Queste non l'hanno fatto. Hanno invece
presentato Hong Kong ai cinesi su un piatto d'argento, al suono dei
pifferi e delle cornamuse degli scozzesi che ammainavano la bandiera.
Che cosa succederà ora? Le soluzioni possibili sono solamente
tre.
Prima soluzione: una "cinesizzazione" piuttosto rapida e
brutale dell'ex colonia, con l'erosione delle libertà civili
e la distorsione in termini cinesi delle libertà di mercato.
In questo caso, risulterebbero vittoriose le "gelosie" di
Shanghai e di Canton e si avrebbe, nel giro di cinque o dieci anni,
un rapido declino dovuto alla perdita dei caratteri di unicità
che costituiscono il vero patrimonio di Hong Kong.
Seconda soluzione: una continuazione delle cose così come sono
ora, col mantenimento dell'alta dirigenza burocratica e un rapporto
diretto con Pechino che seguiterà a riconoscere a Hong Kong
i suoi "privilegi", giocando anzi sull'antagonismo con le
vicine città della Cina meridionale.
Naturalmente, le libertà civili saranno attenuate. In questo
caso, Hong Kong non decadrà, ma è difficile prevederne
una crescita ulteriore.
Terza soluzione: è quella illustrata dalla bellissima copertina
di "The Economist" nella settimana della transizione. Hong
Kong, in una mano un sacchetto di dollari e nell'altra la bilancia
della giustizia, ferma i tanks dell'esercito cinese. La prospettiva,
insomma, è che Hong Kong, elemento essenziale per la trasformazione
nel senso del mercato dell'economia cinese in quanto colonia britannica,
diventi elemento di trasformazione in senso democratico dell'intera
società e della politica cinese, in quanto "territorio
speciale" della madrepatria.
Naturalmente, a Pechino i "duri" sperano nella prima soluzione,
gli innovatori nella seconda. A Denver, la speranza si è incentrata
nella terza. Così apparentemente attento a misurare i rischi
d'affari, con Hong Kong il capitalismo ha fatto un'autentica scommessa
politica all'insegna dell'incertezza. E' la scommessa oraziana del
"Graecia capta ferum victorem coepit" che molti assolutisti
a Pechino vedranno come una sorta di cavallo di Troia entro le mura
della cittadella cinese.
Per questa scommessa passa la speranza di un'economia mondiale stabile,
di un'evoluzione pacifica di un miliardo e 200 milioni di cinesi verso
la prosperità e la libertà. Ci sarebbero da risolvere
problemi di ogni genere, in quanto l'ingresso cinese nella fascia
dei redditi per abitante medio-alti non comporterà certo la
semplice ripetizione dei modelli di consumo europeo o americano. Vincoli
geografici, ecologici e demografici, rendono impensabile una replica
del boom individualistico dei consumi dei nostri "miracoli economici";
si dovranno studiare e trovare forme nuove di domanda privata e pubblica.
Un'eventuale sconfitta del disegno di mercato significherebbe, d'altra
parte, un brusco aumento della tensione internazionale accompagnato
da una crisi finanziaria non piccola, che si aggiungerebbe alle attuali
fortissime difficoltà asiatiche.
E' questa l'alea che l'Occidente ha dimostrato di voler correre; per
questo, quanto accadrà a Hong Kong nei prossimi anni influenzerà
tutto il mondo. L'isolotto che i cinesi cedettero al termine della
Guerra dell'Oppio diventa così l'ombelico del capitalismo.
|