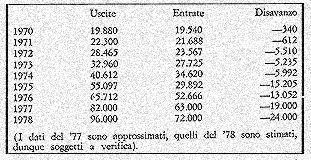Un politologo francese,
Jean François Revel, ha coniato recentemente un'espressione particolarmente
felice per designare quei politici ed in particolare quei sindacalisti
che in seguito a nuove batoste economiche sono ora disposti a fare dell'autocritica.
Sono, insomma, dei " profeti retrospettivi ". Affermano: se
si fosse fatto quello, non sarebbe capitato questo. Dimenticano, naturalmente,
che a suo tempo hanno proprio patrocinato quello che poi ha dato luogo
a questo, e cioè alle batoste economiche.
Sarebbe troppo lungo elencare, in base all'esperienza italiana, gli errori
di politica economica commessi negli anni Settanta, ed anche prima, errori
che oggi si cerca di far dimenticare con un po' d'autocritica. Come se
l'autocritica fosse sufficiente per sanarli. Così, solo per far
qualche esempio, non basta dire, profetizzando all'incontrario, che il
salario non è una variabile indipendente, che la conflittualità
permanente sfascia le imprese, e così via. Non vale piangere sul
latte versato. Piuttosto, bisogna rendersi conto, oggi come oggi, quali
potranno essere domani le ripercussioni negative d'alcune richieste contenute
nelle cosiddette piattaforme sindacali, concernenti la ristrutturazione
salariale che direttamente o indirettamente modificheranno la distribuzione
del reddito nazionale tra i fattori di produzione.
Ho già scritto che da alcuni anni al fattore lavoro, dipendente
ed indipendente, tocca una quota via via maggiore del reddito nazionale
netto, al costo dei fattori. Nel 1977, questa quota ha superato il 92
per cento, per cui agli altri fattori di produzione è rimasto solo
poco meno dell'8 per cento. Partendo da questa constatazione sono possibili
alcune riflessioni su quanto potrà verificarsi, se per l'appunto
si accoglieranno o le richieste di cui s'è appena fatto cenno.
Prima riflessione. Da anni si sente parlare di " giungla" salariale.
L'inventore di quest'espressione che mira a porre soprattutto in evidenza
alcune differenze di retribuzione, e proprio per questo condannarle, ne
ha tratto fama politica. S'è perfino costituita una commissione
parlamentare che ne ha discusso in lungo e in largo. Non s'è preso,
però, in adeguata considerazione il fatto che la giungla non riguarda
solo i salari e gli stipendi, ma anche e soprattutto la produttività.
In altri termini, non si possono stabilire confronti omogenei, e quindi
significativi, tra i livelli retributivi, se contemporaneamente non si
tiene conto della produttività, o meglio ancora della produzione
per unità di lavoro che corrisponde a queste remunerazioni.
Se si tenesse conto della componente produttività, sarebbe facile
constatare che in alcuni casi i divari nelle retribuzioni non trovano
alcuna giustificazione, per cui s'è veramente di fronte ad una
giungla che non sarà tanto facile disboscare, perché a quest'azione
risanatrice s'oppongono concreti interessi corporativi. In altri casi,
invece, il divario è più che giustificato, perché
ad una diversa remunerazione corrisponde una diversa qualità e
quantità di lavoro. Solo stabilendo questa diversa correlazione
è possibile ottenere un impegno produttivo individuale, che in
fin dei conti non giova solo ai singoli, ma a tutta la collettività.
Il divario assume un significato del tutto particolare in relazione ad
alcune richieste intese a modificare la struttura delle remunerazioni.
Non è qui il caso di soffermarsi sui procedimenti per effettuare
questa ristrutturazione, tanto più che la materia è ancora
oggetto di discussione nell'ambito delle organizzazioni sindacali.
Un aspetto particolare riguarda la revisione per dare più ampio
spazio alle remunerazioni dirette ed immediate, vale a dire quelle che
in concreto si trovano nella busta paga, e questo restringendo lo spazio
di quelle indirette che, grazie agli oneri sociali ed assistenziali, si
concretano in servizi attuali, come quelli sanitari, ed in remunerazioni
differite, come sono le pensioni.
Si comprendono facilmente i motivi di questa revisione. Da che mondo è
mondo, sempre meglio un uovo oggi che una gallina domani, specie se la
gallina si prospetta spennata dall'inflazione, ed in particolare se si
ritiene che in ogni caso sarà allevata a spese della collettività.
Solo apparentemente, però, il costo del lavoro per le imprese,
che è quello che conta, non subirà aumenti. In realtà,
qualcuno dovrà pur pagare gli oneri sociali ed assistenziali, dato
che non è possibile ridurre i servigi attuali e le remunerazioni
differite. Se non si pagheranno con contributi sociali, si pagheranno
con tributi, o peggio ancora con l'inflazione.
Un altro aspetto di questa ristrutturazione delle remunerazioni, pure
assai significativo, è quello che risulta dalla tendenza a collegarla
con un ulteriore passo avanti sulla via dell'appiattimento delle retribuzioni
stesse. L'idea per alcuni sindacalisti sarebbe quello di un salario e
stipendio uguale per tutti, quale che sia l'apporto di ognuno in relazione
alla rispettiva produttività. Questo livellamento di retribuzione
mira dunque ad eliminare ogni forma di " meritocrazia ". Un
principio analogo, del resto, a quello d'alcuni studenti quando chiedono
la promozione assicurata ed il voto uguale per tutti. Lo sfascio della
scuola dovrebbe ammonire coloro che chiedono di estendere l'applicazione
di questo principio all'attività produttiva.
Risulta ad evidenza, dunque, che i progetti di ristrutturazione delle
remunerazioni non tanto mirano a disboscare la giungla retributiva, quanto
a livellarla, il che non sarà certo verso l'alto, bensì
verso il basso, e comunque sganciata da ogni riferimento ad una maggiore
produttività. Quindi, questo livellamento, è destinato a
provocare un ulteriore ristagno dell'attività produttiva che, si
voglia o non si voglia, è sempre affidata alla volontà dei
singoli d'emergere, d'andare avanti, una volontà che si concreta
in un trascinamento che favorisce il funzionamento del sistema economico
considerato come un tutto. Questo ristagno alla fine dà luogo,
come pure l'esperienza insegna, alla formazione di gruppi privilegiati,
in quanto operano nell'ambito del mercato ufficiale del lavoro, e di gruppi
emarginati.
Questi sono i problemi che anche i politici, ma ancora più i sindacalisti,
devono affrontare con criteri realistici, in vista di quanto potrà
accadere domani. E non c'è bisogno di molta fantasia per rendersi
conto che ogni appiattimento delle retribuzioni, e quindi ogni rottura
dei legami tra remunerazioni e produttività, è destinato
a rallentare lo sviluppo produttivo. E se non è più il caso
di fare profezie per il passato, si cerchi almeno, con cognizione di causa,
di non sbagliare ancora guardando al futuro.
Investimenti
e risparmio
Quando Keynes, poco
prima di morire, disse che non era keynesiano, già intuiva che
i dirigenti della politica economica stavano preparando un sostanziale
travisamento del modello con cui aveva cercato di schematizzare il funzionamento
dei sistemi economici. Modello, com'è noto, basato sulla coordinata
azione del principio di moltiplicazione e di quello di accelerazione.
I dubbi di Keynes riguardavano in particolare l'applicazione in termini
di politica economica del principio di moltiplicazione, con il quale
s'afferma che l'aumento del reddito nazionale, variabile dipendente,
può considerarsi come un multiplo degli investimenti, variabile
indipendente. Sicché, se si sostengono gli investimenti, s'incrementa
pure il reddito nazionale, e quindi i consumi ed il risparmio, il quale
a sua volta consente di fornire ulteriore sostegno agli investimenti.
Il risparmio è dunque sempre necessario.
Faccio grazia ai lettori, e specialmente a quelli che ancora accettano
acriticamente il mito keynesiano, contrapponendolo sdegnosamente ad
altri definiti " classici ", di tutti i se e di tutti i ma
che condizionano il funzionamento di siffatto modello. Mi limito a dire
che ha funzionato in anteprima per rimettere in sesto l'economia degli
USA, colpiti dalla grande crisi 1929-33. Ma allora queste economie erano
soggette ad un violento processo deflazionistico il quale, a sua volta,
dava luogo ad una continua caduta della produzione. Cadevano pure i
consumi, ed anche quel poco di risparmio che si formava rimaneva inoperoso.
Non si dimentichi, a questo proposito, che negli anni della grande crisi
i prezzi all'ingrosso e al minuto si dimezzarono. Sicché, una
politica monetaria espansiva intesa a sostenere gli investimenti, anche
di natura autonoma, e cioè non strettamente legati al risparmio,
aveva un ampio margine d'azione senza provocare particolari stimoli
inflazionistici. Questo è un punto sostanziale da tener presente,
al fine di non ripetere ad orecchio ricette economiche che in questo
dopoguerra, ma specialmente negli ultimi anni, hanno consentito di innescare
stimoli inflazionistici che non si sa quando potranno essere annullati.
Bisogna tener presente, in altre parole, che i modelli economici sono
strumenti che di volta in volta debbono essere adattati alle particolari
situazioni di fatto. E' vero che non sempre il risparmio, che in questo
caso meglio si potrebbe definire tesoreggiamento, porta automaticamente
agli investimenti. Ma è altrettanto vero che se il finanziamento
degli investimenti è effettuato come moneta aggiuntiva, e cioè
superiore a quella richiesta dal mercato, l'aumento del reddito nazionale,
condizione necessaria ma non sempre sufficiente per un aumento del risparmio,
dà luogo a processi inflazionistici.
L'innescamento di processi inflazionistici si verifica particolarmente
quando la produttività di un sistema segna il passo rispetto
all'incremento dei flussi monetari con i quali si remunerano i fattori
di produzione. Si tratta di un altro punto che il modello keynesiano
non teneva e forse non poteva tener presente nel momento in cui venne
realizzato. Difatti, per il funzionamento di questo modello si richiede
che l'offerta delle prestazioni dei fattori di produzione, e specialmente
del lavoro, nonché dei beni e servigi che derivano dal loro operare,
sia elastica rispetto alla domanda. In caso contrario si generano pressioni
inflazionistiche. Il concetto della piena occupazione del lavoro è
validissimo sul piano sociale. E lo sarebbe anche sul piano economico,
se le remunerazioni di questo fattore di produzione aumentassero in
parallelo alla sua produttività. Ma se l'elasticità del
mercato del lavoro è difettosa, e questo avviene quando una politica
di piena occupazione risulta avulsa da ogni condizionamento economico,
le conseguenze non possono essere che quelle che ci stanno sotto gli
occhi.
Su queste conseguenze non è il caso di insistere. Piuttosto,
è necessario ribadire che gli investimenti sono oggi più
che mai legati al risparmio, ed anche, se si vuole essere più
precisi, alle modalità con cui il risparmio è impiegato.
Sappiamo, tutti che nel nostro sistema economico l'unica fonte di risparmio
sono oggi le famiglie. Il risparmio delle imprese, il cosiddetto autofinanziamento,
è diventato negativo. Questa espressione può suscitare
qualche meraviglia. Il risparmio può essere negativo? Sicuramente.
E più precisamente quando non genera un processo di accumulazione
del capitale, bensì si risolve in una decumulazione. In alcuni
casi, infatti, l'ammontare dei salari e stipendi pagati da imprese supera
il valore aggiunto dalle imprese stesse. Ciò significa che i
salari e stipendi sono pagati con quote di capitale, come del resto
risulta dal crescente indebitamento delle imprese.
Il risparmio della Pubblica Amministrazione, misurato dagli investimenti
pubblici finanziati con tributi e contributi, è pure negativo.
Da tempo, infatti, questi investimenti sono, finanziati esclusivamente
con debito pubblico. Ma questo non avviene solo con gli investimenti.
Con debiti, ed anche con emissione di moneta, si fa pure fronte ad una
parte delle spese correnti, che per la quasi totalità riguardano
remunerazioni e trasferimenti di reddito che poi le famiglie riducono
in consumi ed in risparmio.
Così il principio di moltiplicazione si sviluppa in modo contrario
a quello tradizionale. Non dà luogo, cioè, al principio
di accelerazione, per cui un aumento del reddito nazionale genera un
aumento del risparmio, e quindi degli investimenti, vale a dire del
fondo netto di beni strumentali a disposizione del sistema economico.
Il risparmio addizionale è subito distrutto, in quanto non si
traduce in nuovi investimenti produttivi, bensì in consumi. Giova
infine tener presente che nel tempo il rapporto tra il risparmio nazionale
lordo ed il reddito nazionale lordo disponibile è andato via
via diminuendo. Negli anni Sessanta ha oscillato intorno al 24%. Ma
negli anni Settanta è cominciato a discendere. Nel 1976 è
stato del 21%. Queste percentuali sono calcolate in base a grandezze
espresse in termini monetari. Ancora più grave è il loro
significato se si tenesse conto della loro portata reale. Comunque,
la parallela caduta degli investimenti è stata la naturale conseguenza
della riduzione, sia in termini assoluti che relativi, sia in termini
monetari che reali, del risparmio.
Questo dunque è il quadro della situazione. L'indebitamento pubblico
che ha le sue radici in una politica finanziaria spensierata crea inflazione.
Oggi, alla resa dei conti, si pensa di correggerla inasprendo solo il
carico tributario, magari mangiandosi il fieno in erba con un anticipo
d'imposte, senza porre mano ad una pure simbolica riduzione delle spese
correnti. L'inflazione sconvolge però il significato reale d'ogni
grandezza economica, e quindi, in definitiva, del modello keynesiano
valido in tempi di deflazione, che non sono certo quelli che caratterizzano
il funzionamento odierno del nostro sistema economico.
La discussione
sul disavanzo allargato della Pubblica Amministrazione prosegue con
carosello di cifre. Le cronache riferiscono sulle varie ipotesi. Ma
in tutto questo gran parlare e scrivere non sempre si presta adeguata
attenzione all'andamento delle entrate e delle uscite, che per l'appunto
danno luogo al disavanzo. Vale quindi !a pena di integrare le discussioni
con alcuni dati concernenti i totali delle entrate ed uscite, sia correnti
che in conto capitale. Giova sottolineare che questi dati registrano
flussi di cassa e non di competenza, in quanto risultano dai conti economici
consolidati dalla Pubblica Amministrazione. Ecco i dati espressi in
miliardi di lire correnti:
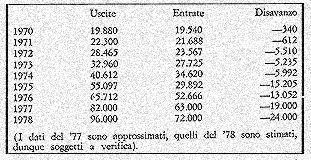
(I dati del
'77 sono approssimati, quelli del '78 sono stimati, dunque soggetti
a verifica).
Per interpretare il significato di questi dati occorre rifarsi al reddito
nazionale. Ma quale aggregato prendere in considerazione come termine
di confronto? Non certo il reddito nazionale lordo, vale a dire comprensivo
degli ammortamenti, come qualcuno è solito fare, se non altro
per dimostrare che nel nostro sistema economico la pressione tributaria
e paratributaria non è molto differente da quella in atto in
altri sistemi.
Ma a parte il fatto che da noi il reddito per abitante è assai
più basso di quello accertato altrove, per cui proporzionalmente
è più elevata la pressione, ritengo che il solo aggregato
valido per operare questo confronto è quello del reddito netto
al costo dei fattori, vale a dire della somma di redditi o remunerazioni
che effettivamente compensano le prestazioni dei vari fattori di produzione.
Ebbene, nel 1970 questo reddito nazionale netto era pari a 47.086 miliardi
di lire correnti, e nel '76 a 115.794 miliardi. Ciò significa
che tra questi due anni è aumentato come da 100 a 331, e le entrate
come da 100 a 270.
Per il '77 si può stimare un reddito nazionale netto pari a 137.000
miliardi di lire correnti, e per il '78 a 158.000 miliardi. Si constata
dunque un ulteriore sfasamento tra l'andamento del reddito e quello
della finanza pubblica, con ovvii effetti inflazionistici sia che si
riesca ad aumentare le entrate che a contenere le uscite.
Per quanto riguarda le entrate, si punta su un aumento della pressione
tributaria, nonostante che l'inflazione abbia già grandemente
appesantito aliquote assai progressive. Inoltre, si trascura, per quanto
riguarda le uscite, che i trasferimenti di reddito per finanziare aree
decisamente parassitarie sono in continuo aumento: per esempio, quelle
concernenti le pensioni di invalidità. I cultori della finanza
pubblica ritenevano ed in parte ancora ingenuamente ritengono che un
tributo è ottimo solo quando consente alla Pubblica Amministrazione
d'aumentare il reddito dei contribuenti, poiché il valore dei
beni e servigi forniti alla collettività è superiore a
quello dei tributi e contributi coattivamente prelevati. Ma se dà
di meno, come ormai concretamente si verifica nel nostro sistema economico,
il tributo non è più ottimo, bensì distrugge reddito.
Concludo ricordando che le entrate e le uscite su riportate riguardano
sia quelle correnti che in conto capitale. Orbene, mentre la percentuale
delle entrate in conto capitale sul totale delle entrate, del resto
scarsamente significativa, è rimasta su per giù uguale
nel tempo, quella delle uscite, assai significativa, è passata
dal 14% del '70 al 12% nel '76, con probabile ulteriore diminuzione
nel '78.
Inoltre, è bene ricordare che mentre per il finanziamento delle
uscite in conto capitale del '70 interveniva una certa quota di risparmio
pubblico positivo, ora questa quota del finanziamento ha dato luogo
a un ingente risparmio negativo, nel senso che le entrate globali neppure
hanno consentito di spesare le uscite correnti. Per una parte di queste
uscite si è dovuto ricorrere ai debiti.
L.D.P.
|