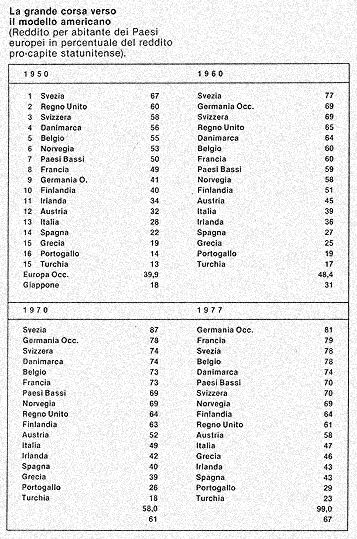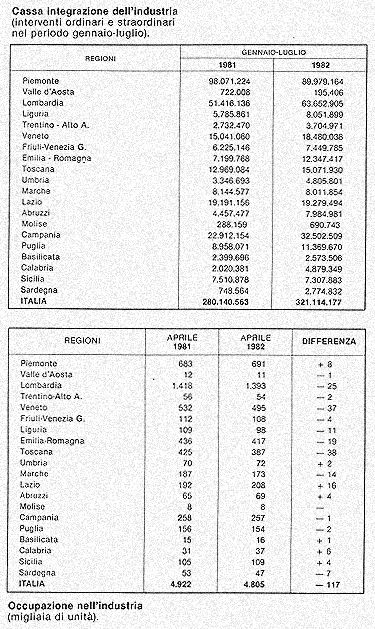|
Quando l'incertezza,
la confusione e quindi il disorientamento aumentano, è opportuno
fermarsi un momento a riflettere, almeno per capire ciò che é
andato e sta andando storto nell'economia mondiale. Ho detto economia
mondiale (e non solo economia italiana) perché la crisi economica
ha progressivamente contagiato gran parte dei Paesi dell'Ovest e dell'Est.
La stessa dinamica politica lo dimostra. Parecchi Paesi si spostano
o verso destra o verso sinistra senza essere poi in grado di mutare
la rotta della politica economica. Reagan, nonostante tutte le promesse,
non riesce a tagliare le spese sociali, per cui deve aumentare le tasse
che voleva diminuire. Olof Palme vince le elezioni, ma svaluta immediatamente
e inaugura una rigidissima politica dei redditi. Mitterand blocca prezzi
e salari. All'Est, niente di nuovo. La Jugoslavia e la Romania - per
non parlare della Polonia - adottano anch'esse drastiche misure di contenimento
di salari e di prezzi.
L'economia italiana é quella che sta peggio, almeno tra i Paesi
occidentali. Perché stia peggio è noto: un disavanzo pubblico
che nessuno controlla più, un'inflazione che ha ripreso il volo,
larghi buchi nei conti delle aziende autonome e delle imprese a partecipazione
statale. Ma ciò che più sconcerta è una situazione
sindacale da far rimpiangere persino i tempi in cui il sindacato impazzava,
e una situazione politica che ormai sembra aver dei tutto dimenticato
che i governi, centrali e locali, ci sono per prendere qualche decisione.
Perché l'economia mondiale sembra aver infilato un tunnel senza
via d'uscita? Per rispondere adeguatamente sarebbe necessario scrivere
parecchi volumi. Ci dobbiamo limitare a qualche spunto per la riflessione.
1) Vi è un grande cambiamento nel funzionamento dell'economia
mondiale che non ha ancora trovato una corrispondente risposta di politica
economica. Il processo di industrializzazione, e quindi di integrazione,
delle economie nazionali ha proceduto a ritmo serrato con effetti grandemente
positivi sul benessere economico dei vari Paesi. D'altro canto, l'integrazione
economica significa che ogni Paese è, molto più di prima,
soggetto a cambiamenti provenienti dall'esterno.
Se i giapponesi ti portano in casa gli orologi a metà prezzo,
la tua industria degli orologi deve fare qualcosa. Che cosa deve fare?
0 ristrutturarsi, per competere con i figli del Sol Levante, o sviluppare
produzioni diverse. Per fare questo, si richiedono un ampio investimento
e un'elevata mobilità delle risorse. Se queste due condizioni
mancano, i concorrenti vincono.
2) Inoltre, è del tutto evidente ormai che la politica economica
internazionale èuna politica più adatta, nonostante i
rapporti tra banche centrali e l'azione del Fondo Monetario Internazionale,
per i tempi degli Stati-Nazione (circondati da solide barriere doganali)
che per il tempo attuale in cui, nonostante l'insorgenza di protezionismi,
la direzione di marcia è quella delle libertà degli scambi.
Oggi, chi ha difficoltà nella bilancia dei pagamenti sceglie,
oppure è costretto a difendersi da solo, causando danni agli
altri Paesi che non possono non reagire.
Per evitare questi danni è evidente che occorre un certo grado
di concentrazione delle politiche economiche dei vari Paesi, almeno
in date aree, come l'Europa. Ma qui incontriamo il primo problema politico
irrisolto nonostante il cammino dell'economia. Cioé: l'economia
ha camminato più rapidamente della politica internazionale, e
oggi ne subiamo le conseguenze.
3) Vi è un altro problema aperto della politica economica contemporanea,
un problema che potrebbe interessare da vicino anche la questione delle
riforme istituzionali, di cui si parla oggi in Italia. i] mondo occidentale
esce dal secondo conflitto mondiale con un corpo di dottrina economica
- la dottrina keynesiana - che attribuisce all'azione illuminata dei
governi, attraverso la spesa pubblica, la capacità di influire
in modo positivo sul "sentiero" di crescita dei redditi e
dei l'occupazione, senza dover rinunciare, come invece era stato il
caso della Germania nazionalsocialista, alla democrazia.
Queste conclusioni erano basate su ipotesi politiche ben precise: in
primo luogo che, una volta individuate corrette linee di politica economica,
queste potessero essere isolate da "domande politiche" in
conflitto con la razionalità economica e difese poi dall'azione
corrosiva dei gruppi d'interesse.
Credo che non si debba insistere molto per provare che queste condizioni
"politiche" della dottrina keynesiana siano solo parzialmente
soddisfatte. La politica economica non è fatta dai "saggi"
di Harvey Road, come era nella concezione elitaria di Keynes, ma da
politici sicuramente in buona fede, ma impegnati in una lotta allo spasimo
per la rielezione: politici quindi - e gruppi di interesse - portati
a favorire progetti di spesa pubblica di breve periodo rispetto a quelli
di lungo periodo, e comunque tendenti a sottovalutare gli effetti di
lungo periodo delle decisioni di breve.
Come dice James Buchanan in Democray in Deficit, mettere il keynesismo
in questa struttura di decisione politica è piuttosto complicato,
ed è molto probabile che dal tritacarne escano disavanzi pubblici
e inflazione.
Ciò non vuoi dire che la democrazia non ammetta sviluppi, come
non vuoi dire che occorra abbracciare posizioni opposte. La signora
Thatcher che, con più costanza di altri, sta applicando dottrine
monetariste, sta ancora attendendo, nonostante i successi sull'inflazione,
una ripresa duratura e soprattutto quella riorganizzazione dell'industria
britannica che era e rimane l'obiettivo principale della sua azione.
Ciò che si vuoi dire è che sarebbe opportuno allungare
in qualche modo la vita del governi, per sganciare i politici da logiche
parziali e di breve periodo, e comunque troppo influenzate da gruppi
d'interesse e dalle burocrazie, private e pubbliche.
4) Vi è infine un punto che può anch'esso spiegare le
incertezze del cammino economico attuale. Il mondo sta vivendo una grande
rivoluzione tecnologica: la rivoluzione collegata all'uso dei microprocessori
e allo sviluppo dell'informatica. Questo grande cambiamento, che incomincia
a interessare anche l'Italia, porta con sé la complessa e grave
questione della disoccupazione, anche perché le nuove tecnologie
cominciano a diffondersi nel settore del servizi che, nel passato, ha
assorbito parte del lavoratori espulsi dall'agricoltura e dall'industria.
E' molto probabile che quella relazione diretta tra aumento della produzione
e aumento dell'occupazione, che era ritenuta in passato come certa e
sicura, non sia più valida.
Il grande economista Wassily Leontief ha osservato che, in queste condizioni,
se una economia deve funzionare senza estesi controlli sociali, il lavoro
non fatto dalle macchine deve essere "ripartito", come deve
essere ripartito il reddito. La storia, anche la storia recente, mostra
che le società hanno risposto a queste sfide attraverso la revisione
delle loro istituzioni economiche e del loro valori per giungere a un
uso efficiente della tecnologia e aumentare in tal modo il benessere
della comunità.
Nell'ardore e nel clamore della lotta politica, nell'incertezza che
oggi sovrasta il mondo, è difficile spingere lo sguardo lontano,
alla ricerca delle vere cause che turbano le odierne società
e l'economia mondiale. D'altra parte, è solo evitando di lasciarsi
travolgere dal contingente che i profondi cambiamenti in atto in campo
politico, economico e sociale potranno essere meglio capiti e dominati.
La domanda che ci si pone da più parti, è se avremo fra
non molto un crack che in qualche modo ricordi quello che determinò
il grande crollo di Wall Street, nel 1929. In altre parole: è
da tre anni che due spettri aleggiano sull'umanità, e sono quelli
della guerra mondiale e della grande crisi. Una guerra, che non si fermi
al livello "regionale" (e di guerre del genere ce ne sono
parecchie in corso) e che coinvolga i due massimi contendenti planetari,
segnerebbe con ogni probabilità la fine di tutte le civiltà
sulla terra. Una grande depressione che colpisse l'Europa, finirebbe
con l'estendersi rapidamente al Terzo e al Quarto Mondo, coinvolgerebbe
l'America e trascinerebbe con sé anche i sistemi economici dell'Est.
In un caso o nell'altro, si tratterebbe, secondo Galbraith, di una strada
"che incomincia davanti a un cimitero e finisce nel fiume".
Segni di nervosismo ci sono, e il pericolo di una guerra planetaria
non si deve considerare mai del tutto scongiurato. La grande diplomazia
è sempre al lavoro, e con alterne vicende le "ritirate"
riguardano ora l'uno, ora l'altro dei due blocchi. Se salterà
questo delicato equilibrio, se la "ritirata" di uno solo dei
due blocchi sarà costretto a superare la longitudine vitale,
qualcuno "premerà il bottone", e ne saremo tutti coinvolti.
In un contesto così complesso, politica ed economia sono un tutt'uno,
si determinano vicendevolmente e vicendevolmente si condizionano all'interno
di ciascun blocco e nei confronti dell'altro blocco. Ecco perché
è importante la risposta alla domanda: siamo alle soglie di un
altro '29?
Sarebbe errato chiederci se quello che successe al Wall Street nell'ottobre
1929 può ripetersi, con crolli delle quotazioni azionarie paragonabili
a quelli di poco più di mezzo secolo fa. Perché la risposta
sarebbe sì, il grande crack di borsa potrebbe ripetersi, anche
se le probabilità sono molto minori, perché oggi ci sono
limiti precisi alle operazioni allo scoperto, mentre nel '29 non c'erano
limiti del genere, e gli speculatori giocavano in borsa con denaro preso
a prestito. A quell'epoca, le voci più assurde e improbabili
trovavano credito, mentre oggi questo non avviene più. Abbiamo
norme che, in qualche misura, impediscono la manipolazione del mercato.
Ma quando i prezzi salgono rapidamente, possono precipitare ancor più
velocemente. Ora, Marx ha affermato che la storia si ripete, la prima
volta in chiave di farsa, la seconda in chiave di tragedia. La storia
economica non si ripete secondo questa regola. Vediamo quali furono
i problemi che determinarono la grande depressione, nel periodo fra
il 1929 e il 1931. Prima di tutto, il sistema bancario si trovò
con una massa di crediti inesigibili, che provocarono il fallimento
di migliaia di banche. Come stanno le cose ora? Le maggiori banche di
New York, di Chicago, di Londra, di Francoforte, hanno in essere ingenti
prestiti concessi a Paesi stranieri. Quattro o cinque anni fa ero molto
preoccupato per la circostanza che non conoscevamo l'esatto ammontare
di queste esposizioni, né sapevamo quale fosse la capacità
di rimborso dei Paesi debitori. Diverse grandi banche erano sulla lista
nera degli organi di vigilanza, per via dei prestiti concessi a nazioni
in difficoltà, come la Turchia, lo Zaire, il Perù. La
mia impressione è che oggi (malgrado la dichiarata insolvenza
del Messico, che pure è un campanello d'allarme) la situazione
è molto migliore di quanto non fosse cinque o sei anni fa. In
parte, ciò è dovuto al fatto che l'inflazione favorisce
molti cattivi debitori. Ma questo non significa che il problema sia
risolto. Al contrario, le esposizioni delle banche sul mercato dell'eurodollaro,
privo di ogni controllo ufficiale, rappresentano un grosso pericolo.
Insomma, quelle che è avvenuto alla Franklin National Bank (grazie
anche alla gestione di Michele Sindona), potrebbe succedere alla Chase,
o alla First National of Chicago, e le ripercussioni potrebbero essere
ancora più serie di quelle provocate dai quasi-fallimenti della
Lockheed, della Crysler, o dalla bancarotta della Penn Centrai.
La grossa differenza, la vera differenza della quale gli storici dell'economia
debbono tenere conto, è che nel periodo fra il 1929 e il 1935
si viveva nel mondo dell'ortodossia, le regole erano assolutamente vincolanti,
non solo ai fini dell'azione, ma anche a quelli del pensiero. Nessuno
si sarebbe sognato, mentre negli Stati Uniti ottomila banche stavano
fallendo, di mettere sotto pressione la tipografia della Zecca e, stampando
danaro, salvare così le banche con un atto dello Stato.
Se andiamo a rileggerci i documenti dell'epoca, gli articoli di giornale,
le minute delle riunioni segrete dei responsabili della Banca Centrale,
vediamo che tutti davano per scontato l'obbligo di mantenere un rapporto
costante fra le riserve monetarie e il circolante. E questa religione
continuò a prevalere fino all'avvento di Adolf Hitler. Il quale,
per ignoranza o per astuzia, cambiò completamente le regole del
gioco.
Oggi non si potrebbe più verificare, come si verificò
allora, una corsa al ritiro dei risparmi dalle banche, con conseguente
fallimento a catena degli Istituti di Credito, soltanto perché
i governi, per motivi costituzionali, non possono attivare la rotativa
delle banconote. Le moderne democrazie che prevalgono nel mondo Occidentale,
(anche nei Paesi monetariamente più ortodossi, come la Svezia
o la Germania Occidentale), non consentirebbero l'innesto di un processo
deflazionistico, di un circolo vizioso provocato dalla paura. Un circolo
vizioso che può essere interrotto mediante la creazione di carta
moneta.
Si dirà: la grande depressione iniziò poco più
di cinquant'anni fa con il crollo della borsa; oggi, il mercato delle
valute e quello dell'oro sono in ebollizione. Che cosa significa?
Ecco: l'interpretazione più diffusa del fenomeno dice che il
mercato dell'oro, e ora anche quello dell'argento, quest'ultimo dopo
alterne vicende, sono segnali d'allarme, indicazioni che il sistema
monetario non funziona, così come è strutturato. Personalmente,
però, sono convinto che l'oro non ha alcun potere monetario.
Mi spiego. Prendiamo il mercato dei semi di sola. E un mercato di produzione
e di consumo, nel quale il margine della speculazione è definito
dalla previsione di un divario fra i livelli della domanda e dell'offerta.
I prezzi, insomma, possono oscillare, e anche in misura sensibile, ma
sempre intorno al prezzo reale della merce, verso il quale tendono in
ogni caso. Per l'oro, invece, il discorso èdiverso. Gli impieghi
industriali di questo metallo, ossia il consumo, sono assolutamente
secondari. Non esiste, quindi, un prezzo di parità al quale si
possa fare riferimento. Per cui il mercato - che è estremamente
ristretto - è in balia della speculazione. Ricordiamoci che De
Gaulle e la sua convinzione che l'oro potesse tornare alla base del
sistema monetario internazionale sono morti e sepolti, da un pezzo".
Joan Robinson, unica donna nell'olimpo degli economisti, professore
emerito di economia a Cambridge, è considerata l'erede naturale
di Keynes, anche se nei confronti del maestro ha sviluppato una critica
serrata, nel tentativo di far coincidere keynesismo e marxismo. Ecco
quanto ci ha detto: "Keynes credeva nella possibilità di
un capitalismo riformato, con la piena occupazione e senza più
povertà. Era convinto che una più equa distribuzione del
reddito avrebbe portato i consumi a un livello tale da garantire quasi
li pieno impiego, senza bisogno di troppi investimenti. Il che è
certamente vero per le popolazioni del Terzo e forse anche per quelle
del Quarto Mondo, che se avessero di che mangiare a sufficienza, acquisterebbero
più prodotti dell'industria locale. Nei Paesi sviluppati, per
contro, se la pubblicità smettesse di creare falsi bisogni, la
gente finirebbe per preferire allo shopping la cultura e il tempo libero.
Ma per raggiungere obiettivi così ambiziosi, Keynes pensava bastasse
spiegare ai cittadini come comportarsi in modo razionale, e questi avrebbero
agito di conseguenza. Galbraith commette più o meno lo stesso
errore, quando sostiene che una pubblica opinione qualificata può
convincere i grandi gruppi industriali a seguire politiche più
illuminate. Mentre invece avviene il contrario: sono i detentori del
potere economico a influenzare il pubblico e a sostenere quei governi
che non mettono in pericolo i I loro potere. Ci vuoi altro per cambiare
veramente le cose, è necessaria una grande svolta politica, che
non può certo essere indolore. Questo Keynes non l'aveva capito.
Kalecki, che pure sul piano teorico era giunto alle stesse conclusioni,
non era ottimista come lui. Ma Kalecki aveva un retroterra marxista.
Legittima obiezione: Marx prevedeva la fine del capitalismo, escludeva
quindi la possibilità di riformarlo. Bene: fra Marx e Keynes
non c'è incompatibilità. Si potrebbe anzi dire che il
primo ha gettato le fondamenta, il secondo ha curato le rifiniture.
Comunque é chiaro che anche il pensiero di Marx va rivisto. Ha
più di cento anni, e nel frattempo tante cose sono cambiate.
Per esempio, Marx non aveva previsto l'enorme forza d'urto del nazionalismo
che si sarebbe scatenata negli anni '30. Aveva previsto la caduta dei
saggi di profitto, e questa c'è stata. Ma aveva anche pronosticato
la diminuzione dei salari, e invece questi sono cresciuti realmente
nella maggior parte dei Paesi industrializzati. Il sistema si è
evoluto in direzioni diverse da quelle che Marx si aspettava. ]n sostanza,
la versione complessiva che egli ci ha dato di come il capitalismo opera
è giusta: ma molti dettagli sono sbagliati. Ed è su questi
che Keynes ha lavorato. Ecco perché il capitalismo ha un futuro,
anche se molto travagliato. D'altro canto, le economie di tipo sovietico
hanno i loro problemi, anche gravissimi. I grandi miti della sinistra
europea stanno cadendo ad uno ad uno. Non è più possibile
essere socialisti nel modo idealistico in cui lo si era un tempo. Ma
io credo che, al di là di tutto, il rischio peggiore che abbiamo
di fronte è questa sfrenata corsa agli armamenti, che minaccia
di portarci alla guerra nucleare. E' un pericolo spaventoso. La più
grossa tempesta monetaria, al confronto, è una cosa da nulla".
Caposcuola dei "ragazzi di Chicago", economisti liberisti
che rifiutano la teoria keynesiana e ritengono necessario ridare alla
libera iniziativa e al mercato il controllo dell'economia, il premio
Nobel Milton Friedman insegna all'Università Stanford, in California.
Gli abbiamo chiesto quale rimedio consiglierebbe per l'economia mondiale
se ci si dovesse trovare di fronte a un'altra depressione come quella
del '29. "Non credo che, nelle condizioni attuali e prevedibili
per il futuro, si possa ragionevolmente profetizzare un'altra grande
depressione come quella del 1929-33. La caratteristica principale di
quell'evento storico fu, particolarmente negli Stati Uniti, la deflazione
monetaria. Oggi, il problema dominante è quello opposto, l'inflazione.
Dalla grande depressione ad oggi, sono intervenuti mutamenti fondamentali
nelle istituzioni e nei modi di pensare. E non solo negli Stati Uniti.
I mutamenti nelle strutture degli Istituti di Credito e del sistema
bancario, e nel sistema fiscale, hanno modificato sostanzialmente le
reazioni cicliche dell'economia occidentale. E i cambiamenti avuti nell'atteggiamento
del pubblico nei confronti dell'inflazione e della deflazione hanno
modificato completamente le reazioni a livello politico ai mutamenti
economici. A mio parere, gli effetti complessivi di queste alterazioni
delle istituzioni e dei modi di pensare fanno sì che una depressione
di notevole gravità, ossia paragonabile a quella cominciata nel
1929, sia oggi inconcepibile.
La depressione che iniziò verso la metà di quell'anno
fu una catastrofe di dimensioni senza precedenti per gli Stati Uniti,
e poi anche per il resto del mondo. Nel 1933, il reddito monetario della
nazione americana era dimezzato, il prodotto totale si era ridotto di
un terzo e un lavoratore potenziale su quattro era disoccupato. Ma fu
anche una immane catastrofe per il mondo. Il diffondersi della depressione
ad altri Paesi causò diminuzione della produzione, lievitazioni
della disoccupazione, fame e miseria dappertutto. In Germania, la depressione
contribuì all'ascesa al potere di Hitler, preparando così
lo scoppio della seconda guerra mondiale. In Giappone, rafforzò
il già notevole potere dei circoli militaristici che sognavano
di creare la "sfera di co-prosperità della grande Asia Orientale".
In Cina, le conseguenza della depressione distrussero il sistema monetario,
indebolirono il governo nazionalista impegnato nella lotta contro i
giapponesi e, successivamente, contro i comunisti, e crearono le premesse
dell'iperinflazione che segnò il destino di Chang Kaishek e l'avvento
al potere di Mao Tse-tung.
Le conseguenze della grande depressione furono, quindi, di ordine politico,
ma anche filosofico e sociale. Ad esempio, il crollo convinse moltissimi
cittadini, negli USA e altrove, che Carlo Marx aveva ragione nel condannare
il capitalismo, giudicandolo un sistema fondamentalmente instabile e
suscettibile di provocare crisi anche più gravi. Convertì
il pubblico all'opinione, che in precedenza aveva avuto corso crescente
fra gli intellettuali, che il governo dovesse svolgere un ruolo più
attivo nell'economia, che dovesse intervenire attivamente per controbilanciare
l'instabilità provocata dall'iniziativa privata e che dovesse,
insomma, diventare un elemento equilibratore, promuovendo la stabilità
e garantendo la sicurezza economica dei cittadini. Questo mutamento
nella percezione che il pubblico aveva del ruolo del mercato, da una
parte, e dei governi, dall'altra, fu un importante catalizzatore della
rapida crescita degli apparati governativi, e in particolare di quelli
centralizzati, negli ultimi cinquant'anni.
La depressione provocò anche un drastico giro di boa nel pensiero
economico. Distrusse, infatti, la convinzione della maggior parte degli
economisti, che si era rafforzata negli anni '20, che la politica monetaria
fosse un potente strumento di promozione della stabilità economica.
Quello che avvenne fra il 1929 e il 1933 convinse molti della erroneità
di questo convincimento e spinse alcuni all'estremo opposto, e cioé
all'affermazione che "la moneta non conta". Per riempire il
vuoto lasciato dall'apparente collasso della teoria prevalente fino
ad allora, il più brillante economista di questo secolo, Keynes,
offrì la teoria alternativa, lanciando la rivoluzione keynesiana,
che non solo conquistò gran parte degli economisti, ma fornì
una diagnosi e una terapia che giustificavano massicci interventi governativi
nell'economia.
Quella grande depressione non fu la conseguenza del fallimento dell'iniziativa
privata, ma dei pubblici poteri. E il fallimento si ebbe in una sfera,
quella della "coniazione della moneta, della sua regolamentazione
e della sua valutazione in moneta straniera", la cui responsabilità
era stata affidata ai pubblici poteri molto tempo prima. Il Federal
Reserve System, che all'epoca era la massima autorità monetaria
americana, impose all'economia un onere schiacciante. H suo comportamento
determinò o facilitò il declino della quantità
di moneta, nella misura di un terzo, fra il '29 e il '33. Creato nel
1913 a seguito di una crisi precedente, quella del 1907, proprio allo
scopo di impedire il ripetersi di eventi del genere, stette a guardare
senza far nulla, mentre un terzo delle banche commerciali americane
andava in fallimento. Il Federal Reserve Board non seppe far nulla per
fermare un'ondata di panico finanziario molto più vasta e disastrosa
di quelle che l'avevano preceduta nella storia, e finì per soccombere
alla propria inettitudine, chiudendo i battenti per un'intera settimana,
durante la cosiddetta "vacanza bancaria" del 1933. Dal punto
di vista scientifico, sappiamo oggi che la depressione, lungi dal dimostrare
che "la moneta non conta", offrì invece una tragica
testimonianza dell'importanza della moneta. Ovviamente, molti altri
fattori, oltre alla politica monetaria, influirono sul corso della depressione,
e contribuirono a spiegarne la gravità e la durata. Ma è
letteralmente inconcepibile che la depressione possa essere durata tanto
a lungo o abbia raggiunto la gravità che raggiunse, se la Banca
Centrale avesse agito tempestivamente per evitare il declino della quantità
di moneta. Oggi un fatto del genere non può verificarsi più,
a meno che non prevalga la cecità più assoluta".
Il canadese John K. Galbraith è lo storico ufficiale del grande
crollo del '29. Questo il quadro che ne fa: "Ci sono giorni, che
vengono riconosciuti dalla storia, dopo i quali cambia tutto. li 7 dicembre
1941 fu uno di questi giorni. E probabilmente lo fu anche l'11 novembre
1918, quando, in tutto il mondo, gli uomini si resero conto con grande
sorpresa che il massacro della prima guerra mondiale era veramente finito.
Un caso analogo è quello del giorni dell'agosto 1945, quando
caddero le bombe e cominciò l'era nucleare. Ma ci volle tempo
prima che l'importanza di quell'evento venisse realizzata e di conseguenza
nessuno ricorda le date precise.
In questo contesto, il 24 ottobre 1929 ha un suo posto importante nella
storia. Questa data, il giorno del grande crak di Wall Street, rimane
nella memoria della società anche dopo! che sono passati più
di cinquant'anni, e per buoni motivi. Dopo quel giorno, la vita, per
milioni di persone non fu più la stessa.
Prima di quel "giovedì nero" d'ottobre, quegli americani
intelligenti e di buone maniere le cui opinioni si ritenevano riflettessero
l'opinione del pubblico erano, secondo il consenso generale, una razza
ottimista, fiduciosa anche nella competenza e nell'onestà degli
uomini che gestivano i grandi affari finanziari e industriali. Questi
americani avevano pochi dubbi circa l'efficacia generale e l'affidabilità
del sistemo economico in cui operavano. Molti vedevano, nella loro crescente
ricchezza, la prova che questo sistema premiava i migliori. Ma questi
americani non saranno mai più così liberi dal dubbio dopo
gli eventi dell'ottobre '29.
Per milioni di operai, contadini, mezzadri e piccoli commercianti la
devastazione di quei giorni d'ottobre fu un'eco distante. Non potevano
supporre che le loro vite sarebbero state influenzate da quello che
succedeva a Wall Street. Si sbagliavano, e di molto. Nel giro di qualche
mese, e per molti nel giro di settimane, gli eventi di New York si sarebbero
tradotti in eliminazione di posti di lavoro, riduzioni dei prezzi, chiusure
di banche e cancellazione di ipoteche. Le conseguenze dell'attacco di
Pearl Harbour sulle vite degli americani furono più visibili
e più eroiche. Nel complesso, però, non furono più
dolorose. Per molti americani, la guerra significò la comparsa
di posti di lavoro inaspettati, responsabilità, movimento e pochissimi
pericoli. Non sono molti, invece, coloro che ricordano con piacere la
depressione.
Il giorno del crak a New York fu un giorno interessante, così
come interessanti furono quelli che lo seguirono, quando le cose peggiorarono.
Ma, come sempre, lo storico deve essere cauto per non attribuire troppa
importanza al momento culminante.
C'è sempre la tentazione di attribuire al grande dramma della
data storica un'importanza che appartiene invece ai momenti antecedenti.
L'attacco a Pearl Harbour non fu più importante della decisione
giapponese di inviare le portaerei dalle quali sarebbe partito, o delle
correnti politiche ed economiche, eventi fortuiti e disastri che porteranno
al potere, in quelle isole così civili, uomini capaci di aberrazioni
militari e politiche così macroscopiche. Il crack del '29 fu
reso inevitabile dalla pazzesca speculazione che lo precedette. Quella
deviazione dalle regole della ragione supera ovviamente in importanza
gli eventi che si verificarono nel giorno famoso. E dietro il boom speculativo
c'erano le forze - economiche, culturali, psicologiche e politiche -
che rendevano suscettibili gli americani. Non si può utilmente
analizzare il crack se l'analisi non si estende a quel che accadde prima.
Questa ricerca delle cause più profonde e più generali
non esclude di per sè gli effetti sull'economia del collasso
del mercato azionario. E' stato detto che già nei primi mesi
del '29 l'economia, reagendo ai propri imperativi ciclici, aveva cominciato
a indebolirsi. Il crack fu semplicemente la risposta a questa realtà
più profonda. Era errato, addirittura antiscientifico, attribuire
conseguenze più ampie a qualcosa così intrinsecamente
superficiale come qualche giorno di panico a Wall Street. Contemporaneamente,
i banchieri di Wall Street, i brokers e le ditte d'investimento non
avevano certo interesse a sottolineare il ruolo che avevano avuto. Per
quanto li concerne, non hanno nulla in contrario a che la colpa della
successiva tragedia economica venga attribuita ad altri.
Spesso, quando cercano di essere profondi, gli economisti riescono soltanto
a sbagliare. Non può esserci infatti alcun serio dubbio che il
collasso del valore dei titoli, il collasso delle fortune di coloro
che giocavano in borsa, l'immediato effetto sugli investimenti e sui
consumi, e l'effetto soltanto leggermente più remoto sulle prospettive
dell'attività economica e degli investimenti ebbero un'influenza
traumatica sulla produzione, sul reddito e su I l'occupazione. Sui prezzi
delle materie prime e su importanti categorie di consumi privati, in
particolare quella del prodotti di lusso, l'effetto fu già visibile
prima della fine dell'anno. Nella più ampia prospettiva storica,
l'importanza del boom e del crack è stata più generalmente
accettata.
Forse di questo dovremmo compiacerci. C'è una certa soddisfazione
nel sapere che un evento che tanto concentrò l'attenzione del
mondo finanziario non fu senza effetti economici più profondi.
Banchieri, brokers e uomini il cui genio finanziario è variamente
definito, amano essere considerati importanti, anche se -in questo caso
- la loro importanza è dovuta al fatto che persero il senno.
La storia non ha bisogno di essere difesa: la sua forza è la
sua realtà. Ma ho pensato che fosse importante tenere viva la
memoria di quello che successe nel 1929 e negli anni successivi. Perchè
nè le regolamentazioni pubbliche, nè il migliore livello
morale dei promotori societari, brokers, venditori di titoli, operatori
del mercato, banchieri e gestori di fondi d'investimento possono evitare
queste ricorrenti epidemie speculative e le loro conseguenze. La prevenzione
è affidata alla memoria delle illusioni passate, e al risveglio
da queste illusioni".
Al contrario di quanto sosteneva Keynes, secondo Rostow "il lungo
andare ci accompagna per ogni giorno della nostra vita". Il secondo
dopoguerra è ormai sufficientemente lungo per poter essere visto
in prospettiva storica. Sentiamo, anche a livello di esperienza epidermica
quotidiana, che moltissime cose sono cambiate nello spazio di una generazione.
Ma non sempre siamo in grado di misurare i mutamenti assoluti e relativi
avvenuti durante quest'arco di tempo. Un modo probabilmente tedioso
ma forse non inutile di cominciare a ripercorrere all'indietro il cammino
che ci ha portato al punto cui oggi siamo giunti, è quello di
cercare di misurare la nostra ricchezza relativa e i suoi mutamenti.
Esercizi apparentemente semplici, come il confronto internazionale di
misure, quali il reddito nazionale, implicano una serie di difficoltà
logiche, sulle quali sarebbe troppo lungo soffermarsi. L'uso dei tassi
di cambio di mercato tra le varie monete produce, ad esempio, una distorsione
che è difficile valutare. Uno dei metodi alternativi di affrontare
il problema consiste nell'immaginare un ipotetico consumatore medio
del Paese più ricco (gli Stati Uniti) e di chiedersi quanti beni
e servizi potrebbe acquistare se disponesse del reddito medio di un
abitante del Paese che si vuole confrontare, qualora i prezzi relativi
restassero quelli degli USA.
Anche in questo caso la misura è "distorta", (tipicamente,
si tende a sopravalutare il reddito del Paesi più poveri), ma,
almeno, la distorsione è controllabile e conosciuta. Un gruppo
di ricercatori guidato da Kravis compie da anni esercizi di misurazione
con tale metodo per conto dell'ufficio statistico delle Nazioni Unite.
Assumendo che questo sia il modo accettabile per confrontare il reddito
pro-capite di vari Paesi, vediamo come sono mutate, tra il 1950 e il
1977, le posizioni relative rispetto a questa importante variabile che
indica sostanzialmente il livello dello sviluppo economico.
In questo arco di tempo, il reddito per abitante degli USA è
cresciuto del 2,1% l'anno, (tutti i dati che forniamo sono espressi
in termini reali, come dicono gli economisti: tendono, cioè,
a misurare le quantità, indipendentemente da variazioni di prezzi).
Una crescita del genere implica quasi un raddoppio del benessere dell'americano
medio durante i 27 anni considerati, (supposto, ovviamente, che il benessere
dipenda solo dai beni e servizi di cui si dispone, cosa di cui si può
certo discutere all'infinito e senza trovare una risposta). L'Europa
Occidentale (inclusa l'area mediterranea) aveva nel '50 e nel '77, un
reddito per abitante corrispondente, rispettivamente, al 40 e al 59%
di quello americano. Va detto, tuttavia, che la "rincorsa"
dei Vecchio Continente rispetto ai più ricchi cugini d'oltre
Atlantico si è verificata quasi tutta tra il '50 e il '70, con
una crescita media annua del 3,9%. Nei seguenti anni di crisi, invece,
lo sviluppo europeo - calcolato sempre partendo dai dati Kravis - non
si discosta significativamente da quello americano. L'Europa rallenta,
mentre gli Stati Uniti mantengono su per giù il loro tasso di
crescita secolare. Uno sviluppo di lungo periodo attorno al 2% annuo
costituisce non solo una "performance" tutt'altro che trascurabile
in prospettiva storica (in tal modo i nostri figli sarebbero due volte
più ricchi di noi), ma probabilmente il massimo che possiamo
attenderci, se tutto va bene, per i prossimi anni. La brillante eccezione
è costituita dal ventennio 1950-70. Parallelamente alla "rincorsa"
operata dagli europei nel loro complesso, si sono verificati alcuni
mutamenti nelle posizioni relative di alcuni Paesi dei continente. Vediamo
i più rilevanti.
Il Regno Unito, fucina della prima industrializzazione, figurava nel
1950 al secondo posto in Europa, con un reddito per abitante pari al
60% di quello statunitense; nel '60 era passato al quarto posto (65%),
nel '70 al nono (64%) e nel '77 al decimo (61%). Dunque, tra il '60
e il '77 lo sviluppo delle Isole Britanniche è stato più
lento di quello americano.
Sul lato opposto si collocano i casi della Germania Federale e della
Francia. La prima occupava nel '50 il nono posto (con un reddito per
abitante pari al 41% di quello USA), ma già dieci anni dopo seguiva
la Svezia come Paese più ricco d'Europa. Nel '77, la Germania,
che durante gli anni di "crisi" mostra una delle migliori
capacità mondiali di adattamento, finisce con l'avere il reddito
per abitante più elevato del continente (81% di quello USA).
La "rincorsa" della Francia inizia più tardi, ma produce
esiti altrettanto brillanti e forse più sorprendenti, essendo,
nel '77 e sempre secondo i dati Kravis, il secondo Paese europeo dal
punto di vista del reddito per abitante.
La lega del Paesi più poveri resta composta, lungo tutto il periodo
considerato, da Spagna, Grecia, Portogallo e Turchia. L'Irlanda segue
la Gran Bretagna nel declino relativo e raggiunge nel '77 i meno ricchi,
con un reddito pro-capite pari a quello della Spagna. Ottima, invece,
in questo gruppo, la rimonta della Grecia che passa, tra il '50 e il
'77, dal 19 al 43% dei reddito americano: ma qui, forse, il gioco del
prezzi relativi ha un pò truccato i dadi.
E l'Italia? In prospettiva di lungo periodo c'è forse motivo
per ridimensionare alquanto il "miracolo" di buona memoria.
La posizione relativa del nostro Paese nella classifica economica europea
resta, in questi anni e secondo questi calcoli, piuttosto stabile, malgrado
il fatto che il suo reddito per abitante passi dal 28 al 47% di quello
statunitense. Negli anni '50 l'Italia si sviluppa a un tasso sensibilmente
superiore a quello del gruppo del più- poveri. Ma dopo l'inizio
del decennio successivo, Spagna e Grecia compiono una "rincorsa"
sostenuta, mentre la crescita italiana subisce un relativo rallentamento,
cosicchè, nel '77, i tre Paesi mediterranei non presentano il
divario nel livello di sviluppo che esisteva nel '60. Tra il '70 e il
'77, secondo questi conti, il reddito italiano medio è diminuito
relativamente, seppure di poco, rispetto a quello americano.
Nel complesso, a parte il declino relativo del Regno Unito e l'emergere
della Germania Federale negli anni '50 e della Francia nel decennio
successivo, la posizione dei vari Paesi nella "classifica"
del benessere medio del loro abitanti èrimasta abbastanza invariata
sia durante il ventennio della "rincorsa" dell'intero continente
rispetto al Nordamerica, sia nei successivi anni di sostanziale allineamento
del tassi di crescita delle due aree.
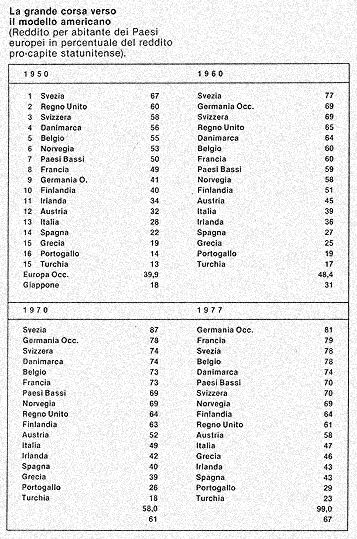
In prospettiva di
lungo periodo, dunque, gli effetti del "boom" economici vanno
forse un poco ridimensionati, (con l'eccezione probabile dei caso giapponese,
che ha visto un reddito pro-capite passato dal 18 al 67% di quello statunitense
durante il periodo che abbiamo considerato). Il lungo andare è
ancora più lungo dello spazio di un'intera generazione. I risultati
ottenuti in duecento anni di "sviluppo economico moderno"
non si sovvertono facilmente nel giro di venti o trent'anni. Lo stesso
Regno Unito, che secondo l'opinione di molti studiosi è in relativo
declino da oltre un secolo, ha ancora un reddito per abitante superiore
di un terzo rispetto a quello dell'Italia "del miracolo".
Passiamo al caso Italia. Quattro cartelle zeppe di cifre, proiezioni,
analisi elaborate dal Ministero del Lavoro, portano a una conclusione:
nel 1983 l'Italia sfiorerà i tre milioni di disoccupati, un record
senza precedenti, una soglia mai toccata, neppure negli anni più
difficili del dopoguerra. Negli ultimi mesi dell'82, gli iscritti alle
liste di collocamento erano poco più di due milioni e 300 mila,
e i cassintegrati circa 350 mila. Tra l'autunno e l'inverno, con la
crescita zero prevista dagli esperti, sono andati in fumo altri 300
mila posti di lavoro. I guai sono incominciati con l'autunno. Da settembre,
infatti, anche l'ultimo pilastro dell'industria italiana ha fatto sentire
sinistri cedimenti: fallimenti, licenziamenti, cassa integrazione hanno
investito le piccole e medie imprese. E' andato in crisi quel tessuto
industriale sul quale, negli anni scorsi, politici ed economisti si
erano esercitati, assicurando che le fortune del Paese, più che
dalla grande industria, dipendevano dall'originale e creativa attività
delle piccole e medie aziende. Piccolo è bello, si diceva. E
oggi, a Nord e a Sud, anche i piccoli e i medi non sanno più
a che santo votarsi.
Che l'occupazione nell'industria fosse in pericolo, si sapeva da tempo.
Dall'autunno '80, da quando il mondo produttivo è entrato in
recessione, le grandi italiane hanno tentato in tutti i modi di espellere
manodopera. Ma alla fine, i conti in un modo o nell'altro sono sempre
tornati, perchè tenevano le piccole e medie aziende, che da sole
danno lavoro al 75% degli addetti all'industria Poi, questo precario
equilibrio si è spezzato. I meccanismi di compensazione non hanno
funzionato più.
Tutto è incominciato con la crisi dell'auto. L'esplosione della
cassa integrazione alla Fiat e all'Alfa Romeo ha progressivamente messo
in ginocchio le piccole e medie imprese collegate. Nell'estate 1981
in Piemonte le imprese in cassa integrazione erano 167, oggi sono circa
450. In Lombardia, in un anno, il numero delle imprese che hanno fatto
ricorso alla cassa integrazione è triplicato. Di esse, una buona
metà hanno meno di 100 dipendenti e il 42% non supera i 500 addetti.
Subito dopo l'automobile è stato il turno delle grandi imprese
di elettrodomestici. Aziende come Indesit, Emerson, Voxson si sono trovate
sull'orlo del baratro e hanno evitato la chiusura solo perchè
hanno sospeso a zero ore quasi tutti i lavoratori. Anche in questo caso,
i contraccolpi per le piccole imprese subfornitrici sono stati pesanti.
Soprattutto in Brianza, nell'area torinese e a Caserta, una delle poche
provincie della Campania a non avere avuto finora grossi problemi.
Poi è toccato alla siderurgia. Cassa integrazione di massa all'Italsider,
sospensione e licenziamenti alla Falck, crisi alla Breda e agli altri
impianti del gruppo Finsider, con effetti a cascata sull'intero settore.
Persino i "tondinari" di Brescia, usciti sempre indenni dalle
periodiche crisi di mercato, hanno problemi di non poco conto, dagli
stabilimenti del "re del tondino", Lucchini, alla più
piccola ferriera. Medie imprese tradizionalmente solide come la Caleotto
di Lecco (300 addetti), o la Pietra di Brescia (1.200 dipendenti), rischiano
di chiudere i battenti. A Sud, in cassa integrazione i seimila di Bagnoli:
e sono restati senza lavoro i 14 mila lavoratori dell'indotto. Lo stesso
discorso vale per l'Italsider di Piombino, dove il dilagare della cassa
integrazione ha messo in crisi i tremila lavoratori delle imprese che
ruotano intorno all'acciaieria.
L'onda lunga della recessione ha investito anche le ultime isole felici,
le piccole e medie imprese autonome. Quelle, cioè, che, avendo
un mercato e un prodotto proprio, non dipendono dalle commesse della
grande industria. I primi segnali negativi erano venuti all'inizio dei
1982. Il protrarsi della stretta creditizia, la caduta del salari per
effetto della cassa integrazione e lo stillicidio del licenziamenti
avevano provocato una drastica contrazione del consumi interni. Ma inizialmente
i piccoli imprenditori autonomi erano riusciti a limitare i danni, forzando
le esportazioni, tanto che nei primi sei mesi dell'82 le vendite all'estero
erano aumentate del 30%. La batosta è arrivata a settembre, anche
nelle aree più forti della piccola e media impresa, come Veneto,
Emilia, Toscana, Marche.
Il più colpito è il settore meccanico, dalla Riello alla
Galileo, alla Benelli di Calenzano, alla Piaggio. Sono le cifre a dirlo:
su 321 milioni di ore complessive di cassa integrazione pagate dall'Inps
nel 1982 in tutta Italia, il 55% riguarda proprio l'industria meccanica.
Clamoroso anche il crollo del settore del legno e del mobilio, mentre
tira ancora, ma a costo di preoccupanti licenziamenti, quello tessile
e dell'abbigliamento. Per i licenziamenti in questo campo, imputate
le job killers, le macchine che uccidono posti di lavoro, come le chiamano
i sindacalisti inglesi. Innovazioni tecnologiche che l'industria italiana
è decisa a introdurre a tappe forzate, per non regredire al livello
dei Terzo Mondo. Ma nel brevissimo periodo, il nuovo assetto produttivo
quasi certamente renderà molto difficile il riassorbimento della
cassa integrazione.
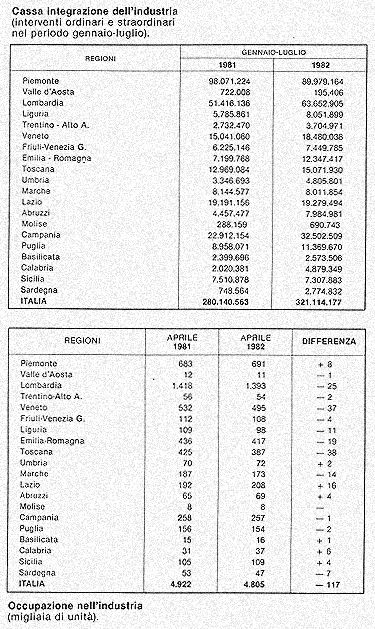
Le cifre del disastro italiano sono impietose. Il disavanzo pubblico
per l'82 è stato calcolato in 75 mila miliardi di lire, ma alcuni
esperti dicono che ha realmente superato i 100 mila miliardi. L'indebitamento
pubblico interno ha raggiunto i 350 mila miliardi e ogni anno, di soli
interessi su questo debito, lo Stato paga dai 40 ai 45 mila miliardi,
raccolti generalmente attraverso l'emissione di Bot. L'indebitamento
esterno è di 50 miliardi di dollari, pari a circa 75 mila miliardi
di lire. La bilancia dei pagamenti correnti sfiora i 9 mila miliardi
di deficit, il disavanzo commerciale ha superato i 15 mila miliardi.
L'inflazione ha ripreso a marciare a una velocità che ha toccato
punte del 24%. Così, la nostra moneta non regge alla spinta ascensionale
dei dollaro e perde terreno anche nei confronti del marco tedesco e
dei franco svizzero. Per sostenerla, la Banca d'Italia spesso si svena.
L'"Azienda Italia" si avvia al fallimento? Il nostro sistema
economico è irrecuperabile o è ancora possibile salvarlo?
Qualche mese fa, Guido Carli, ex governatore dell'Istituto di emissione
ed ex presidente della Confindustria, ha parlato di "terapia d'urto"
per questa azienda malata. Ma dice Antonio Pedone, docente di Scienza
delle Finanze a Roma, consigliere dei Cnel e consulente scientifico,
con Spaventa, del Centro europeo ricerche: "Certo che la terapia
d'urto per un malato grave come l'Italia in questo momento può
essere una cura efficace. Ma bisogna stare attenti a non smarrire le
ragioni per cui viene imposta. Essa ha come obiettivo l'inversione delle
aspettative inflazionistiche. Per raggiungere tale obiettivo occorre
una terapia credibile, nel senso che la medicina deve avere effetto
per un certo periodo di tempo. Non è credibile una terapia che
duri, per esempio, quattro giorni, dopo i quali si ritorna all'allegra
finanza pubblica. Questa cura drastica deve quindi avere due requisiti:
essere massiccia ed essere credibile. Il terzo requisito è quello
-della sua diffusione, e non solo per rispondere a un criterio di equità".
Si riparla di "terapia classica", quella usata in molti Paesi
tra la prima e la seconda guerra mondiale. In che cosa consiste? Nel
controllo dei prezzi, nell'imposizione di imposte patrimoniali, nel
consolidamento del debito pubblico, nella tassazione delle rendite finanziarie,
nella stretta monetaria e nel controllo dei salari, fino alla riduzione
dello stesso salario, come avvenne nel nostro Paese nel periodo fra
le due guerre: azioni da avviare di volta in volta per una terapia "reale"
e "profonda", e non epidermica. Comunque, per una terapia
che non duri un'eternità. Il peggio, dunque, deve ancora venire.
|