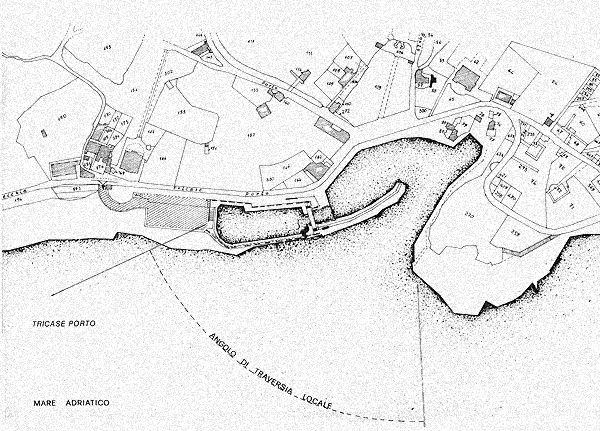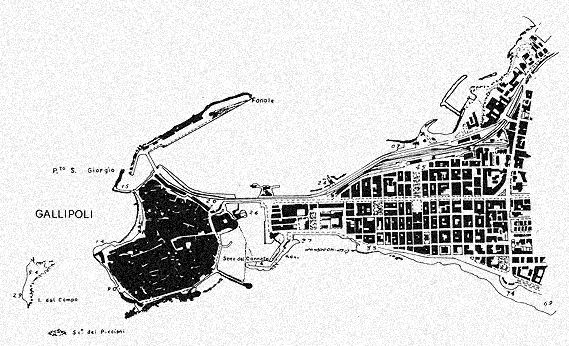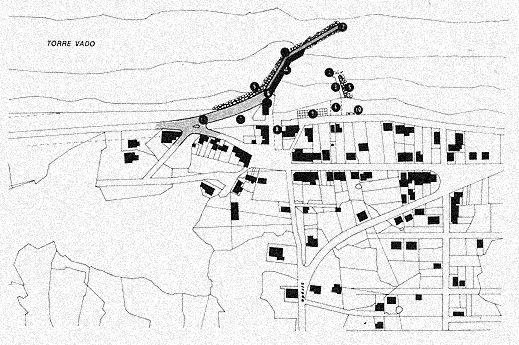"Finalmente
tutto quello che giova ad accrescere la circolazione interna, le strade
pubbliche, i canali di comunicazione, i porti ( .. ) giova ad equilibrare
lo stato delle province a quello della capitale".
(G. Filangieri, "La scienza della legislazione, 1784)
Alla fine, due secoli
dopo, l'esperienza storica dimostrerà che l'equilibrio non è
stato raggiunto (e mai, forse, sfiorato) e che la tesi dei Filangieri
apriva, già sul finire dei '700, la strada ad una serie di inquietanti
ipotesi da vagliare e verificare.
In primo luogo, che l'accentramento spasmodico di ogni attività
amministrativa e politica nella Napoli borbonica avrebbe irrimediabilmente
compromesso, a lungo andare, gli interventi finanziari a favore delle
"province" più meridionali. In secondo luogo, che lo
sviluppo economico e sociale di aree ad alta densità demografica
era strettamente condizionato dal parallelo potenziamento dei sistema
di comunicazioni terrestri e marittime. In terzo luogo, e questa è
la verifica, che i ritardi e le lacune operative avrebbero definitivamente
spostato il baricentro degli affari e dei commercio verso il Nord, chiudendo
gli sbocchi finanziari offerti dall'incipiente era industriale.
Le avvertenze ed i suggerimenti di coloro che, come il riformatore napoletano,
consideravano la concentrazione della ricchezza (e, quindi, della spesa
pubblica) in un solo punto della nazione ("La capitale, che dovrebbe
essere una porzione dello Stato, è divenuta il tutto, e lo Stato
non è più niente") come elemento frenante dello sviluppo
meridionale, caddero nel vuoto. Napoli, città guida dei Regno
delle Due Sicilie, accumulò capitali e relativi investimenti,
cristallizzandoli, però, nel suo immediato entroterra. Centro
di consumo piuttosto che di produzione, in essa confluirono per decenni,
con alterne fortune, le direttrici dei mercato nazionale ed internazionale,
mentre il resto dei Meridione rimase tagliato fuori, per decentramento
geografico e per la ferrea logica dei "privato", da ogni attività
che non avesse necessariamente il carattere della provvisorietà
e della immediatezza. Molte leggi speciali, ieri come oggi, pochi interventi
finalizzati a costituire le basi di un possibile decollo industriale
o, almeno, precapitalistico. "I lavori pubblici adoperarono per
un momento alcune braccia, ma non crearono un'industria nè una
borghesia nuova", secondo il Villari (1) e secondo l'intera corrente
dei liberalismo risorgimentale che, per primo, declinò l'immobilismo
e l'arretratezza meridionali con le desinenze di una questione sociale
che non poteva più essere ignorata.
La storia, come la natura, non contempla salti, e forse non se li può
permettere. E non è un caso che l'argomento dei quale ci occupiamo
(quattro porti salentini) debba prendere l'avvio da una situazione,
o da un modo di gestire la cosa pubblica, che affonda le sue radici
nelle plastiche aderenze dei secolo scorso, quando la geografia dei
Sud, e non solo dei Sud, avrebbe avuto la sua prima, e definitiva, configurazione
fisica, economica e sociale.
L'Italia ha uno sviluppo costiero di settemila chilometri. Oltre ai
limoni, dovevano fiorire anche i porti. Seicento chilometri di mare
in Puglia, con un profondo e sensibile inserimento nel Mediterraneo,
ai margini di Paesi e realtà emergenti. Quarantun porti in tutta
la regione: nove in provincia di Foggia (Manfredonia, Tremiti, Vieste,
Rodi, Mattinata, Peschici, Margherita di Savoia, Foce Varano, Foce Capoiale),
dodici in provincia di Bari (Bari, Barletta, Trani, Molfetta, Monopoli,
Mola di Bari, Bisceglie, Giovinazzo, S. Spirito, Palese, Torre a Mare,
Polignano) quattro in provincia di Brindisi (Brindisi, Savelletri, Villanova
di Ostuni, Torre Canne), due in provincia di Taranto (Taranto e Maruggio),
bel quattordici nella provincia più orientale della penisola,
Lecce (Otranto, Gallipoli, Tricase, S. Maria di Leuca, S. Cataldo di
Lecce, S. Foca, Morciano di Leuca, Torre S. Giovanni, Castro Marina,
S. Maria al Bagno, S. Caterina di Nardò, S. Cesarea Terme, Porto
Cesareo, Salve).
Abbiamo parlato di porti, ma sarebbe meglio parlare di approdi, o scali,
perchè i porti veri e propri, in tutta la Puglia, sono appena
tre: Bari, Brindisi e Taranto. I primi due, commerciali; il terzo, militare.
Il resto della regione è costellato da una miriade di scali,
di minima entità e scarsa importanza, destinati a non esperimentare
nuovi impulsi e nuove spinte in avanti.
Perchè questo stallo e questo strangolamento economico, anche
nell'involuzione dei sistema portuale? E' solo un riflesso dei disorganico
programma politico post-unitario, o il frutto di una scelta governativa
intesa a trasformare il Mezzogiorno in un territorio dipendente, anche
a livello di comunicazioni, in quel "Nebenländer" politico
e umano prodottosi, dopo l'Irlanda, in quasi tutti i Paesi europei?
Le due ipotesi hanno seri fondamenti storici: il sistema portuale, nel
Meridione, ha risentito dei generale vuoto legislativo che accompagnò,
nel primi anni dell'Ottocento, la creazione dei mercato nazionale. Ma
ha subìto, parimenti, l'imposizione di un'economia di ristagno
che offriva poche possibilità di incrementarsi attraverso i traffici
marittimi interni ed esterni. I pochi porti esistenti non vennero sfruttati
perchè la logica amministrativa impediva lo smistamento di capitali
in aree geografiche decentrate e perchè le infrastrutture dell'entroterra
furono realizzate con ritardi notevoli rispetto al resto d'Italia.
Le ferrovie, per esempio. Nel 1859 la rete ferroviaria in esercizio
nel Nord era di circa 1500 Km, mentre quella dei Sud non raggiungeva
i 350 Km. Bisogna attendere la fine dei secolo perchè l'estremo
lembo meridionale sia collegato stabilmente da una ferrovia con le regioni
settentrionali.
Indicativo di una tendenza di fondo il fatto che in ben quattro proposte
governative per l'unificazione ferroviaria (Petitti e Cavour, 1845;
Deboni, 1846; Rossi, 1861; Commissione LL.PP., 1861; Il Politecnico,
1861), il Salento non abbia voce in capitolo. Lo squilibrio è
ancor più evidente se si valuta l'entità degli investimenti
effettivamente operati nelle diverse circoscrizioni territoriali per
le costruzioni ferroviarie: su un totale di 5.600 milioni spesi dallo
Stato, il 33,1% è andato al Nord, il 18,1% al Centro e il 27,0%
nel Mezzogiorno (il restante 21,8% non può essere ripartito perchè
riguarda opere di carattere nazionale, o non territoriale). "Ora,
poichè è noto che a causa di condizioni tecniche oggettivamente
peggiori (montuosità, natura dei terreno, frequenza di manufatti
speciali) i costi unitari per la costruzione di ferrovie sono stati
molto superiori al Sud che non al Nord - e lo dimostrano le continue
richieste di sovvenzioni, contributi, revisioni di convenzioni che le
imprese operanti nel Mezzogiorno facevano allo Stato perchè le
sostenesse, ben diversamente da quanto avveniva nel Settentrione, dove
le concessioni venivano sollecitate e contese tra i vari gruppi privati
- è evidente che a una minor spesa in assoluto non poteva che
corrispondere una peggiore qualità dei prodotto, sia in termini
di infrastrutture che in termini di servizio" (2).
Qualitativamente e quantitativamente inferiori a quelle dell'Italia
Settentrionale, le ferrovie dei Sud agirono, in prospettiva, come fattore
di ulteriore squilibrio nel processo di sottosviluppo di un Meridione
sempre più riserva finanziaria e "mercato coloniale"
utili alla formazione dei moderno apparato industriale dei Nord.
Falliti i tentativi degli speculatori privati (Bayard-de-la-Vyngtrie,
Adami e Lemmi, che aveva legami finanziari con il Partito d'Azione,
Talabot, Rotschild, Bastogi), il Salento dovrà attendere il 1905,
anno della nazionalizzazione e istituzione delle Ferrovie dello Stato,
perchè il suo territorio fosse compreso nei piani di intervento
ferroviario predisposti dalla "Sud-Est". I lavori inizieranno
dopo il 1910.
Seconda voce, viabilità e strade. Nel 1860 la densità
stradale complessiva nel Regno delle Due Sicilie era di 0,1 Km per Kmq.
di territorio, mentre nel Nord essa era di 0,3 Km. per Kmq. Due soli
erano i collegamenti "rotabili" tra Nord e Sud, entrambi difficili
e malsicuri: il primo attraversava le Paludi Pontine (l'antica Via Appia)
e il secondo l'Appennino abruzzese, da Sulmona a Isernia; entrambi,
per di più, convergevano su Napoli, lasciando dei tutto scoperto
il resto dei Mezzogiorno continentale. Traffico difficile, spesso pericoloso,
quasi sempre discontinuo. Se i riferimenti letterari possono fare testo,
basti pensare al viaggio dei Gattopardo da Palermo a Donnafugata.
Quando, nel 1863, il ministro dei LL.PP., De Vincenti, affermava che
"niuna cosa ha maggiore influenza sulla produzione di un Paese
che la viabilità... le strade vivificano l'agricoltura, creano
le industrie, dànno origine ai commerci... la statistica delle
strade è la statistica della ricchezza di un Paese", ritenendo
che una nazione civile non potesse contare meno di 1 Km di strade per
Kmq di territorio, nel Mezzogiorno il 70% dei comuni (1313 su 1792)
era praticamente privo di un effettivo collegamento stradale.
Il ritardo, però, coinvolge l'intero apparato nazionale. Nel
1870, la viabilità pubblica si avvaleva di 86.000 chilometri
di strade (nazionali, provinciali, comunali), contro i 641.000 chilometri
della Francia, e i 200.000 chilometri dell'Inghilterra. Il raffronto
èancor marcato se consideriamo che le strade comunali (che ci
interessano più da vicino) rappresentavano, tanto per la Francia
quanto per l'Inghilterra, la voce maggiormente ricorrente nel capitolo
degli investimenti governativi. L'esperienza d'oltr'Alpe che aveva dimostrato,
tra l'altro, come il potenziamento dell'agricoltura, in chiave capitalistica
esterna, e l'eliminazione dei brigantaggio (Scozia e Galles), in rapporto
alla sicurezza interna, dipendessero, in maniera rilevante, dal grado
di penetrazione economica dei "chemins vicinaux" e delle "strade
parlamentari", non venne recepita, invece, in Italia. Al contrario.
Con la classificazione di cui all'Allegato "F" delle legge
n. 2248 dei 1865 che ripartiva, per la prima volta, le strade in quattro
categorie in base alle competenze dell'operatore pubblico (strade nazionali,
di competenza statale; strade di seconda categoria, di competenza delle
province; strade di terza categoria, di competenza dei comuni; e le
strade di quarta categoria, demandate ai consorzi formati dagli utenti
privati), lo Stato si limitava ad un ruolo di promozione e coordinamento,
decentrando la formazione delle reti secondarie ad organi amministrativi
minori. Non solo. Tre anni dopo, la legge n.4613, escludendo tassativamente
ogni finanziamento governativo, stabiliva che la costruzione delle strade
comunali era un obbligo giuridico al quale i comuni non potevano sottrarsi,
e al quale avrebbero dovuto provvedere, tempo due anni, anche con l'imposizione
di pedaggi, di tasse sui principali utenti, e di prestazioni d'opera
gratuite da parte dei cittadini.
Il carattere volutamente discriminatorio della legge è evidente,
in quanto privilegiava i comuni più ricchi (disposti interamente
nelle province settentrionali), penalizzando i centri meridionali concretamente
impossibilitati, per mancanza di fondi di gestione, ad inaugurare un
programma organico di costruzioni, e di edilizia, stradali.
I risultati si rivelarono catastrofici. Ai comuni inadempienti si sostituirono
le prefetture, con procedure d'ufficio e d'urgenza. Ed anche in questo
caso, le sovrapposizioni e gli innesti, gonfiando l'iter burocratico,
bruciarono appalti, capitali ed iniziative, finchè il completo
fallimento dei disegno governativo non indusse lo Stato ad intervenire
di persona, finanziando direttamente i piani di sviluppo e i relativi
lavori. Il che avvenne solo nel 1919, con la creazione dell'Istituto
Nazionale per le Opere Pubbliche dei Comuni, collegato alla Cassa Depositi
e Prestiti e al Genio Civile, e controllato dal Ministero dei LL.PP.
L'isolamento si compie in cinquant'anni. Praticamente, dal 1850 al 1900,
dall'abolizione delle barriere doganali interne all'apertura di mercati
commerciali esterni, dal l'accentramento amministrativo cavouriano alle
leggi speciali dei liberalismo giolittiano. Mai terra di "frontiera",
e mai destinato ad avere una sua, peculiare, epopea pionieristica, il
Salento perde, proprio in quegli anni, la possibilità di esperimentare
gli attributi di un "self government" amministrativo, maturando,
invece, in clima autarchico e protezionista, un'economia asfittica,
basata su strutture ed infrastrutture inadeguate ed antiquate.
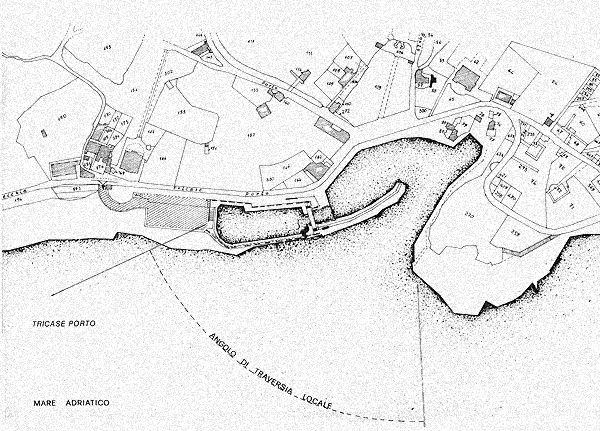
Paradossalmente, il primo treno ad arrivare nel Salento significò,
anche, l'ultima corsa, verso il Meridione, di realtà economiche
ed industriali ormai orientate verso i mercati internazionali. Al Sud
rimase un biglietto di sola andata, un'industria fondamentalmente casalinga,
un'agricoltura seminaturale.
In questo contesto, e con queste premesse, il piano delle localizzazioni
portuali non poteva non fallire. Fino ad oggi, la storia non ha smentito.
Valgano da esempio quattro porti salentini. Dall'Adriatico allo Ionio:
Tricase, Santa Maria di Leuca, Torre Vado, Gallipoli. Su presunzioni
storiche, un dato in comune: anticamente costituirono la testa di ponte
dei traffico marittimo verso l'Oriente, e dalla Grecia verso le colonie
calabresi. Lo attestano i relitti di navi greche e romane, con relativo
carico, scoperti sui fondali che cinturano le coste da S. Cataldo a
Santa Caterina. Un mercato fiorente, la punta avanzata per la penetrazione
economica ad Est e l'interscambio commerciale. Con il passar dei secoli,
invece, il declassamento. Porti difensivi (meglio, di "avvistamento")
contro le incursioni turche prima, scali di secondo ordine nell'Italia
preunitaria poi. Il momento critico, sul finire dell'Ottocento. La mancata
realizzazione di strade e errovie e di un organico quanto conveniente
collegamento con l'entroterra impedirà ai quattro porti di agganciarsi
(trainando il mercato agricolo interno) al decollo capitalistico settentrionale.
Penalizzati da secche e scogli che impedivano l'attracco a bastimenti
di grosso tonnellaggio, continueranno a sopravvivere ad economie locali
sempre più strangolate dall'isolamento geografico. Indicativo,
in questo senso, l'esempio dei porto di Tricase che gestì, in
esclusiva, fino al 1700, il traffico di pelli conciate, finchè
la concorrenza di Francia ed Inghilterra (che si servivano delle infrastrutture
tecniche del Nord) e la sopravvenuta impossibilità di piazzare
tempestivamente il prodotto sul mercato interno non determinarono, in
pochi anni, la caduta verticale di una attività che, in sei secoli,
non aveva mai dato segni di cedimento.
A metà Novecento, infine, il collasso. Coincide, almeno per i
porti di Tricase, Torre Vado e Leuca, con le scelte economiche della
ricostruzione (e un nuovo spostamento di capitali a Settentrione, per
la ripresa industriale), con la crisi di rigetto dei l'agricoltura,
arcigna nelle sue specializzazioni, con la mancata industrializzazione
delle regioni meridionali, con il criterio di rimescolare le carte,
inventando la combinazione vincente dei Turismo.
Eccetto quello di Gallipoli, gli altri tre, oggi, sono considerati e
classificati esclusivamente come porti turistici, anche se, nell'ottica
dei "marketing oriented", gran parte della flotta diportistica
si va concentrando sempre più nelle coste liguri e toscane, con
una progressiva sottoutilizzazione dei litorali nel resto della Penisola
e nelle Isole.
Quale futuro, dunque, per questi porti? E vero quanto sostiene il ministro
Signorello, e cioè che "il turismo non è alternativo
alla industrializzazione ed allo sviluppo dell'agricoltura" (4),
ma è anche vero che il turismo rappresenta, per questi scali
e per tutto il Salento, l'ultima spiaggia e l'ultima occasione.
Molte analogie e poche differenze, tra i porti considerati.
TRICASE PORTO: lat. 39° 56' N - long. 18° 24' E. Incassato tra
alte scogliere, fondali fangosi e bassi, può ospitare solo imbarcazioni
da diporto medio-piccole e pescherecci di tonnellaggio limitato. Classificato,
nel primo Novecento, porto di prima categoria, "nei riguardi della
difesa dello Stato", agevolò l'esportazione dei tabacco
verso i mercati dei Nord Europa, e costituì una tappa obbligatoria
per le navi a vapore della società di navigazione "Puglia"
che collegava Bari a Messina.
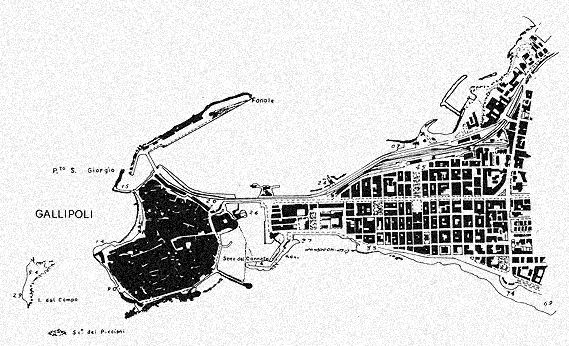
Oggi, il traffico commerciale è praticamente azzerato. Sopravvive
la pesca, anche se il numero delle imbarcazioni mediamente presenti
nelle sue acque è sensibilmente diminuito dal 1980. Con delibera
consigliare dei 1982, è stato approvato il progetto di ampliamento
delle strutture portuali, con la creazione di un secondo bacino da collegare
con quello esistente: Finanziamenti regionali per circa due miliardi,
e lavori che procedono a ritmo ridotto, per difficoltà tecniche,
ma soprattutto per gli ostacoli frapposi dalle procedure burocratiche.
In prospettiva, la possibilità, e il rischio, che l'inflazione
e il costo dei denaro brucino le somme erogate, e che il piano di intervento
abbia solo una parziale realizzazione.
Il nuovo porto potrà ospitare fino a trecento imbarcazioni, da
pesca e da diporto, ma i ritardi potrebbero invertire anche la tendenza
turistica, vanificando gli spiccioli di speranza che ancora restano.
SANTA MARIA Di LEUCA: lat. 39° 48' N -long. 18° 22' E. Quasi
venti miliardi di finanziamento (sette regionali, tredici statali);
in conto capitale una prima "tranche" di cinque miliardi.
Classificato, nel 1935, nella prima categoria dei porti marittimi nazionali,
quale porto di rifugio, e nella seconda categoria, quarta classe, come
porto commerciale, non e mai decollato per carenza di strutture e per
la posizione geografica che lo decentra al massimo dal capoluogo provinciale.
In più, non è un porto sicuro, perchè il libeccio
e lo scirocco creano periodiche ondazioni, con notevole risacca nello
specchio d'acqua interno.
L'elaborato tecnico, approvato dal Consiglio Comunale di Castrignano
dei Capo nel 1980, prevede un prolungamento dell'attuale molo foraneo,
di circa 130 metri, e la costruzione, ex novo, di un braccio di chiusura,
o "testata", di 40 metri. Le opere, se realizzate, dovrebbero
portare ad un incremento e a uno sviluppo lineare delle banchine d'attracco,
con l'adeguamento delle dimensioni e delle caratteristiche dello scalo
d'alaggio esistente all'attuale flottiglia peschereccia operante in
zona. Inchieste giudiziarie e ritardi amministrativi hanno intanto bloccato
i lavori che riprenderanno, si presume, dopo l'estate. Per il momento,
quindi, solo scalo turistico. Troppo poco, per tentare anche il decollo
commerciale nel Mediterraneo.
TORRE VADO, porto di Morciano di Leuca. Una storia recente, da coniugare
solo al futuro. Scalo di modestissime dimensioni, è praticamente
chiuso anche al discorso turistico. I ritardi, qui, sono stati decisivi.
Assegnato nel 1979, il progetto ha preso il via solo quest'anno. Dai
275 milioni iniziali si è arrivati al miliardo e mezzo attuale,
ma la cifra non sembra idonea a coprire l'intera realizzazione dei piani
di costruzione. Previsti due bracci di contenimento: molo foraneo di
200 metri, e testata di 70 metri, per ospitare 100 imbarcazioni di piccole
dimensioni. Penalizzato da una posizione infelice ai margini dei Salento,
il porto di Torre Vado potrebbe tentare l'alternativa della specializzazione.
Potenziare, cioè, le infrastrutture portuali per lo sfruttamento
economico del banchi di corallo (rosso e bianco) che esistono al largo
delle sue coste. L'affare è conveniente, se tre pescherecci ciprioti,
di media stazza, da due anni conducono ricerche in tal senso. Non solo
corallo in ogni caso. La pesca d'alto mare (pesce-spada, triglie ed
aragoste) potrebbe risultare oltremodo decisiva per incrementare un'economia
locale, fondamentalmente asfittica, ed ancorata tutt'ora ai canoni tradizionali
dei l'investimento fine a se stesso.
Ma, queste, sono ipotesi di lavoro, e, come tali, da vagliare, in relazione,
sopratutto, alle capacità che il porto avrà di attirare
investimenti e capitali.
PORTO DI GALLIPOLI: lat. 40° 03', 5 N - long. 17° 58', 5 E.
E' l'unico scalo salentino che possa, in prospettiva, rompere l'egemonia
dei porti settentrionali. L'investimento (30 miliardi) della Regione
e dello Stato, per ampliamento delle infrastrutture, sembra destinato
in tale direzione. In più, Gallipoli è il solo porto commerciale
dei Salento, molto vicino a Taranto, ma molto distante anche da Brindisi
e da Bari. Può diventare, pertanto, un polo alternativo nel commercio
tra Italia e Paesi emergenti dei Mediterraneo. Le cifre, e il volume
degli scambi con Paesi terzi, illustrano ampiamente questa tendenza.
Aumento delle esportazioni (vino per i Paesi dei Nord Europa, mattonelle
per l'Arabia, vermouth delle aziende esistenti tra Brindisi e Lecce,
farina di buccia d'uva che, inutilizzata in Italia, viene convertita
in fertilizzante agricolo in Inghilterra), con un incremento dei traffico
totale del 47% rispetto agli anni precedenti: 300 navi arrivate e partite,
contro le 150 del 1980.
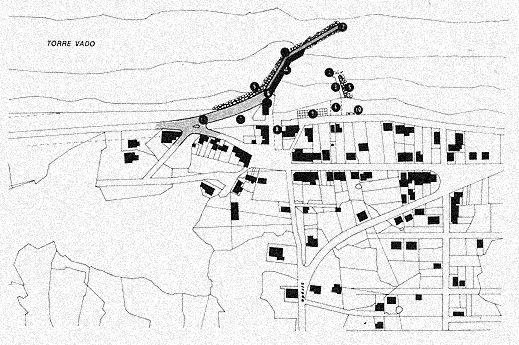
Ma Gallipoli è
già una realtà diversa. Porto di seconda categoria commerciale
e di seconda classe, dispone di approdi differenziati per la flottiglia
peschereccia, per quella diportistica e, infine, per quella mercantile.
Non sfugge, tra l'altro, l'importanza strategica (come base di ripiegamento,
nell'ipotesi di un attacco alle strutture militari tarantine), visto
il sensibile inserimento nel bacino dei Mediterraneo che lo rende trait
d'union con i paesi africani e con quelli medio-orientali.
Molte analogie, abbiamo detto. In sintesi: i quattro porti non dispongono
di un collegamento, ferroviario e stradale, adatto allo smistamento
delle merci verso l'interno, e dall'interno. In secondo luogo, gli investimenti
finanziari per il potenziamento delle capacità portuali sono
stati deliberati, e ancora spesso sulla carta, con notevole ritardo
rispetto ad altri approdi italiani. In terzo luogo, eccetto Gallipoli,
gli altri porti non dispongono di un mercato ittico di sostegno, all'interno
delle stesse strutture portuali. Il pescato deve subire i cosiddetti
"tempi di percorrenza", prima di arrivare nei paesi e nella
stessa città di Lecce. Aumentano, così, tempi e spese.
Quarto rilievo, l'insufficienza delle infrastrutture costringe l'economia
della pesca a un circolo vizioso che si consuma, nell'immediato entroterra,
senza possibilità di piazzarsi su mercati diversi e decentrati.
Quinto, le stesse carenze tecniche impediscono ai quattro porti di arginare
la concorrenza, ormai spietata, di altri Paesi meridionali, come Mazara
dei Vallo, ed internazionali come il Giappone e la Francia.
Nella polverizzazione degli interventi, delle responsabilità
e delle competenze in materia portuale, Tricase, Leuca e Torre Vado
danno l'impressione di non poter reggere il passo, perdendo anche l'ultima
corsa. Solo Gallipoli potrebbero ancora tentare, in extremis, la carta
dei commercio con i Paesi dei Terzo mondo.
In caso contrario, non solo il Salento si ripiegherà, contemplativo,
sullo stallo economico che, in definitiva, gli appartiene, ma si assisterà
anche al solito e collaudato fenomeno degli interventi straordinari
che non portano a nulla di concreto e di definitivo. Anche perchè
se è vero che, parafrasando Lamartine, "noi dobbiamo tutto
al mare", è anche vero che il coccodrillo dello sviluppo
meridionale non si ottiene soffiando dentro la lucertola dei vuoti politici.
NOTE
1) P. Villari, "Le lettere meridionali ed altri scritti sulla questione
sociale in ltalia", Firenze, 1878, p. 41.
2) Alberto Mioni, "Le trasformazioni territoriali in Italia della
prima età industriale", Marsilio ed., Venezia, 1976.
3) R. Tremelloni, "Fasi della recente storia delle strade in Italia",
in Economia e Storia, IX, 1962, n. 4.
4) Gazzetta del Mezzogiorno, 27 marzo 1983, p.4.
|