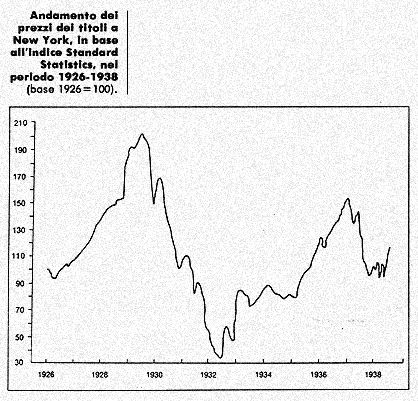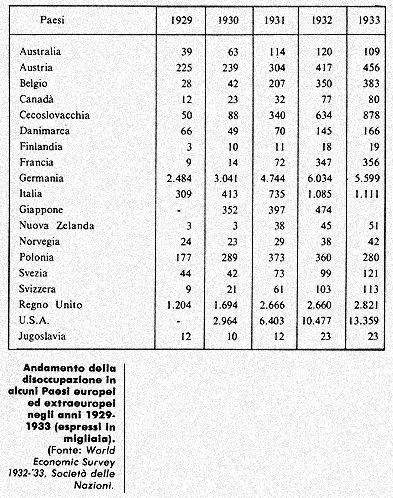Gli Stati Uniti
d'America erano l'America tout court. E l'America scoppiava di salute.
Herbert Hoover ebbe persino l'imprudenza di dire: "La prosperità
è all'angolo della strada". Era diventato presidente nel
1929, a cinquantaquattro anni, aggiudicandosi quaranta States. Sprizzava
ottimismo da tutti i pori. I suoi connazionali lo ricordavano quando
aveva diretto con un'efficienza impareggiabile l'approvvigionamento
del Paese durante il primo conflitto mondiale. Si presentò
alla cerimonia di insediamento alla presidenza in marzo con baldanza:
"Non ho paura per il futuro del nostro Paese. E' luminoso di
speranza".
Gli americani notarono subito che aveva portato l'efficienza alla
Casa Bianca. Nella prima settimana fece rimuovere le vecchie lampade
a olio e la carta da parati. Nella seconda fece piazzare un telefono
sulla sua scrivania: gli altri presidenti erano sempre andati a telefonare
nella stanza accanto. "Con me", disse Hoover, "l'american
way of life non corre pericoli". Promise ai connazionali inebriati:
"Vi farò tutti ricchi". Negli anni precedenti, ogni
americano si era fatto l'automobile; ora il magnate del motore, Chrysler,
proclamava che era giunta l'ora di procurare a ciascuno un'auto di
lusso.
Diceva John Raskob, miliardario e presidente della Generai Motors:
"Ognuno dovrebbe essere ricco. Non arrivarci oggi è colpevole.
la fortuna è alla portata di tutti. Basta investire quindici
dollari ogni mese in Borsa ed essi in vent'anni, per il gioco dei
dividendi, portano un capitale di ottantamila dollari". Infatti,
i titolari di redditi modesti erano guardati con sospetto. Chi non
aveva un buon lavoro per elevarsi, poteva pur sempre ricorrere alla
lotteria nazionale: la Borsa. Questa era diventata un pozzo di San
Patrizio. Nel maggio 1929, un'inchiesta ordinata da Hoover permise
di appurare che diciassette milioni di cittadini americani giocavano
in Borsa. La maggior parte erano, diceva l'inchiesta, "investitori
nuovi, piccoli ignoranti". Compravano azioni non per risparmiare,
ma per arricchirsi. La stampa era la loro droga: dava enorme risalto
a storie di gente che aveva investito quattromila dollari e se ne
era ritrovati in tasca centocinquantamila. Proclamavano i fogli finanziari:
"E' il 1929, e tutto va bene". La grande immoralità
di fondo fu che tutti potevano giocare in Borsa.
La ruota della fortuna aveva girato con opulenza e aveva permesso
di collaudare i ben oliati congegni della prosperità americana.
Lo Stock Exchange, la Borsa, si rivelava veramente la versione novecentesca
e capitalistica della celeberrima corsa all'oro della metà
dell'Ottocento. Il numero delle azioni scambiate alla Borsa di New
York saltò da 449 milioni nel 1926 a 576 nel 1927, a 920 nel
1928, a un miliardo e 124 milioni nel 1929. Ogni impiegato poteva
giocare a fare il finanziere, cimentandosi in una specie di gioco
dei Monopoli per nulla rischioso. Tutto quello che aveva da fare,
era sollevare la cornetta del telefono e chiamare l'agente di cambio.
Questi Dulcamara del dollaro nel 1920 prestarono un miliardo; nel
1927, tre miliardi e mezzo; nel 1929 superarono i sei miliardi.
Qualche pessimista osò dire che sarebbe bastato un granello
di sabbia nell'ingranaggio e l'intera macchina surriscaldata sarebbe
andata a pezzi. Ma perché sarebbe dovuto accadere? Crepasse
l'astrologo! America la Magnifica, come l'aveva battezzata F. Scott
Fitzgerald, alzò le spalle. Il 18 marzo arrivò un ammonimento.
Lo dette un banchiere, Paul Warburg, presidente dell'International
Acceptance Bank, l'uomo che molti nel mondo della finanza consideravano
il più competente in fatto di titoli e di monete.
La Borsa, disse Warburg, è sospesa a precipizio su una roccia
che strapiomba su un mare in tempesta. Perché gli agenti di
cambio non cercano di puntellarla? Fu chiesto. Semplice, rispose Warburg:
perché gli agenti sono eccellenti clienti delle banche, e le
banche hanno interesse a chiudere un occhio sulla situazione. La risposta
degli agenti fu irosa: perché Warburg cerca di romperci le
uova nel paniere? E' un ottobre ventoso e carico di paure. L'allarme
all'America lo da, come accade da anni, Chicago. Un gangster ha gettato
una bomba nell'ufficio di un agente di cambio. Se i rackets si sono
accorti che la Borsa non è più l'eldorado, significa
che la situazione è grave. Da parecchi giorni proliferano le
vendite in un clima di nervosismo. E' arrivata l'ora del mercato dell'Orso,
il ribasso. Si chiama così, dice la leggenda, perché
al tempo dei pionieri uno speculatore cercò di vendere la pelle
di un orso prima di averlo ucciso, e i creditori vennero a vedere
il suo bluff, rovinandolo.
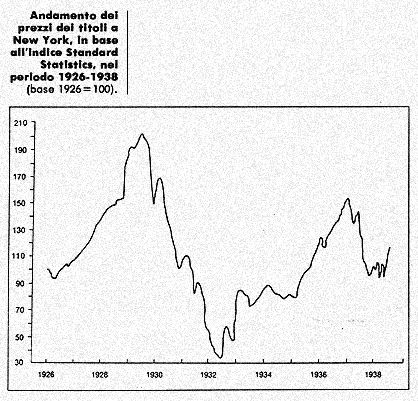
Alle dieci in punto di giovedì 24 ottobre 1929 suona il gong
che annuncia l'apertura delle contrattazioni alla Borsa di New York.
La prima transazione vede cedere 6.000 azioni della Montgomery Ward
a ottantatre dollari l'una: il loro prezzo per tutto il 1929 si era
aggirato sui centocinquanta dollari. Un fremito di terrore passa nel
recinto.
Alcuni uomini cercano di scongiurare il giorno del giudizio. Al ventesimo
piano del grattacielo di Wall Street 23, di fronte alla Borsa, nell'ufficio
della direzione della Banca J.P. Morgan, sei titani della finanza
americana si sono dati convegno in extremis per prendere misure d'emergenza.
Presiede Thomas W. Lamont, il cervello della Banca Morgan. Parla a
scatti, con la lingua che gli si inceppa. E a tratti abbandona la
scrivania di mogano, per incollarsi al vetro della finestra e gettare
lo sguardo in basso, sulla folla che sembra impazzita. Lamont è
conosciuto per la sua fredda energia di generale del dollaro: "L'obiettivo
essenziale del momento è ristabilire la fiducia. Faremo fronte
tutti insieme. Acquisteremo per tenere alto il mercato. Per il dollaro
costruiremo l'equivalente di ciò che fu per i francesi, durante
la guerra, la linea della Marna. Gli speculatori e gli affamatori
non dovranno passare".
Gli altri lo ascoltano con l'occhio spento. Sono vecchie volpi che
dalle assi sconnesse di un bastimento per emigranti si sono innalzate
a un Walhalla di dei dell'oro. Adesso hanno paura: guardano con orrore
da quel ventesimo piano, come se temessero che stia per diventare
la loro Rupe Tarpea. Il povero nell'ora del disastro sfodera le sue
naturali difese; il ricco è patetico. Con un tremito che scuote
le rughine della bocca, i titani urlano e discutono per novanta minuti.
Poi decidono di varare l'Operazione Cuscino: manderanno un loro uomo
a comprare azioni, per sostenere il mercato.
E' l'una e trenta dell'interminabile giornata. Richard F. Whitney,
chiamato "il cavaliere bianco di Wall Street", agente di
cambio e vicepresidente della Borsa, esce dall'edificio della Banca
Morgan. Si fa largo tra la folla ed entra nello Stock Exchange, dove
l'atmosfera è veramente quella delle trincee della Marna.
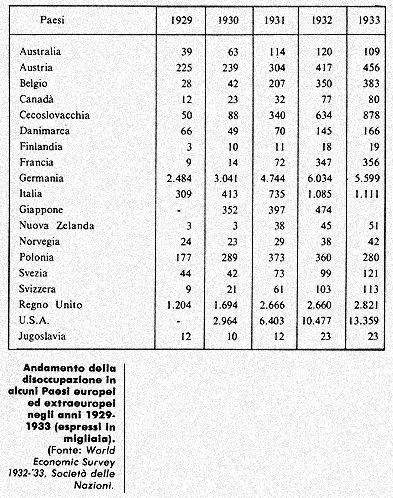
Il macello è continuato per tutta la mattina. Il terrore è
corso lungo gli stucchi dorati della hall di marmo grigio. Faccia
a faccia, lungo i diciannove sportelli della Borsa, è mancato
poco che agenti di cambio e clienti si prendessero a pugni. Il quadro
elettrico all'altezza del primo piano, sul quale sono scritte le quotazioni,
sembra la mappa di una battaglia. I continui ribassi equivalgono a
postazioni perdute. Ogni volta che un valore precipita, dalla folla
si alzano voci di disorientamento, grida di rabbia. Si sbriciolano
fortune, si polverizzano vite: molti non troveranno la forza di andare
a casa, la sera, a raccontare ai familiari che i risparmi di un'esistenza
sono stati ingoiati dal vento. I loro cadaveri finiranno per coprire
l'antica pista dei bisonti.
Quattro lampadine sul muro lampeggiano senza interruzione. Vi appaiono
dei numeri. Corrispondono agli agenti di cambio abilitati a contrattare
in quella Borsa. Ogni strizzata d'occhio della lampadina vuoi dire
che c'è la telefonata di un cliente. Agli agenti di cambio
le orecchie dolgono per il rimbombo. Ma l'atto di ascoltare è
soltanto meccanico. Conoscono a memoria il ritornello iroso che trapana
l'apparecchio e i timpani: "Venda! For Heaven's sake, per amor
del cielo, venda!!!".
Ora Whitney, estintore vivente, procede a malapena nel caos della
hall. Una baraonda. Stanno sopraggiungendo migliaia di piccoli risparmiatori,
dal Bronx, da Brooklyn, dal New Jersey, sulle loro auto comprate a
rate, e contemplano con i loro occhi la propria disgrazia. Tra poco
faranno a pezzi le telescriventi che ticchettano i prezzi disastrosi.
Whitney si ferma davanti allo sportello 2: qui viene trattato l'acciaio,
l'azione U.S. Steel, titolo-perno della Borsa. Domanda la quotazione.
E' calata a 193 dollari. Urla a tutto spiano, in modo che tutti lo
sentano: "Compro 25.000 azioni U.S. Steel a 205 dollari!".
La folla tiene il respiro: questo è Sigfrido che arriva a riequilibrare
le fortune dei Nibelunghi. Da quella platea di neodiseredati sale
l'accenno di un timido applauso. Whitney si aggira come un'ape a suggere
il miele di ogni sportello: 10.000 azioni per ciascuno, alla miglior
quotazione. In cinque minuti rastrella titoli per trenta milioni di
dollari. Quando il cavaliere generoso esce dalla hall, le telescriventi
cantano la sua gloria. Il bluff psicologico ha funzionato. L'emorragia
di azioni sembra arrestata. Il risparmiatore riprende fiducia. Questa
camera di rianimazione funziona meno di due ore. Poi è il collasso.
Alle tre, quando l'implacabile gong argenteo scandisce la chiusura,
la Borsa è nell'abisso. Molti non si abituano all'idea che
il giorno seguente dovranno ricominciare un'altra vita. A mezzogiorno
i suicidi si contano ancora sulle dita di due mani: le informazioni
più pessimistiche parlano di dodici. Entro sera saranno migliaia.
A mezzanotte si verifica l'episodio che fermerò per sempre
l'immagine di quel fatale giovedì. Un signore elegantemente
vestito, dall'aria di banchiere, si presenta al Waldorf Astoria, il
più sfarzoso albergo di New York, e chiede una camera all'ultimo
piano. Il portiere gli porge la chiave e inquisisce, fra cinico e
preoccupato: "E' per dormire o per saltare?". Su questa
battuta si archivio definitivamente nella storia il Black Thursday,
il giovedì nero 24 ottobre 1929 del crollo di Wall Street.
Dopo la chiusura della Borsa, il presidente Hoover ha interpellato
il suo grande ministro del Tesoro e gli esperti. Ai giornalisti mostra
un volto disteso a metà: "Gli interessi del Paese riposano
su basi solide. E' stata l'isteria a determinare il panico. Domani
il mercato ritroverà la calma". Appena l'ultimo giornalista
ha voltato i tacchi, Hoover si precipita alla telescrivente. Vi resta
incollato fino alle sette e mezza di sera, a seguire le quotazioni
sprofondanti, come milioni di americani. Le sue parole di mesi prima
gli risuonano ironiche nell'orecchio: "Noi stiamo indefessamente
costruendo una nuova civiltà".
L'era Hoover, inaugurata nel segno della speranza, finiva senza speranza,
travolta dalla paura.