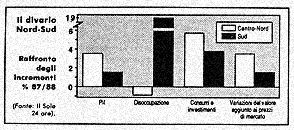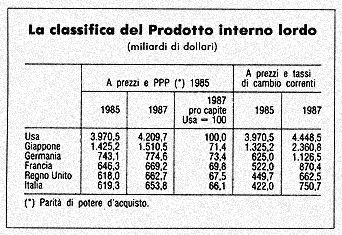Nessuno
lo nega: una maggiore integrazione europea è indispensabile,
anzi vitale. Perché allora continui ad essere frenata dai particolarismi
nazionali è un vero e proprio mistero. la domanda, allora, è:
quest'Europa ci conviene oppure no? A moltissimi, pare di sì,
anche se, come afferma il ministro italiano del Tesoro, l'Europa ha
un alto indice di gradimento a parole, mentre nei fatti è ostacolata
da una classe politica "che teme di essere colpita dall'integrazione
perché sulla scena europea conterebbe di meno". Altre preoccupazioni
riecheggiano dalle banche, che dovranno giungere all'appuntamento del
1992 quasi radicalmente trasformate, più concorrenziali, meno
amministrativizzate. Inoltre, fondamentale per il miglioramento del
nostro sistema finanziario è la riforma del mercato secondario
dei titoli di Stato, insieme con quella della Borsa. Secondo alcuni
economisti, poi, sarà necessaria anche la creazione di una Banca
Centrale Europea. Ha chiarito il ministro francese del Tesoro: "Senza
un'istituzione centrale di controllo, i capitali saranno attratti verso
la Repubblica Federale Tedesca, che ha moneta forte, provocando lo sbandamento
del Sistema monetario europeo". E ancora: il rafforzamento dello
Sme richiede obbligatoriamente l'entrata nel Sistema della sterlina
inglese. In cambio, l'Italia sarebbe disposta a rinunciare alla banda
di oscillazione più ampia (6 per cento) di cui beneficio la lira.
Un serio problema del l'integrazione finanziaria europea resta quello
della coesistenza di due poli: da una parte, Londra, cuore finanziario;
dall'altra, Bonn, fulcro e cuore monetario del sistema. Verso quale
del due dovrà gravitare il nostro Paese? E' un dilemma di non
facile soluzione, che il processo di integrazione dovrà comunque
affrontare, anche perché sono previsti benefici stimoli alla
finanza e sull'economia ,reale dell'Italia. D'altra parte, per evitare
effetti negativi sugli equilibri finanziari internazionali, è
necessario che la liberalizzazione europea non sia intesa come generica
deregulation, ma sia accompagnata da una più intensa regolamentazione
"prudenziale", a tutela del risparmiatori e della liquidità
e solvibilità delle istituzioni creditizie. E in ogni caso, osservano
alcuni economisti, riforme di questa portata non sono attuabili senza
muovere verso un nuovo "sistema di governo" europeo, che sia
in grado di sostituirsi ad una debole volontà politica dei singoli
Paesi.
E' stato scritto che dal punto di vista finanziario l'attuale costruzione
dell'Europa presenta "evidenti asimmetrie". La liberalizzazione
dei movimenti di capitale potrebbe addirittura accentuarle, invece che
ridurle. In termini monetari e commerciali, la Germania Federale è
il "Paese-centro". E' infatti il principale mercato di esportazione
di ciascun Paese europeo, ed è quindi - in termini keynesiani
- il Paese che presenta a livello europeo il maggior "moltiplicatore"
della sua domanda interna. Inoltre, la Bundesbank è di fatto
la Banca Centrale europea, nel senso che la sua politica monetaria tende
a definire il grado medio di stabilità dei prezzi in Europa.
I periodici riallineamenti dello Sme non hanno impedito che tendenzialmente
i Paesi europei convergessero verso il tasso di inflazione tedesco,
nel corso degli ultimi otto anni, e, prevedibilmente, anche in futuro.
A questo ruolo commerciale e monetario della Germania Federale non si
accompagna peraltro un equivalente ruolo finanziario. Francoforte non
è il centro finanziario dell'Europa, né lo sta per diventare.
In effetti, è Londra questo centro finanziario europeo, e allo
stesso tempo è il punto di scambio con i mercati finanziari mondiali.
Ma Londra non è parte dell'accordo di cambio dello Sme, e ritiene
ciò inevitabile, data la scelta di privilegiare il suo vantaggio
comparato nell'offerta di servizi finanziari.
Nel campo finanziario, ciascun Paese europeo è più integrato
con il resto del mondo (di norma, via Londra), che non con i suoi partners
europei. Da trent'anni, ormai, invece di un mercato finanziario europeo
si è avuto infatti lo sviluppo dei cosiddetto "euromercato",
che èsostanzialmente off shore per ciascun Paese europeo. La
crescita di questo mercato, inizialmente favorita dall'essere meno regolato
di ciascuno dei singoli mercati europei, è stata in seguito sostenuta
dall'essersi trasformato in un mercato più ampio ed efficiente
di ciascuno dei singoli mercati.
Come può evolvere questa situazione?
C'è, da un lato, il modello tedescofederale, che è allo
stesso tempo un modello di stretta integrazione banca-industria, export-led
sia sul piano commerciale che dei capitali (dato il surplus della bilancia
corrente dei pagamenti), e di contenimento della domanda interna per
garantire tutto ciò. C'è, dal lato opposto, il modello
britannico, che al declino dell'attività industriale e all'assenza
di capitali da investire all'estero (una volta venuto meno, negli ultimi
anni, il surplus petrolifero) ha accompagnato una strategia imperniata
sulla specializzazione nei servizi finanziari, per fare di Londra una
"capitale del capitale".
I due modelli sembrano così poco armonizzabili, orchestrabili,
da porre in dubbio la possibilità stessa del "mutuo riconoscimento".
E c'è un evidente dilemma per l'Italia: con quale dei due modelli
ha interesse ad integrarsi? Da quello tedesco ci allontana la nostra
tradizione di "separatezza" tra banca e industria. Ma i legami
commerciali e monetari sono più stretti con la Germania Federale
che con Londra.
Ove questi dovessero prevalere, risulterebbe privilegiato un approccio
più "eurocentrico" rispetto a quello tendenzialmente
internazionale, che ci deriverebbe invece dall'integrazione con il Regno
Unito. Ma forse è proprio questa la chiave di volta dell'integrazione
finanziaria europea: per realizzarla, occorre ridurre il collegamento
con i mercati mondiali.
Integrarsi con Londra, significa integrarsi con Tokio e con New York
(è solo questione di fusi orari), e questo è in un certo
senso alternativo a integrarsi con Parigi, Francoforte, Madrid, Bruxelles
e via dicendo. la pura e semplice liberalizzazione del movimenti di
capitale potrebbe accentuare le forze centrifughe, ciascun Paese aumentando
la sua dipendenza extracomunitaria senza il procedere del l'integrazione
finanziaria tra i Paesi europei.
Ma c'è anche un altro punto di forte contrasto tra l'orientamento
finora prevalso a Bruxelles e quello, ad esempio, della Banca d'Italia.
Il contrasto verte anzitutto sulla definizione di ciò che è
definito "un minimo di armonizzazione" (vale a dire di regole
comunitarie predeterminate per tutti i Paesi della Comunità economica
europea), preliminare al successivo "mutuo riconoscimento"
delle norme nazionali. L'indicazione è che ciò riguarda
solo le norme direttamente rivolte a tutelare la stabilità degli
intermediari, cioè la "vigilanza prudenziale". E quindi
prevedibile che questo "minimo" resti comunque molto inferiore
a quanto la Banca d'Italia avrebbe desiderato, e che ciò determini
conseguenze radicali sul sistema bancario italiano. Basti citare in
proposito quanto è scritto nel "Libro bianco": "Occorre
però anche rendersi conto che vi saranno alcune parti della normativa
bancaria che non verranno armonizzate, per il semplice fatto che un'armonizzazione
è del tutto inutile ai fini di cui sopra. Come esempio di tale
tipo di normativa va citata la separazione del tutto artificiale, per
non dire artificiosa, tra il credito a breve e il credito a medio-lungo
termine esistente in Italia. Detta separazione, completamente obsoleto,
che non esiste in nessun altro Paese della Comunità, né
in nessun altro degli altri Paesi industrializzati fuori della Comunità,
non può fare oggetto di armonizzazione di sorta".
Ciò equivale a riconoscere che quella separazione - alla base
della nostra distinzione tra aziende di credito e istituti speciali
- non potrà più essere imposta, in futuro, ad enti creditizi
dei Paesi della Comunità economica operanti in Italia.
L'elenco dei problemi posti dall'integrazione finanziaria in Europa
è probabilmente molto più lungo di quello considerato
fino a questo momento. Ma già quelli esaminati sono sufficienti
per indicare due conclusioni, persino ovvie: l'obiettivo di realizzare
un mercato finanziario e dei servizi finanziari unico entro il 1992
(e dunque nel brevissimo giro di quattro anni) è molto ambizioso;
le conseguenze che ne deriveranno per il sistema italiano sono enormi.
Certo, è sempre possibile rifugiarsi nell'esperienza del passato,
per concludere che anche questa volta i ritardi ci salveranno. Dopo
tutto, la prima direttiva Cee sul coordinamento bancario, del 1977,
richiese tre anni per essere approvata, e poi l'Italia ottenne dodici
anni di tempo (fino al 15 dicembre 1989) per applicarla. Su queste basi,
anche se la seconda direttiva fosse approvata nel 1988, noi potremmo
aspettare fino alla fine del secolo per renderla operativa! Ma ciò
significherebbe, in questo caso, che l'integrazione finanziaria procederebbe
senza di noi. Assumendo, invece, che si intenda procedere all'integrazione
finanziaria secondo i tempi fissati a Bruxelles, quali sono in sintesi
i costi e i benefici che possiamo attenderci?
Incominciando dagli aspetti positivi, vi è un generale consenso
sul fatto che la creazione di un più ampio mercato finanziario
e dei servizi finanziari porterà con sé i vantaggi dati
da maggior concorrenza: economie di scala, di diversificazione, di specializzazione.
Più che un aumento dei trasferimenti netti di capitali, il risultato
atteso è quindi quello di un aumento di efficienza: la maggior
concorrenza e innovazione dovrebbero dar benefici agli utenti dei servizi
finanziari più che agli intermediari nel loro complesso.
L'Italia, che è notoriamente un Paese ad elevata propensione
al risparmio e con un alto "fabbisogno di intermediazione",
ha tutto da guadagnare da una intermediazione finanziaria più
efficiente. Essendo, inoltre, il Paese europeo che presenta i maggiori
costi operativi unitari, per quanto riguarda le maggiori banche commerciali,
è anche quello che più trarrà beneficio da una
loro riduzione verso la media europea. Questi benefici risulteranno
maggiori con riferimento alle famiglie ed alle piccole imprese, essendo
evidente che le maggiori imprese - ormai divenute multinazionali - hanno
già potuto operare con notevole libertà sui mercati finanziari
internazionali, utilizzando i segmenti più efficienti dei diversi
sistemi bancari. Sempre che l'integrazione non si limiti ai mercati
finanziari (consentendo solo un guadagno in termini di diversificazione
dei portafogli), ma proceda anche a coinvolgere i servizi finanziari
"al dettaglio", che più direttamente riguardano famiglie
e piccole imprese.
Si può aggiungere che questi benefici saranno maggiori qualora
si diffonda (anche qui dal livello delle maggiori imprese, che già
vi ricorrono, ai servizi finanziari "al dettaglio") l'uso
dell'Ecu come unità di conto, mezzo di pagamento, e riserva di
valore. In un certo senso, l'uso di una moneta comune serve a diffondere
vantaggi analoghi a quelli dati dal ricorso ad un "centro finanziario":
come nel caso degli attuali rapporti bilaterali degli undici Paesi della
Cee con Londra (invece dei 66 rapporti che altrimenti si avrebbero fra
ciascuno dei 12 Paesi ed i restanti 11), così il progressivo
ricorso all'Ecu da un iato consente economie di costi e dall'altro ripartisce
fra ciascun Paese il relativo "signoraggio".
Non va inoltre dimenticato che la diffusione a livello europeo di una
moneta alternativa a quelle attualmente prevalenti a livello internazionale
potrebbe introdurre un elemento di "protezionismo implicito"
che favorirà la stessa integrazione finanziaria. Ma il realizzarsi
di questi benefici presuppone una radicale ristrutturazione degli attuali
sistemi finanziari e relativi intermediari, un processo che richiede
di essere "governato" se si vuole che sia ordinato, cioè
proceda in condizioni di stabilità.
La situazione italiana non risulta la più forte in termini di
capacità competitive dei propri intermediari, né presenta
una struttura dell'intermediazione che potrà imporsi come "modello"
degli altri Paesi. Ne deriva che dovrà essere la situazione italiana
ad adeguarsi a quella prevalente nel resto della Comunità economica
europea, e non viceversa.
E altresì prevedibile che la ristrutturazione dei servizi finanziari
proceda secondo una logica gerarchica che vedrà emergere pochi,
grandi gruppi finanziari "europei", cioè in grado di
servire tutti, o quasi, i singoli mercati nazionali (prevalentemente
nel campo dell'intermediazione in titoli, e dei servizi finanziari alle
imprese maggiori), accanto a gruppi finanziari "nazionali"
e a banche regionali, che serviranno mercati (e clienti) più
limitati. Ma a differenza di quanto sta avvenendo negli Stati Uniti
con il graduale superamento dei McFadden Act, del 1927, e quindi con
la creazione di un unico mercato bancario, nel caso europeo non avremo
né apposite norme per regolare questo processo, né la
possibilità di un livello sopranazionale, al quale regolare gli
intermediari "europei". li "memorandum Colonna",
del 1970, con la sua proposta di statuto di "società europea"
sembra del tutto dimenticato a Bruxelles. Mancando questo strumento,
è da prevedere che sarà la politica dei singoli Stati
a garantire, nei prossimi anni, quella selezione (più o meno
darwiniana) che dovrà porre le basi per la successiva "gerarchia
europea".
E anche da questo punto di vista l'attuale situazione italiana appare
inadeguata: stiamo ancora portando avanti una strategia di accorpamento
delle banche locali di minori dimensioni, quando, com'è stato
precisato dalle autorità monetarie, è evidente che al
confronto con gli altri Paesi europei abbiamo bisogno di una concentrazione
delle banche maggiori, per non essere assenti dalla scena delle grandi
"banche europee".
I costi del nostro adeguamento a quanto richiesto da I l'integrazione
finanziaria - se vogliamo evitare il rischio che integrazione significhi
dipendenza - risultano evidenti dal lungo elenco dei temi che dovranno
essere riesaminati nei prossimi anni, dal sistema della riserva obbligatoria
alla specializzazione degli intermediari, dal modus operandi della politica
monetaria al funzionamento dei mercati mobiliari. Da questo punto di
vista, molta parte dei dibattito che in questi anni ha affrontato il
tema della revisione della "legge bancaria", o quello della
regolamentazione degli intermediari nonbancari, o quello della distinzione
fra controlli per "finalità", per "funzioni",
o per "mercato", risulta già datato, perché
privo di una prospettiva europea. Ma soprattutto risulta datato l'approccio
con il quale abbiamo fino a questo momento risposto agli appuntamenti
europei, che è stato sostanzialmente quello di fissare delle
date fino alle quali potevamo ritardare il cambiamento. E' tempo di
rovesciare il nostro modo di usare il calendario, e di incominciare
a stabilire le date entro le quali il cambiamento deve avvenire.
L'Europa cresce
con l'impresa
Per i cultori
del catastrofismo capitalistico sono giorni piuttosto duri: l'economia
non si decide a ripetere i nefasti del dopo-'29, ma, soprattutto,
imprese e imprenditori stanno dando prova di un fermento innovativo
senza precedenti. Nuove tecnologie, nuovi prodotti, nuovi mercati,
nuove società, nuove alleanze, nuove fusioni, nuove acquisizioni
stanno modificando gli equilibri internazionali: quelli geoeconomici,
non meno di quelli geopolitici. èuna trasformazione che i dati
macroeconomici rappresentano solo in parte e che ha l'ambigua caratteristica
sia di agire silenziosamente nel profondo, sia di esplodere clamorosamente
in superficie.
Tanto per fare un esempio, l'annuncio dato alcuni mesi fa, a Parigi,
da Carlo De Benedetti, relativo alla Societé Generale de Belgique
è una di quelle notizie esplosive, la cui valutazione travalica
il dato di natura finanziaria. Che, nel caso specifico, è senz'altro
clamoroso, anche perché proietta la propria efficacia su altri
terreni, da quello produttivo a quello manageriale. Ma che anche,
al di là del caso specifico, conferma alcune verità
di carattere generale sulle quali vale la pena di riflettere.
La prima riguarda la vitalità dell'imprenditoria italiana nel
momento in cui all'impresa si chiede di essere vitale non soltanto
tra le pareti domestiche (magari protette), ma anche sul mercato internazionale,
aperto ai fortissimi venti della concorrenza. Né si tratta
di una vitalità per pochi e magnifici condottieri: questi,
certamente, dominano la scena, fanno notizia, vanno sulle copertine
più prestigiose e illustrano, con la propria immagine, l'immagine
dell'Italia. Dietro di loro si muove, infatti, una schiera di nomi,
meno famosi, ma non per questo meno ricchi di vitalità, che
contribuiscono in maniera determinante alla internazionalizzazione
del nostro sistema produttivo e finanziario. Per valutare appieno
tutto ciò, basta scorrere l'elenco delle principali acquisizioni
estere che negli ultimi tempi hanno avuto come protagoniste imprese
italiane. Olivetti, Banca nazionale del lavoro, Italimpianti, Ifil,
Fidenza V., Fininvest, Montedison, Gft, Sirti, Piaggio, Magneti Marelli,
Iveco, Generali, Candy, Ferruzzi, Nikols, Miroglio, San Paolo, e altre,
hanno acquisito società dei settori software, engineering,
alimentare, del vetro, della Tv, delle telecomunicazioni, bancario,
chimico, elettrico, delle auto e biciclette, assicurativo, della moda
e dell'abbigliamento, ampliando la penetrazione In Germania Federale,
in Francia, in Gran Bretagna, in Belgio, in Canada, negli Stati Uniti
e persino in India.
La seconda verità è che nei comportamenti delle imprese
ha fatto irruzione l'Europa. Nel senso che, pur non rinunciando alla
loro identità nazionale, e spesso, anzi, facendo perno su questa
identità, un numero crescente di imprenditori e di manager
europei non considerano più l'Europa come un'idea alla quale
adattarsi faticosamente, ma come un ambiente ideale nel quale èpossibile
muoversi più agevolmente per crescere e per competere.
Il mito del partner americano come condizione di successo è
ormai tramontato, e ha lasciato il posto al pragmatismo delle alleanze
su progetti concreti. Che negli ultimi due anni si siano costituite
decine e decine di aggregazioni imprenditoriali europee, produttive
o finanziarie, su base sovranazionale, costituisce un fatto nuovo
e di incalcolabile rilievo per il futuro assetto del capitalismo,
sia in Europa sia nelle altre aree avanzate, quella americano e quella
giapponese. Non è detto che tutto questo basti all'Europa per
vincere la sfida; ma certamente rende la sfida più aperta e
dall'esito meno segnato. E nel momento in cui De Benedetti dichiara:
"Il mio obiettivo è la holding europea", riassume
pienamente tanto la realtà nuova, quanto la nuova sfida.
Una terza verità merita allora di farci riflettere: nel processo
di riallocazione degli assetti imprenditoriali europei ci sono protagonisti
e comprimari, ci sono Paesi dinamici e ci sono Paesi (e aree territoriali)
immobili. Contrariamente a tante previsioni, anche nostrane, l'Italia
si è mosso finora tra i primi, meritando addirittura, per profondità
e velocità del mutamento, lo scudetto del dinamismo europeo.
Nuovi assetti proprietari, nuovi raggruppamenti imprenditoriali, espansione
all'estero, sono i tre volti di questo dinamismo che colloca l'Italia
tra le aree portanti del nuovo assetto continentale. Il che non si
può dire, ad esempio, del Belgio. Dove tensioni etniche, debito
pubblico, ma soprattutto intorpidimento economico, agiscono da freno
ad ogni rinnovamento: tanto da far apparire più patetico che
tardivo l'improvviso soprassalto di patriottismo economico che in
gennaio venne suscitato dalla mosso di De Benedetti.
Restano, infine, altre due verità, questa volta amore per il
nostro Paese. La prima, è quella di una classe politica nazionale
irrimediabilmente abituato a vivere, a ragionare e a dibattersi in
un ambito tutto domestico e bottegaio, mentre economia e finanza vivono,
ragionano e competono in un ambito transnazionale. Quanto potrà
ancora durare? E la seconda, quella di un Mezzogiorno ancora lontano
dallo sviluppo dell'Europa. Che sarà del Sud, varcata la soglia
del 1992?
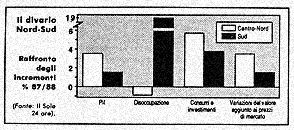
Nord-Sud-Cee
Ultime notizie sul divario
La Calabria al quintultimo posto tra le regioni dei Paesi della Comunità
economica europea: il dato conferma da una parte il relativo progresso
della regione italiana anche per l'entrata nella Cee di nazioni che,
con i loro parametri socio-economici, hanno strappato alla Catabria
il poco invidiabile ruolo di fanalino di coda nella classifica europea.
Spetta, infatti, all'ellenica Tracia il primato di regione più
povera della Comunità, mentre l'olandese Groningen è
in cima alla classifica, con un prodotto interno lordo procapite sei
volte superiore.
Il dato si desume, unitamente a molti altri, dal rapporto preparato
dal vicedirettore generale della Banca d'Italia, Tommaso Padoa Schioppa,
particolarmente dedicato ai problemi e alle strategie volte al rafforzamento
del sistema economico comunitario.
Le 160 regioni dei dodici Paesi della Comunità, cui è
riservato un capitolo dello studio, sono oggetto di una graduatoria
effettuata in termini di Pil pro-capite a parità di potere
d'acquisto. Fatta uguale a 100 la media della Comunità a dodici,
la Tracia registra un valore pari a 43,2, seguita nella "classifica
della povertà" dalle isole dell'Egeo orientale (46,0)
e dalla spagnola Estremadura (46,6).
L'immagine di una Comunità a due velocità è confermata
dai dati del rapporto: le venti regioni "meno favorite"
concentrate infatti nella fascia meridionale della Cee, e dunque nei
territori di Grecia, Portogallo, Spagna e Italia. Oltre alla Calabria,
ne fanno parte anche la Sicilia (con un valore del Pil pro-capite
inferiore del 37 per -cento alla media comunitaria), la Campania,
la Puglia, la Basilicata e il Molise.
Nella graduatoria delle regioni più ricche, alle spalle di
Groningen (237,4), Amburgo occupa il secondo posto, con un valore
pari a 195,5. Seguono, nell'ordine: l'Ile de France (159,4), la regione
della "Grande Londra" e quella tedesca di Darmstadt (l'una
e l'altra con 155,1). Al decimo posto, la prima regione italiana,
la Valle d'Aosta (137,0), che precede la Lombardia (119,0), ventesima
area europea.
Ai dati sul Pil pro-capite, il rapporto affianca quelli sulla disoccupazione
alla fine del 1986: l'Andalusia, con un tasso del 30,2 per cento,
registra la più alta percentuale di "senza lavoro"
fra le regioni della Comunità. Molto elevati sono anche i valori
rilevati in Estremadura (28,6 per cento), nelle Canarie (27,3%) e
nei Paesi Baschi (24,6%). In Italia, la regione con il maggior numero
percentuale di disoccupati risulta essere la Sardegna (19,3 per cento),
seguita dalla Calabria (14,4 per cento).
"I successivi ampliamenti della Comunità - afferma il
rapporto di Padoa Schioppa - hanno reso più acute le disparità
regionali: l'accesso di Grecia, Spagna e Portogallo ha elevato il
Pil del 10 per cento, la popolazione del 22 per cento e l'occupazione
agricola del 57 per cento".
La Seconda
Direttiva Cee Banche Unite d'Europa
Con l'approvazione definitiva da parte della Commissione esecutiva,
la Seconda Direttiva Cee in materia bancaria è entrata in dirittura
d'arrivo, ma non ha ancora concluso il suo complesso iter. Infatti,
mancano altre due approvazioni, compresa quella del Parlamento europeo,
prima del varo definitivo da parte del Consiglio dei ministri.
Non sono pochi coloro i quali ritengono che sia difficile arrivare
alla conclusione entro il 1988 e considerano la prima metà
del 1989 come una scadenza più realistica. A partire da quella
data, incomincerà il conto alla rovescia per l'attuazione vera
e propria. I tempi, in ogni caso, non saranno lunghi. E' quasi ironico
dire che saranno più brevi di quelli previsti dalla Prima Direttiva,
che aveva accordato fino a dodici anni di tempo, ma, si badi, non
per tutta la materia regolata, bensì solo per le norme collegate
al principio del "bisogno economico" come presupposto del
l'autorizzazione.
Sull'Attuazione dell'Atto Unico e sulla data del 1992, la Cee ha puntato
ormai molte delle sue carte politiche e non sarà disposta a
giocarsi una fetta cospicua di credibilità per un ritardo sostanziale
rispetto all'obiettivo, certo ambizioso, del 1993. Se qualche ritardo
ci sarà, può essere stimato in termini di qualche anno,
non di lustri. Dei resto, gli effetti della Prima Direttiva non sono
stati né così limitati né così lenti come
alcuni ritengono. Le legislazioni di tutti i Paesi sono profondamente
cambiate a partire dal 1977, e l'Italia è stata forse quello
che ha modificato in maggior misura i propri criteri di vigilanza:
l'introduzione di coefficienti patrimoniali liberi e il progressivo
allentamento dei controlli all'entrata hanno definitivamente affermato
una vigilanza che (per usare le parole del Governatore della Banca
d'Italia, Carlo Azeglio Ciampi) vuole essere "neutrale rispetto
alle scelte gestionali delle banche".
Proprio grazie all'intensità del processo di trasformazione
che è già avvenuto, i diversi Paesi sembrano oggi più
preparati ad iniziare la fase di integrazione vera e propria. Nel
corso del lungo negoziato che ha portato all'approvazione di gennaio,
molte concessioni sono state fatte da ciascuna delle parti per eliminare
alcuni ostacoli preliminari. Proprio sul filo di lana, l'Italia ha
ottenuto due modifiche importanti, una delle quali (quella relativa
alle società controllate dal parabancario) rende compatibile
l'applicazione della direttiva con la situazione attuale delle banche
italiane.
Per capire la portata della Direttiva, è necessario ricordare
che il principioguida è molto semplice: le banche sono individuate
dallo svolgimento di attività indicate in un'apposita lista
e sono soggette a controlli di vigilanza da parte delle autorità
del Paese d'origine. Sulla base di questo presupposto, potranno cominciare
ad operare da un Paese all'altro con il principio del "mutuo
riconoscimento", vale a dire, potranno operare in altri Paesi
con la propria legislazione.
Come si afferma nella premessa della Direttiva, la Cee completa con
questo documento "l'armonizzazione minima necessaria e sufficiente
per pervenire al reciproco riconoscimento delle autorizzazioni e dei
sistemi di controllo". in un settore per sua natura regolamentato
come quello bancario, il concetto di libera circolazione ha senso
solo all'interno di quadri normativi e di processi di vigilanza sostanzialmente
omogenei. Non a caso il libro Bianco del 1986 indicava per l'integrazione
finanziaria entrambi gli obiettivi, quello del mutuo riconoscimento
e quello dell'armonizzazione delle normative nazionali.
In altre parole, il processo di armonizzazione è appena agli
inizi: la scelta delle autorità è stata quella di non
aspettare tutto il tempo necessario per arrivare a leggi uguali nei
vari Paesi (in pratica, l'eternità), ma di accettare un confronto
con le forze di mercato che si metteranno in movimento il 10 gennaio
1993. La possibilità delle varie banche di operare da un Paese
all'altro modificherà l'attuale equilibrio concorrenziale,
costringerà ciascun intermediario a cercare nuovi prodotti
e nuovi mercati e finirà fatalmente per mettere in risalto
gli ostacoli posti dalle differenze di normativa. Ciascun Paese dovrà
allora adattare progressivamente la propria legislazione, tanto più
rapidamente, quanto maggiore sarà la preoccupazione di non
creare svantaggi concorrenziali alle proprie banche. Le legislazioni
saranno così modificate per seguire e incanalare i processi
di cambiamento realizzati dalle singole banche.
Quanto più le banche si dimostreranno capaci di cogliere le
nuove opportunità, tanto più creeranno pressioni sui
propri ordinamenti e in qualche modo guideranno il processo di convergenza.
Non era mai successo, se si riflette, che gli animai spirits delle
banche fossero così capaci di influire sul quadro normativa.
Naturalmente, non è detto che proprio tutto questo debba verificarsi:
ma le indicazioni che abbiamo ci portano a ritenere che solo gravi
avvenimenti economici e/o politici possono comportare una significativa
deviazione dalla rotta intrapresa. Ne è una prova anche la
decisione con cui si èlavorato a Bruxelles, insieme con il
ruolo propulsivo svolto da alcuni Paesi, a cominciare dall'Italia.
La realizzazione della Seconda Direttiva deve quindi essere considerata
come l'evento più probabile e anche come un risultato di grande
importanza politica. Solo i più rigidi nostalgici del free
banking possono ritenere che liberalizzare i servizi finanziari sia
sinonimo di abolizione di tutti i controlli. La vigilanza sul sistema
bancario Può e deve cambiare, ma in nessun caso può
essere abolita.
Se questo è il significato del processo che abbiamo di fronte,
è meglio non nascondere la testa nella sabbia, affermando che
le trasformazioni per un sistema come quello italiano possono essere
modeste e che le banche straniere non sembrano oggi particolarmente
interessate ai mercati italiani. è vero che non ci sono divisioni
di banchieri che premono alle Alpi in attesa della fatidica liberalizzazione
totale. Non bisogna però dimenticare che, come è successo
per la prima Direttiva, le modificazioni normative che avverranno
avranno l'effetto di cambiare le condizioni concorrenziali fra le
banche italiane e quindi di spostare gli equilibri attuali indipendentemente
dall'ingresso di nuovi (e più concorrenziali) operatori.
In secondo luogo, in tutti i "mercati ai dettaglio", che
sono quelli forse più appetibili oggi per le banche straniere,
le nuove tecniche di distribuzione del prodotti finanziari consentiranno
di entrare riducendo al minimo la presenza fisica sul territorio,
e quindi in tempi più brevi e con costi più contenuti
di quelli richiesti dalle tradizionali forme di insediamento.
Il processo che sta iniziando è dunque ricco di opportunità,
ma anche denso di minacce per chi non capirà rapidamente che
anche i mercati periferici devono essere considerati come un anello
di un sistema sempre più integrato con gli altri sistemi europei.
Rivalutazioni
del Pil E l'Italia prese Il volo
Il Pil, com'è noto, è il prodotto interno lordo, vale
a dire la somma dei beni e dei servizi finali prodotti nel territorio
di una nazione. E' il "peso" economico di un Paese. Ed è
la suo forza, l'immagine, la capacitò contrattuale. Bene. Intorno
a un anno e mezzo fa, venne annunciata dall'Italia la celeberrima
rivalutazione del Pil. Un'operazione di pulizia e di revisione statistica,
com'è stato definita, che sarebbe stato quasi di routine, se
la rivalutazione non si fosse rivelato "di stazza inconsueta"
(intorno al 20 per cento per il Pil 1985 a I costo del fattori), tanto
da provocare un vero e proprio terremoto nel settore delle classifiche
internazionali.
L'Italia era nel gruppo dei Sette maggiori Paesi industriali. Questo
si sapeva, e quasi quasi meravigliava chi era costretto a pagare sempre
più tasse ad uno Stato sempre più vorace. Tant'è
che qualcuno aveva insinuato il ragionevole dubbio che tra i Sette
il nostro Paese si fosse infilato di straforo, un po' per celia, un
pò per non morire. E invece, no! Nel gruppo del Sette c'eravamo
a pieno diritto e titolo. E non riposavamo in fondo alla classifica.
Eravamo sesti, e precedevamo, addirittura, il lontano e immenso Canada.
Dopo la rivalutazione del Pil, l'Italia prese il volo, e diventò
quinta, superando di colpo il Regno Unito. Le classifiche che vennero
fuori, in realtà, erano un poco confuse, perché nel
frattempo la sterlina si era notevolmente svalutata rispetto ai massimi
del 1985. E in ogni caso, nei confronti internazionali, le uniche
classifiche che hanno un senso sono quelle elaborate sulla base delle
cosiddette "parità di potere d'acquisto": sulla base,
cioè, di particolari cambi che rendono omogeneo il livello
dei prezzi di ogni Paese e consentono quindi di tradurre i diversi
redditi nazionali in quei beni reali (burro, macchine, cose, trasporti,
biglietti per il teatro, libri, e via di seguito) che compongono un
altrettanto omogeneo paniere di riferimento.
Il sorpasso dell'United Kingdom, reso agevole nei confronti a cambi
correnti dalla rivalutazione italiana e dalla svalutazione della sterlina,
veniva tuttavia confermato, sia pure con una certa fatica, dal più
significativo confronto sulla base delle parità di potere d'acquisto.
E c'era anche di più. Su quest'ultima base, la Francia era
a portata di mano. Sulla scorta delle previsioni di crescita reale
per il 1987 che si facevano allora, i consuntivi di fine anno avrebbero
dovuto segnare un altro sorpasso: un fatto che venne notato, con sconcerto
malcelato, proprio in un rapporto di una commissione senatoriale francese.
Improvvisamente, siamo caduti in basso, diventando sesti in classifica.
Che cosa è successo? Perché il Pil italiano ci ha ridimensionati
a livello europeo e planetario? Tre fattori chiariscono questa storia:
1) l'economia britannica si è rivelata sia nel 1986 sia nel
1987 più dinamico di quella italiana; è stato sufficiente
mettere a segno nei due anni un punto e mezzo in più di crescita
per superare l'incollatura di vantaggio che avevamo in precedenza;
2) nel frattempo, i francesi non sono rimasti con le mani in mano,
e nel mese di giugno dello scorso anno hanno fatto anch'essi la loro
brava revisione. Non molto, un 2-3 per cento, che però è
stato sufficiente a scongiurare il superamento e a salvare l'onore
gallico;
3) sono state messe a disposizione dei "confrontatori" nuove
parità di potere d'acquisto. La riponderazione dei vari panieri
(consumi privati, consumi pubblici, investimenti, ecc.) dal 1980 al
1985 ha permesso comparazioni più accurate, che tuttavia hanno
relativamente penalizzato il nostro Paese.
Siamo dunque, e per ora irrimediabilmente, sesti. Per riprendere la
scalata, sarò necessario lavorare di più, consumare
di più, esportare di più. E aver fede. Senza lasciarsi
prendere da facili entusiasmi.
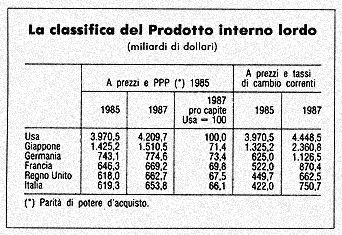
|