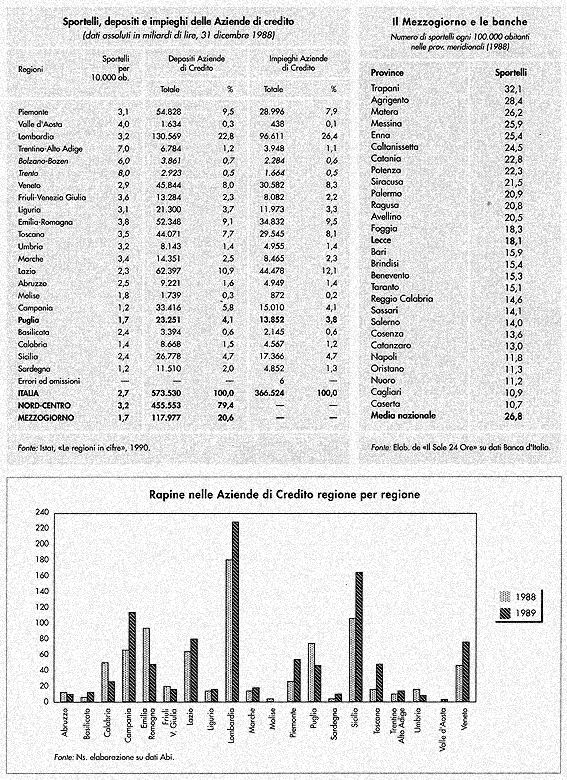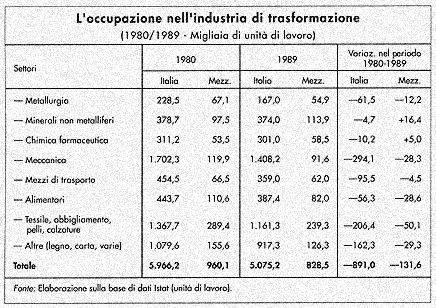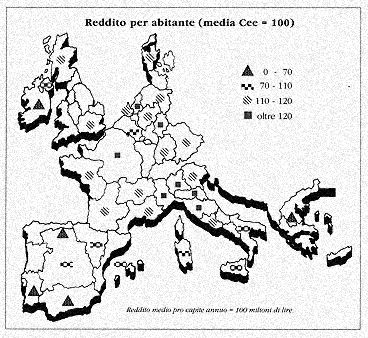L'obiettivo
di una sempre più piena funzionalità del sistema bancario
italiano è oggi più che mai elemento caratterizzante e
fondamento della strategia diretta alla maggiore efficienza dei relativi
servizi. E' un obiettivo valido per tutte le strutture dell'azienda
Italia, anche nell'incombenza della sfida del '93, ma per il comparto
creditizio è assolutamente prioritario, dal momento che dal suo
assetto è condizionato, in via preliminare, lo stesso sviluppo,
nella dimensione e correntezza, delle fonti degli investimenti. I passi
innanzi, in parte compiuti ed in parte in via di svolgimento o di predisposizione,
concernono:
- l'assetto normativo;
- il modello operativo;
- il complesso dei rapporti con l'utenza;
- la sempre più mirata determinazione dei mezzi diretti alla
maggiore efficienza ed anche al superamento delle sacche di inefficienza
o di inadeguatezza che si riscontrano nell'ottica del mercato unico
integrato.
Urgenza di
un assetto più avanzato
Circa il primo aspetto, varie misure amministrative si sono registrate
in quest'ultimo periodo. Esse riguardano la liberalizzazione degli
sportelli, la definizione dei rapporti banche-assicurazioni, la possibilità
per le aziende di credito di partecipare ad attività di merchant
banking, di allungare le scadenze oltre il breve termine, ecc. Su
questa strada il problema è tuttavia molto più vasto,
in quanto alle misure amministrative bisogna affiancare anche quelle
legislative, alle quali oggi si sta lavorando, nella speranza che
il relativo corso abbia una tempestività e una compiutezza
corrispondenti alle necessità da affrontare. Fra le relative
priorità, come ha messo in luce un recente studio dell'ABI,
figurano la regolamentazione dell'intero settore dell'intermediazione
bancaria, la definizione dell'assetto giuridico dei gruppi bancari
polifunzionali, le fusioni fra aziende di credito, l'eliminazione
di vari vincoli che tuttora frenano l'operatività del settore.
L'urgenza delle conseguenti definizioni è sottolineata dal
fatto che, sotto appunto il profilo istituzionale, elementi penalizzanti
per il nostro sistema rispetto a quelli esteri, a cominciare dai Paesi
Cee, limitano il nostro grado di competitività. C'è
in materia il grosso problema della funzionalità degli intermediari
creditizi, che costituisce fonte di svantaggi per le nostre banche
nel quadro europeo; ci sono inoltre misure al tempo stesso a doppio
taglio da mettere meglio a punto (e qui ci si riferisce alla necessaria
tutela dei depositi con i gravami che impone e che, pur migliorando
l'identità degli istituti di credito, tuttavia vanno sempre
meglio calibrati, l'elevatezza della soglia d'ingresso in capitale
per la costituzione di un ente creditizio che offre margini più
larghi per l'applicazione del coefficiente di solvibilità,
ma che indubbiamente richiedono maggiore elasticità); ci sono
regolamentazioni eccessivamente gravose.
Rilevante in questo ambito è il grosso nodo da sciogliere concernente
la riserva obbligatoria. Si tratta per il 1989 di un onere per il
sistema bancario calcolato in circa 6.500 miliardi, derivante dalla
differenza fra la remunerazione della riserva e quella di un investimento
alternativo in titoli di Stato. La conclusione che si può trarre
a tutto questo riguardo, anche nella comparazione con gli altri Paesi,
soprattutto comunitari, è che molte sfaccettature del nostro
sistema non sono ancora in linea con le stesse direttive della Cee
ed alcune di esse hanno origini che risalgono a vari decenni. Tutto
questo mentre il quadro nel quale si svolgono l'economia nel suo complesso
e la stessa struttura creditizia è integralmente mutato, in
termini di dimensione, di avanzamento civile, di maturità,
di capacità tecnologica. E questi sono altrettanti fattori
che non solo devono filtrare nella struttura creditizia, ma da essa
devono far derivare motivi e mezzi di propulsione. Perché,
in effetti, il credito è un avamposto.
Potenziamento
della razionalizzazione
Ma come difendere e far procedere questo avamposto? E che cosa sta
succedendo ed è perseguibile con organicità in questa
direzione? Nel rispondere alla prima domanda, c'è da sottolineare
anzitutto la cessazione dei vincoli del regime delle autorizzazioni
per l'apertura di nuovi sportelli bancari. Secondo i programmi, nel
corso di questi prossimi tre anni il complesso degli sportelli, che
durante il 1989 era di 15.577 unità, dovrebbe aumentare di
circa 5.000 unità. E' questa un'ascesa ineluttabile per il
nostro sistema, dato che attualmente disponiamo di 2,7 sportelli ogni
10 mila abitanti, mentre la Germania Ovest e la Francia ne hanno 6,5,
la Gran Bretagna 4,3, gli Stati Uniti 4,2.
Altro aspetto rilevante del quadro è l'ampliamento progressivo
dell'area bancaria sempre più tecnicizzata e computerizzata.
Fra l'altro, c'è da rilevare il maggiore spazio che si vengono
conquistando il self service, o la personalizzazione del rapporto
con la clientela, o ancora la specializzazione dei servizi. Con la
loro più organica razionalizzazione sarà possibile anche
una riduzione dei costi, conseguente anche ad una migliore utilizzazione
del personale ed in un certo senso anche alla sua possibile riduzione.
Oggi, negli sportelli italiani, anche per il loro numero ridotto,
vi sono per ogni unità in media 23 addetti, contro i termini
della Gran Bretagna, i 14 della Germania già federale, i 16
degli USA ed i 17 della Francia, ecc.
La maggior dinamica conseguibile in questo campo ha a che fare, per
le grandi come per le piccole e medie banche, con le cosiddette filiali
leggere, aperte ad un sempre maggiore ricorso al self service. Le
apparecchiature relative oggi all'interno delle filiali bancarie si
aggirano intorno al migliaio di unità, che secondo qualificate
previsioni saranno presto in grado di raddoppiarsi. Si è partiti,
come è noto, dal Bancomat, le cui operazioni si vengono ampliando
fino a comprendere quelle riguardanti l'erogazione delle pensioni
INPS, ed ora si è giunti anche ad altri tipi di operazioni,
oltre ai prelievi, che riguardano versamenti, interrogazioni varie
e concessioni di fidi preautorizzati, ecc. Si tratta di una nuova
modulazione che si viene svolgendo o predisponendo, a sviluppo delle
ormai trentennali teletrasmissioni dei dati di Borsa da Milano e da
Roma in tempo reale, e ad imitazione di quanto avviene negli altri
Paesi più avanzati, come gli USA, con la comunicazione diretta
casa-banca. Sono traguardi non solo difficili e forse anche in gran
parte da sospirare, ma sono necessariamente dietro l'angolo, in termini
di varietà di operazioni, di capacità di offerta, di
sistemi informativi di marketing, e così via.
Altri spiragli che si dovranno aprire concernono la cosiddetta operazione
"shopping day", degli istituti di credito, con sportelli
sia pure solo settimanalmente aperti per un orario più lungo.
E qui si tratta di un passo europeo che dovrà essere compiuto
anche in Italia, perché in Francia ed in Germania, ad esempio,
già esistono fasce orarie per l'apertura degli sportelli, che
vanno rispettivamente dalle 8.00 alle 18.00 e dalle 8.00 alle 18.30.
Concludendo questa rapida panoramica, si può rilevare che l'ordinamento
in atto nel nostro Paese definisce, con i vincoli fin qui richiamati
e con le ricordate iniziative, l'attitudine bancaria come l'esercizio
congiunto della raccolta di risparmio fra il pubblico e dell'impiego
di fondi in operazioni di credito. Il che è in linea per l'Italia,
come per altri Paesi - Belgio, Lussemburgo, Spagna - con la prima
Direttiva di coordinamento emanata al riguardo dalla Comunità
Nel fondo tuttavia vi sono due altre principali indicazioni. Per qualche
sistema, infatti, e qui ricordiamo Francia e Germania, il nesso fra
raccolta ed impiego non è essenziale per la qualificazione
dell'attività; per qualche altro sistema, come ad esempio quello
britannico, la nozione di attività bancaria è limitata
all'aspetto della raccolta dei fondi; per altri Paesi, infine, c'è
una delimitazione riferita solo ad alcune categorie di aziende ed
è prevista una delimitazione temporale della scadenza dei depositi
e dei fondi rimborsabili. E quest'ultimo caso si riferisce alla Francia,
al Belgio ed all'Olanda.
Quanto all'altra indicazione che si desume dal generale quadro in
atto, va rilevata la tendenza abbastanza diffusa all'istituzione di
una banca cosiddetta universale, alla quale si affiancano altre strutture:
istituti ipotecari, credito specializzato (fra l'altro per l'edilizia),
erogazioni creditizie alle piccole e medie imprese, mutui ipotecari,
ecc. A fronte di questa tendenza, che vede fra l'altro largamente
presente e definita la funzione dell'intermediazione finanziaria,
vi è lo stato di fatto italiano, con ambiti di operatività
che appaiono troppo circoscritti in un contesto che ne indebolisce
competitività e spesso maggiore efficienza, a causa dell'osservanza
di regole alla quale non è sottoposta la concorrenza estera,
tenuto conto che le banche comunitarie, in virtù del principio
del mutuo riconoscimento, possono applicare oltre confine le loro
specifiche normative nazionali.
Una "fratellanza
siamese"
E veniamo ad un aspetto particolare che, rientrando nella tematica
della cosiddetta banca universale sopra richiamata, è oggetto
di un largo dibattito, di precisi indirizzi progettuali, e anche di
critiche e di riserve.
Un punto di riferimento può essere ricavato al riguardo dal
pensiero espresso dal nostro ministro del Tesoro, Carli, che all'interrogativo
su banca universale o gruppo polifunzionale ha risposto di non sapere
quale sistema sia preferibile. "Ciò che occorre - ha detto
- è la garanzia del massimo grado di adattabilità del
sistema finanziario italiano", perché possa esplicare
pienamente la sua attività in concorrenza con le altre strutture
dei Paesi comunitari ed in particolare con l'area forte che si delinea
o è tentata per quanto riguarda, ad esempio, il marco.
Quanto poi al pensiero della Banca d'Italia in materia, esso si può
sintetizzare nei seguenti punti:
- scelta, o meglio propensione, per il gruppo polifunzionale che apre
le maggiori possibilità di riorganizzazione e razionalizzazione
del sistema creditizio.
- ipotesi di accelerazione sulla strada della despecializzazione normativa
delle istituzioni creditizie.
- mantenimento di una separazione fra banche ed imprese finanziarie
(e questa, come si sa, è oggetto di progetti legislativi, fra
l'altro con la legge Amato, approvata da un ramo del Parlamento, sul
cui esame e sul cui andamento rimandiamo il discorso ad altra occasione)
onde evitare "intrecci pericolosi".
Fin qui le posizioni ufficiali. Ma la dialettica al riguardo non manca
di esprimere riserve e critiche in merito alle successive definizioni
della materia. C'è chi osserva che non è solo la scelta
fra banca universale e polifunzionale che può risolvere i problemi
di un sistema che di fatto oggi è distratto da questi due modelli.
C'è ancora chi aggiunge che con la banca universale i rischi
battono i vantaggi. C'è infine chi osserva che la banca universale
èsolo un modello retró. Un punto fermo che intanto sembra
prevalere è quello dell'affermazione del principio dell'indipendenza
delle istituzioni finanziarie, che in un certo senso svolgono la funzione
di guardiani dell'industria. In conseguenza, questa con sue ingerenze
nell'ambito della struttura bancaria verrebbe a controllare i suoi
controllori. Come ha ricordato qualcuno, il problema è quello
di combattere la "mostruosa fratellanza siamese", come ebbe
a chiamarla un grande della storia bancaria italiana, Raffaele Mattioli,
con la sua opera oltre che di banchiere -della Comit - anche di magistero.
Ed era un magistero (chi scrive può ricordare per averlo personalmente
praticato) che non era di parole, ma si affidava solo a fatti e cifre:
gli unici ispiratori rigorosi del suo pensiero.
Sviluppi dell'offerta
bancaria
Due altri aspetti vanno intanto valutati per quanto riguarda gli sviluppi
della possibile offerta bancaria: la stessa strutturazione e la dimensione
del sistema bancario operativo.
In merito all'innovazione organica dell'offerta bancaria, è
da tenere presente - e lo sottolinea uno studio del gruppo San Paolo
- che il ventaglio si allarga, deve allargarsi. Venture capital, merger
e acquisizioni, leveraged buy out, ecc. devono e possono divenire,
nella rispondenza della clientela possibile, termini di sportello,
in funzione di utilizzi di disponibilità che rispondano ai
fabbisogni finanziari delle imprese per acquisire anche apporti di
natura merceologica, di mercato e professionali, utili per rafforzare
la capacità competitiva globale dell'impresa. Malgrado gli
attuali limiti del mercato finanziario italiano, qualche cosa si sta
facendo per favorire il rafforzamento finanziario delle imprese, la
loro ricerca di capitale di rischio. Nel 1988, il nostro mercato finanziario
ha investito l'equivalente di 233 milioni di Ecu per operazioni di
venture capital, classificandosi al quarto posto dopo la Gran Bretagna,
la Francia e l'Olanda. Siamo anche al quarto posto per quanto si riferisce
al totale delle consistenze investite in operazioni di capitale di
rischio, che durante l'anno scorso hanno raggiunto gli 861 milioni
di Ecu. In svolgimento sono inoltre le operazioni di leveraged, management
buy out, quelle di fusione e di acquisizione, di processi di cosiddetta
crescita esterna, di family buy out, ecc.
Il tutto avviene nel quadro di una strategia che per quanto riguarda
attitudini, progettualità, esplicazione da parte del sistema,
si manifesta con la possibile offerta di un capitale dal quale deve
derivare un valore aggiunto nuovo, che deve rafforzare il potenziale
azienda sul mercato, nei contatti internazionali, nelle acquisizioni,
nelle fusioni, nei collegamenti con centri di ricerca e di analisi.
Un profilo particolare acquista in questa dinamica la merchant banking,
la quale sta indirizzando i propri interventi nell'espansione delle
piccole e medie imprese, nella trasformazione del management che tende
a diventare imprenditore, nell'affiancamento o sostituzione di gruppi
familiari, ad interesse aziendale più debole, con gruppi esterni
o della stessa famiglia precedentemente in minoranza. In questa traiettoria
di sviluppo si registrano purtroppo fattori condizionanti e limitativi
che riguardano un sistema fiscale e legislativo non corrispondentemente
mirato e tale da farlo definire dagli operatori il peggiore d'Europa.
Tale cioè da far pensare oggi che operazioni di merchant banking
istruite e concordate in Italia finiscano per realizzarsi al di fuori
del nostro Paese su piazze straniere, soggette a più semplici
e razionali regolamentazioni.
Chiare sono le posizioni di svantaggio che derivano alla nostra economia
ed al nostro sistema creditizio. Su di un piano più specifico,
riguardante fusioni e partecipazioni, ad esempio, i nostri istituti
di credito necessitano della preventiva autorizzazione dell'organo
di vigilanza, mentre in Germania, Gran Bretagna, Lussemburgo e Spagna
queste operazioni sono sottoposte alle stesse disposizioni valide
per i gruppi societari. Circa in ispecie le partecipazioni in istituti
di credito vige una preventiva autorizzazione subordinata al possesso
di alcuni requisiti. Comunque, è questa una materia in merito
alla quale c'è molto cammino da percorrere in termini normativi
e di iniziativa, in un adeguamento sempre più stretto a direttive
e a indirizzi comunitari, taluni dei quali ci trovano ancora in posizioni
di retroguardia. Con la minaccia fra l'altro di una Comunità
a due velocità, che non vogliamo - come si sa - sul terreno
monetario, ma dobbiamo anche non volere in tutto il resto del quadro,
che è a monte di tutto.
Identità
del sistema operativo
E veniamo alla dimensione del sistema operativo. In merito ad essa,
è in corso un dibattito che vede sulla scena chi dice che è
tramontata l'èra del piccolo che è bello, chi afferma
invece che le grandi banche sono alla resa dei conti, chi osserva
che determinate operazioni di interesse, riferito a questo o a quel
tipo di utenza, sfugge volutamente all'attenzione dei grandi istituti,
con riferimento ad esempio al Mezzogiorno, dove si riscontra l'insoddisfazione
per il livello degli impieghi.
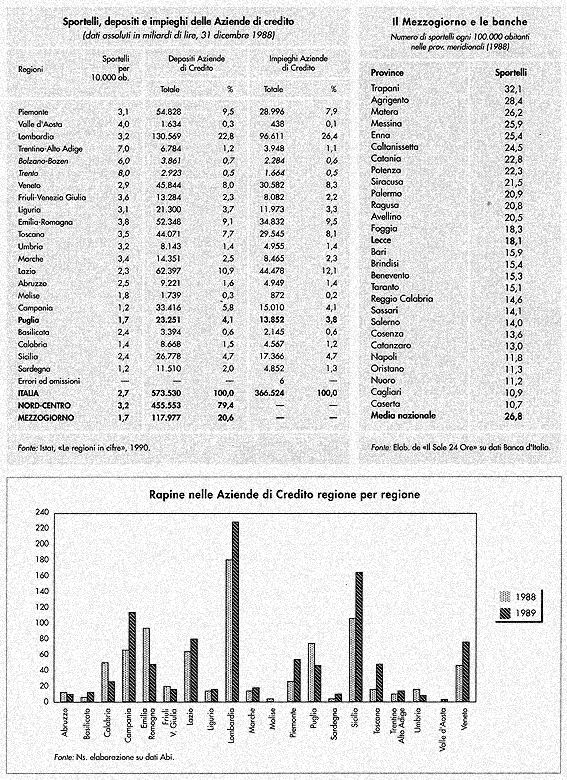
Fra l'altro, una recente indagine della Prometeia ha messo in luce
che se le banche maggiori hanno mediamente riconquistato un po' del
terreno perduto, esso è stato spesso pagato con una compressione
della redditività. E la Prometeia aggiunge che nel confronto
dei risultati relativi al margine di interesse, al margine di intermediazione,
al risultato lordo di gestione, gli istituti medi e piccoli si sono
dimostrati più dinamici. Il discorso può rifarsi anche
a quanto più sopra abbiamo detto a proposito degli sportelli
leggeri.
In effetti, di fronte ad un rapporto fra margine d'interesse e attivo
netto di bilancio pari complessivamente al 4,7%, il valore per le
banche medie si porta al 5,02%, mentre per le banche piccole sale
al 5,13%. Quanto poi al raffronto dei risultati di gestione ci sono
un 1,99% per le banche maggiori, un 2,60% per le banche medie ed un
3,02% per quelle piccole.
Ma a prescindere da questi dati, con riguardo al sistema bancario
minore, c'è da rilevare per esso l'accentuazione della gestione
del cambiamento, constatabile fra l'altro nelle fusioni, negli accordi
di collaborazione, nelle politiche di gruppo e talvolta anche nei
collegamenti già in atto o allo studio. Se ne ricava l'estrema
validità attuale ed in prospettiva degli istituti creditizi
a carattere locale, a cominciare da quelli operanti specie in alcune
aree del Sud, in un ambiente cioè in cui il sistema, oltre
a dover svolgere la normale funzione creditizia, deve incentivare
ed indirizzare, sul piano pure formativo, l'iniziativa ed il suo habitat
economico e culturale.
Taluni discorsi in questa tematica si fermano alla grande dimensione,
cercando di predisporre il terreno nel quale dovranno agire le grandi
banche, pensando fra l'altro a qualche, task force, ma il vero problema
è quello di garantire la massima efficienza di tutto un sistema,
che non può non essere articolato, che non può non essere
fondato se non sul massimo della razionalizzazione, e una risposta
pronta, esauriente, valida alla domanda di un'utenza che molte volte
è addirittura da ricercare e da formare anche culturalmente.
Abbiamo sempre ritenuto che questo aspetto "Culturale",
inteso in tutta l'ampiezza e profondità delle sue radici, debba
essere elemento non secondario della problematica bancaria. Ci sono
già quelli che si muovono, più o meno, in questa direzione,
ma oltre ad aumentare il ritmo bisogna provvedere a maggiori e nuove
forme di collegamento e, se possibile, pure di coordinamento. Circa
i tempi di questi sviluppi, l'anno prossimo - a detta di esperti e
di indagini -dovrebbe essere quello più determinante e comunque
largamente preparatorio delle tappe finali. Questo prossimo traguardo
comincia ad acquisire più precisi connotati in relazione a
quella che sarà la crescita degli sportelli, di cui abbiamo
detto prima. L'attenzione e l'iniziativa al riguardo saranno rivolte
maggiormente ai Comuni di medie dimensioni piuttosto che alle grandi
città.
Due importanti
capitoli
Nell'evoluzione del sistema bancario, quale oggi si viene manifestando
o sollecitando, due altri capitoli si aggiungono ai precedenti: quello
del rapporto e della sua funzionalità fra credito e borsa,
e quello degli scambi con compagnie di assicurazione.
Attualmente nel nostro Paese le banche non hanno accesso diretto in
Borsa. A noi, in questa posizione, si affiancano anche le Borse francesi,
belghe, spagnole, con la differenza però che queste ultime
consentono l'ingresso indiretto delle banche tramite la partecipazione
in società di agenti di cambio. Come osserva il presidente
dell'ABI, è urgente una riforma, in forza della quale gli intermediari
debbono godere di un presidio patrimoniale di tutto rispetto, il campo
degli intermediari non bancari sia sottoposto ad ordine, le partecipazioni
estere siano favorite, la concorrenza diventi più stringente,
i costi dell'intermediazione siano diminuiti. Fra i provvedimenti
di urgenza, si impone poi la riduzione dei tempi della liquidazione
con il ricorso quando necessario ad interventi più tempestivi,
quando la contingenza talvolta grave ne offra la giustificazione o
meglio la necessità. E qui il discorso - si deve aggiungere
- si riporta anche alla Consob, che dopo tutto ha il compito di essere
un buon cordone sanitario, una sorta di pacemaker, attento al ritmo
cardiaco ed a correggere i suoi sbalzi.
Quanto poi agli scambi con le compagnie di assicurazione, essi entro
certi limiti sono ammessi; ora si tratta di mettere meglio a punto
anche questa materia, per la quale qualche cosa sembra muoversi per
quanto attiene agli ingressi esterni privati nella Sace, l'assicurazione
pubblica ai crediti export. Questa struttura deve stabilire il suo
nuovo quadro di riferimento, necessario all'ente per prepararsi ai
mutamenti del mercato interno europeo. L'intervento esterno è
già previsto in analoghi enti assicurativi europei. Il che
è richiesto oltre che dal punto di vista della determinatezza
normativa, anche dall'andamento della Sace, rispetto al quale le banche
estere oggi ci rivolgono l'accusa di procedere agli indennizzi con
il rallentamento, con il pericolo che le procedure messe in atto per
la verifica del relativo diritto all'indennizzo - con la macchinosità
e burocratizzazione perseguite -provochino addirittura una disincentivazione
delle esportazioni. Ed al riguardo si fa appello anche ad una professionalità
da instaurare nelle strutture, che d'altra parte è un tema
incombente su tutte indistintamente le matrici ed i vertici direttivi
ed esecutivi dello sviluppo. Nel bancario, perché è
di questo che stiamo parlando, come negli altri campi.
Questa necessità di più ampio respiro e di un migliore
orizzonte nel quadro bancario viene sollecitata anche dalle banche
estere interessate ad operare in Italia. Attualmente esse ricoprono
una quota inferiore all'1,5% del mercato creditizio, quota che ci
pone all'ultimo posto in una graduatoria internazionale che qualche
anno fa - precisamente nel 1985 - vedeva la Gran Bretagna al primo
posto con un 61%, la Francia al secondo con il 18%, la Germania Federale
al quarto posto con l'8%, la Spagna al quinto posto con il 6%. Qualche
cosa sta cambiando, in forza delle sollecitazioni del 193. Dicono
al riguardo gli operatori del settore che la banca estera in Italia
è più vittima che raider, che essi prendono atto con
soddisfazione dell'atteggiamento di disponibilità della Banca
d'Italia (i provvedimenti più penalizzanti, come la ritenuta
d'acconto sulle operazioni interbancarie, vengono da altre fonti,
mentre le recenti proposte di modifica della disciplina della riserva
obbligatoria costituiscono solo l'ultimo esempio di questo spirito
di collaborazione), ma che non possono sottacere l'estrema pesantezza
dei vincoli in atto che deprimono la redditività dell'attività
di intermediazione, con le chiare conseguenze che ne derivano per
un Paese che pure è fra i sette Paesi maggiormente avanzati
ed ha nella bilancia valutaria, con rilevante componentedella partecipazione
dei capitali esteri, un cardine essenziale da non perdere mai d'occhio
nei condizionamenti che direttamente o indirettamente l'influenzano.
La trasparenza
E veniamo ad un punto chiave di tutto questo discorso: la trasparenza
dei rapporti fra banche e clientela. Per quanto riguarda l'Italia,
la base normativa sta seguendo due rotte, e cioè quella dell'autoregolamentazione
e l'altra legislativa.
La prima, che si fonda sull'accordo dell'ABI in vigore dal dicembre
del 1988, prevede l'obbligo di esporre negli albi delle banche un
cartello con le condizioni minime e massime praticate. I rapporti
in concreto che ne derivano sono regolati su base contrattuale, con
le predeterminazioni di fondo derivanti dal codice di autoregolamentazione.
La fonte legislativa, invece, ha a che fare con una proposta di legge
di iniziativa parlamentare, attualmente in discussione alla Camera,
in forza della quale è fatto obbligo agli istituti di credito
di rendere noti i costi e le condizioni reali praticati per le singole
operazioni e sono previste garanzie specifiche per i piccoli risparmiatori,
fra i quali l'aggiornamento obbligatorio dei tassi passivi, quando
salgono gli attivi, e l'automaticità per i conti con i rendimenti
minimi. Su questa linea sono in corso ulteriori approfondimenti che
affrontano gli altri possibili passi innanzi da compiere in merito
all'informativa dell'utenza, al diritto di fruizione di un grado minimo
di servizi bancari (life line banking), il livello dei tassi d'interesse,
delle commissioni, dei costi e dei rendimenti effettivi, le implicazioni
giuridiche dell'adozione di sistemi elettronici di pagamento, le forme
di pubblicità dei prodotti di risparmio, le modalità
di promozione e di vendita a domicilio, le tematiche specifiche di
taluni contesti.
Tutta questa tematica si lega anche a quanto è previsto o si
prevede per il mercato mobiliare con la riforma della Consob, di cui
prima si è detto ed in merito alla quale numerose sono le leggi,
all'attenzione del Parlamento, relative a funzioni nuove o diverse
dell'istituto, con l'intento di adeguarne il funzionamento ai compiti
nuovi derivanti dall'evoluzione in atto nel mercato ed anche ai ritardi
del nostro ordinamento.
Gli sbocchi possibili riguardano oltre che la funzione di trasparenza
(e cioè la completezza delle informazioni), quella dell'ampliamento
del suo grado di tutela e cioè di protezione del risparmiatore.
Rispetto delle regole del gioco da una parte, dunque, e autorità
di settore dall'altra, con la necessaria latitudine di competenze
e strumenti. E' questa tutta una materia in corso di dibattito teorico
e pratico, che comporta altri corollari, concernenti l'attrezzatura
e la funzionalità dei servizi indispensabili, l'alternativa
fra la sottoposizione dell'istituto al ministero del Tesoro o la sua
elevazione a livello di magistratura, accentuandone l'autonomia. Obiettivo
del nuovo presidente dell'istituto è quello di dare trasparenza
ed efficienza al mercato e far sì al tempo stesso che la difesa
piena del risparmiatore non sia soltanto uno slogan. Si tratta, come
si vede, di un finalismo ancora da meglio tradurre in norme ed in
prassi, che poi direttamente o indirettamente vengono a riflettersi
ed a coinvolgere anche il quadro bancario. E su questo quadro, bisogna
aggiungere, si vengono inserendo vari ed importanti provvedimenti,
che oltre a riguardare la Consob e le materie di cui abbiamo detto
prima, concernono il disegno di legge sulle SIM, il disegno di legge
sulla regolamentazione delle offerte pubbliche di acquisto, la repressione
dell'insider trading, la regolamentazione dell'intermediazione mobiliare,
le banche popolari, ecc.
Spingendo lo sguardo oltre l'angolazione nazionale, e cioè
approfondendo l'esame alla situazione in atto negli altri Paesi comunitari,
ne risulta che per quanto attiene agli specifici rapporti fra banche
e clientela, ferma restando la generalizzazione del fondamento contrattuale,
in Germania, la legge sui contratti tipo stabilisce alcuni requisiti
generali di correttezza e, trasparenza; in Francia sono imposti alcuni
obblighi o divieti nella tenuta dei conti; in Olanda opera un accordo
volontario, stipulato fra le banche, che non riguarda commissioni
e spese dei servizi; in Spagna vigono regole di pubblicità
e di trasparenza delle condizioni per aziende di credito, banche popolari
e casse di risparmio; in Gran Bretagna sono obbligatorie comunicazioni
su condizioni e costi delle operazioni e le pubblicizzazioni sui giornali
delle variazioni relative ai tassi attivi, ecc.
Fermiamoci appunto sui tassi attivi. Attualmente, nel quadro comunitario,
tassi e condizioni sono lasciati quasi sempre alle regole della concorrenza,
con precisazioni in determinati ambiti. In Francia, per esempio, vi
è una scala di tassi amministrati per alcuni tipi di depositi
di risparmio popolare ed i libretti di assegni sono gratuiti per legge.
In Olanda, sono fissati tassi massimi per il credito al consumo. In
Gran Bretagna, per i prestiti al di sotto delle 3.500 sterline che
riguardano la clientela minore, sono previste informazioni più
dettagliate ed anche il metodo di calcolo del costo del credito è
stabilito per legge. E' da notare che per questo Paese esiste una
tradizione di interventi che spesso ha un'origine lontana e comunque
il più delle volte in anticipo sui recepimenti in materia intervenuti
negli altri Paesi in merito appunto alla trasparenza. Per noi, ad
esempio, le forme di autoregolamentazione risalgono a meno di due
anni; per la Gran Bretagna bisogna rifarsi al Consumer Credit Act,
stipulato tre lustri fa.
Ma prima di considerare i riflessi che la materia sta registrando
e può esercitare in Italia, vediamo quale è il quadro
che ci offrono gli Stati Uniti. Orbene, in essi i principii generali
relativi alla trasparenza delle operazioni bancarie sono contenuti
nel "The truth in lending and fair credit reporting" del
1969. La legge fa parte delle norme complessive del Consumer Credit
Act. Essa prevede che devono essere comunicati alla clientela interessi,
commissioni, parcelle ed eventuali premi assicurativi sia in valore
assoluto sia in percentuale del credito concesso. Regolamentate sono
anche le modalità di esposizione dei cartelli pubblicitari.
La disciplina in atto affronta anche il diritto di recesso ed il complesso
di regole per l'uso delle carte di credito, a fronte di un loro utilizzo
che è assolutamente preminente nella vita economica e civile
americana. Sono invece esclusi dalle norme di tutela i crediti superiori
ai 25 mila dollari non garantiti da ipoteche.
Ed ora passiamo all'Italia, in aggiunta a quanto abbiamo detto più
innanzi. Gli indirizzi emergenti non prevederebbero interventi specifici
e dettagliati sul piano legislativo, ma obblighi generali da inserire
in una legge quadro, lasciando poi alle banche ed agli accordi settoriali
la messa a punto delle modalità per l'applicazione pratica
delle direttive in materia di trasparenza e tutela del cliente. In
sostanza, si intenderebbe seguire la linea maggiormente praticata
fuori dei nostri confini e di cui abbiamo detto prima, e cioè
quella di un intervento di principio, con il quale la trasparenza
è regolata per legge, ma applicata appunto in via di principio,
lasciando poi alle autorità monetarie la possibilità
di intervenire ed invitando le associazioni di categoria a dare direttive
a tutto il sistema.
Non mancano tuttavia proposte e sollecitazioni, per lo più
parlamentari, per l'obbligo per le banche dell'applicazione automatica
nella misura del 50% delle variazioni in aumento del tasso minimo,
per le operazioni di credito sui depositi a risparmio a tempo determinato
che beneficiano di un tasso di interesse non superiore di due punti
percentuali a quello minimo o per l'applicazione nel caso di tassi,
prezzi e condizioni più sfavorevoli rispetto a quelle indicate
nei cartelli, di tassi invece corrispondenti a quello nominale minimo
e massimo dei Bot emessi nei due mesi precedenti, rispettivamente
per le operazioni attive e per quelle passive. Altra proposta concerne
l'invarianza, nei contratti di risparmio in senso sfavorevole ai clienti,
dei tassi e di altre condizioni, salvo previa comunicazione e con
la facoltà per i clienti di recedere dal contratto senza penalità.
La strada della legge di riforma bancaria è dunque anche sotto
questo aspetto molto complessa e difficile, e l'assetto di tutta questa
delicata materia rischia di incontrare tempi lunghi, a fronte di un'evoluzione
reale del sistema che procede in fretta ed è sollecitata pure
dalla sfida del '93, con un nostro apparato specifico che non si può
dire certamente di punta nel confronto con i Paesi più avanzati.
Comunque, il sistema sta spingendo al massimo l'acceleratore, facendo
leva anche sulla professionalità a tutti i livelli del fattore
umano di cui dispone e dal quale sta raccogliendo frutti, esperienze,
impulsi, ritenendo i vari traguardi di questa formazione interna altrettanti
gradini per il continuo conseguimento dell'efficienza.
In realtà a questo fine è in atto una strategia, che
è sempre da attuare su basi nuove, cominciando nel percorso
da effettuare subito. Come ha detto argutamente qualcuno, da ieri.
Che poi è ieri e domani anche delle banche.
L'inchiesta
/ prospettiva Europea
Quale Mezzogiorno
M.C. Milo,
A. Foresi, G. Salerno
La guerra del
Golfo persico ha scaricato i suoi effetti negativi sulle aree più
deboli delle nazioni industriali. I timori, che erano ben presenti
in alcune zone della Comunità europea, e soprattutto nel Sud
d'Italia, una volta tradotti in realtà, si sono proiettati
ai nostri giorni. In aggiunta, il Sud era alla vigilia di scelte di
politica industriale e di strategie strutturali che, rappresentando
un deciso mutamento rispetto al passato, avrebbero richiesto invece
una stabilità dei mercati molto più certa di quella
che è stata sconvolta.
Le nuove realtà emerse rendono ancora più problematico
un giudizio sulle nuove direttrici di intervento che le grandi imprese,
con in testa quelle che fanno capo all'arcipelago delle Partecipazioni
Statali, avevano messo a fuoco. in concreto, si stava facendo strada
la convinzione che l'ulteriore sviluppo del Sud andava decisamente
legato "alla creazione di quelle condizioni di base, oggi ampiamente
carenti, in grado di trasformare il Mezzogiorno in un'area effettivamente
europea che possa attirare e rendere convenienti gli insediamenti
produttivi italiani e internazionali".
Si trattava quindi di riqualificare gli interventi nell'area meridionale
attraverso il ricorso a infrastrutture "mirate" che l'Iri
riassumeva in cinque priorità: gestione integrata delle acque;
compimento delle grandi reti di trasporto; potenziamento delle telecomunicazioni;
formazione di imprenditorialità e, attraverso una Mediobanca
per il Sud, creazione di un agile sistema finanziario di supporto
alle imprese.
Come aveva valutato queste prospettive l'imprenditoria privata? Antonio
Urcioli, consigliere della Confindustria per il Mezzogiorno, aveva
affermato che "questo indirizzo ci può soddisfare se significa
anche una nuova politica dello "stare insieme" tra grandi
e piccoli gruppi che riesca a trasformarsi anche in una politica di
promozione per la quantità di cultura d'impresa che riuscirà
a distribuire, per le possibilità di inserimento sui grandi
mercati che offre, per le opportunità di crescita che le aziende
minori avranno a portata di mano". E aggiungeva: "Il piccolo
mondo imprenditoriale meridionale parteciperà con piena adesione
a questo indirizzo se esso si tradurrà in una vera politica
di completo abbandono dei vecchi interventi a pioggia".
Questa nuova funzione dei grandi gruppi piaceva anche ad Andrea Saba,
presidente dello Iasm, l'Istituto di assistenza allo sviluppo del
Mezzogiorno da sempre attento, per le sue stesse funzioni, ai cambiamenti
dell'imprenditoria meridionale. Diceva Saba: "Tutte le nostre
inchieste sulle potenzialità del Sud come area in cui investire
hanno messo in luce la debolezza delle strutture a sostegno dell'impresa.
In questo vuoto gioca un capitolo a parte la produzione di servizi
innovativi. Le Partecipazioni Statali possono svolgere un ruolo nuovo
e di primissima utilità proprio in questo campo". Per
Saba, le vie da percorrere "passano attraverso la creazione di
consorzi di ricerca", con l'azione di supporto alle Regioni per
riempire di contenuti progettuali i grandi programmi che la Comunità
europea intendeva finanziare in futuro: "Ma vi è di più:
le grandi aziende possono porre sistematicamente in essere joint-ventures
con imprese straniere portatrici di innovazione. La formula vincente
potrebbe proprio essere quella che vede una stretta collaborazione
tra Partecipazioni Statali, Comunità europea, Regioni e Ricerca
universitaria".
Ma c'era anche chi avanzava riserve verso questo scenario: esponenti
di vertice dell'Agenzia per il Sud, l'ente che, in passato, aveva
operato proprio nel campo delle grandi infrastrutture; e anche settori
del mondo sindacale. Le obiezioni: "I grandi gruppi, soprattutto
se pubblici, devono continuare ad agire come imprese. Il loro ruolo
imprenditoriale non può essere confuso con quello istituzionale
legato alle infrastrutture. E per ruolo imprenditoriale si intende
la loro presenza nella realizzazione di quelle dimensioni produttive
essenziali, anche per il Mezzogiorno, per un efficace inserimento
di quest'area nei mercati globali che caratterizzano l'attuale fase
economica". E i sindacati, sulla stessa lunghezza d'onda: "Il
rischio è che le Partecipazioni Statali siano portate ad accentuare
una loro presenza nel terziario con un conseguente progressivo abbandono
delle attività manifatturiere nelle regioni meridionali. Si
ritiene, invece, che senza una forte presenza industriale sia delle
imprese pubbliche sia dei grandi gruppi privati la piccola e media
imprenditorialità meridionale che sta finalmente emergendo
rischi di rifluire nelle forme artigianali dalle quali è partita".
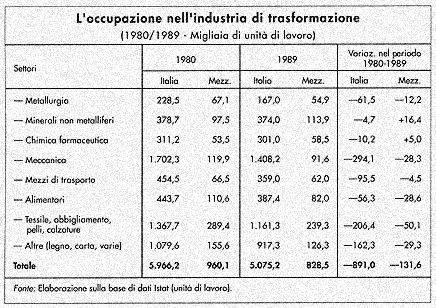
La parola alle
cifre. Per la prima volta, più del 50 per cento del recupero
di occupazione industriale manifatturiera nazionale degli ultimi anni
(1988-'90) veniva dal Mezzogiorno. Per la prima volta, dopo anni di
crescita, le prime rilevazioni Istat delle forze lavoro (gennaio-aprile)
mostravano un calo apprezzabile (circa due punti) nel tasso di disoccupazione
meridionale. Per la prima volta, gli investimenti in macchine e attrezzature
erano aumentati nel Sud dell'11 per cento, a ritmi doppi, cioè,
rispetto al Centro-Nord (5,5 per cento).
E tutto questo avveniva in condizioni sotto molti aspetti negative:
criminalità organizzata sempre più attiva; infrastrutture
civili e sociali sempre più lontane da standard accettabili;
e soprattutto la cessazione di fatto dell'intervento straordinario
(con l'avvio faticoso della legge 64) che a partire dall'84 e fino
all'88 aveva già più che dimezzato l'intervento diretto
a sostegno di investimenti e di occupazione industriale nel Mezzogiorno.
Nelle otto regioni meridionali gli interventi agevolati avevano determinato
occupazione manifatturiera per 23 mila addetti l'anno nel quinquennio
1979-'83 e per soli 10 mila l'anno nel quinquennio successivo.
Allora non era vero che l'industria meridionale si presentava assai
debole agli appuntamenti storici del 1993? Tutt'altro! La struttura
industriale meridionale era debolissima, malgrado i "successi"
delle piccole e medie imprese e della nuova imprenditoria. Il fatto
è che fra le analisi correnti sulla situazione meridionale,
anche le più autorevoli peccavano di una sottovalutazione degli
sforzi che la nuova imprenditoria meridionale stava facendo per evitare
il collasso della debole struttura industriale del Sud. Corollario
di questa tesi è che sbagliavano quanti, collegando i dati
"macro" (sicuramente negativi) dell'ultimo decennio - l'industria
meridionale aveva perso peso sul totale nazionale - al sistema di
agevolazioni in atto, mettevano quest'ultimo sotto accusa, senza calcolare
gli errori del passato, la crisi delle industrie di base, la forte
diminuzione del flusso di incentivi a partire dal 1984, e così
via.
Dopo la crisi del Golfo, tutto va rivisto. Compresi gli incentivi,
che vanno modificati, ma con tempi e modi che non annullino quanto
di buono e di nuovo può verificarsi nelle regioni meridionali.
Da un lato, il livello delle infrastrutture civili ed economiche va
avvicinato a quello del Centro-Nord (e qui èl'intervento ordinario
che deve attivarsi); dall'altro, il peso degli incentivi diretti va
gradualmente spostato dagli investimenti fisici agli investimenti
"immateriali".
Bastano pochi dati per indicare la debolezza dell'industria meridionale:
- la quota di produzione industriale del Mezzogiorno è in calo
da almeno dieci anni, ma con un forte spostamento dalle grandi imprese
alle piccole e medie imprese;
- l'export meridionale di merci è anch'esso in calo continuo:
in quattro anni ha perso tre punti;
- le importazioni nette di "beni e servizi" sono in costante
crescita: il deficit corrente è pari al 21 per cento del Prodotto
interno lordo meridionale, sicché il Mezzogiorno risulta la
regione europea più dipendente dall'esterno.
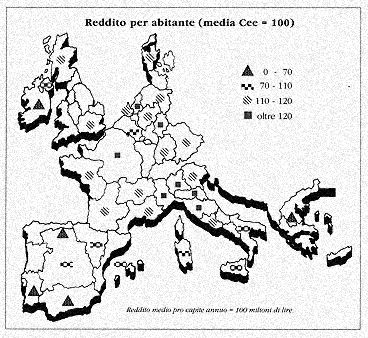
L'unico segnale positivo è che da tre anni (1988-'90) l'occupazione
industriale meridionale segna una ripresa in percentuale superiore
al Centro-Nord: ma non quale potrebbe essere, se venissero sfruttate
più intensamente le potenzialità meridionali. E poi:
per trasformare questi timidi segnali positivi in strutturale inversione
di tendenze storiche non si devono commettere errori di analisi, di
valutazione e di decisioni.
Per quasi vent'anni, il 70 per cento degli incentivi meridionali sono
stati appannaggio delle industrie di base (acciaio e petrolchimica)
perché l'Italia politica e industriale aveva deciso che era
giusto "modernizzare" tali settori, e lo aveva fatto con
i quattrini destinati al Mezzogiorno. Senza entrare nel merito di
quelle scelte - sulle quali abbiamo obiettato in anni non sospetti
- è successo che la crisi internazionale delle industrie di
base e la ristrutturazione delle industrie mature (cantieristica,
tessile, alimentare tradizionale) ha colpito il Mezzogiorno assai
più del Centro e del Nord: le perdite di alcune migliaia di
miliardi di valore aggiunto (circa il 20 per cento del valore aggiunto
manifatturiero meridionale) e di circa 200 mila occupati in imprese
di questi settori (indotto compreso) non vengono quasi mai considerate
nelle analisi sull'attuale debolezza dell'industria meridionale. Così
facendo, le analisi aggregate non mettono in giusta luce l'unico fenomeno
positivo recente, la vitalità imprenditoriale meridionale,
cui si deve la sostanziale tenuta, anzi la modernizzazione di un tessuto
industriale che appena dieci anni fa era malato di "gigantismo",
ma di un gigantismo dai piedi d'argilla; o era addirittura inesistente.
Si deve infatti ascrivere all'imprenditoria locale il fatto che:
- la ristrutturazione industriale della fine degli anni '70 e fine
anni '80 è stata assorbita dal Sud forse meglio che dal Nord;
il Centro-Nord, infatti, ha perso nel decennio il 15,2 per cento dell'occupazione
manifatturiera, contro il 13,8 per cento del Sud, malgrado acciaio,
petrolchimica, cantieristica pesassero più al Sud che al Nord.
Come si può vedere dalla tabella (ultime due colonne), la migliore
tenuta del Mezzogiorno (ad opera soprattutto della piccola e media
impresa) risalta in tutti i settori - anche nella chimica, dove le
perdite dei prodotti di base sono state più che compensate
da un fiorire di piccole e medie imprese nella chimica secondaria
- ad eccezione dell'alimentare, unico settore che ha accumulato nel
decennio più del 50 per cento delle perdite nazionali ( circa
30 mila accupati persi, su un totale di 56 mila persi in tutto il
Paese), ed unico settore da considerare nel Mezzogiorno in grave crisi
strutturale e per cui sempre più urgente appare il bisogno
di interventi strategici puntuali ed organici;
- la ripresa occupazionale industriale iniziata nell'88 e che tuttora
sembra continuare viene per il 50 per cento dal Sud (che pesa solo
il 16 per cento sull'occupazione industriale nazionale): infatti,
al 4 per cento circa di tasso di crescita netta di nuove imprese al
Centro e al Nord, il Sud risponde da anni con un saggio del 6 per
cento;
- sulla base dei dati disponibili, si può ragionevolmente stimare
che la riduzione di 130 mila occupati manifatturieri nel Sud tra l'80
e 1189 (si veda l'ultima colonna della tabella, a pag. 36) sia dovuta:
a) alle perdite delle grandi imprese dei settori di base (metallurgia
e chimica) e maturi (tessili, alimentari, cantieristica, ecc.) e del
relativo indotto per circa 200 mila unità;
b) a ristrutturazioni di piccole e medie imprese di altri settori,
per altre 130 mila unità;
c) queste perdite sono state in parte compensate dalla creazione di
più di 200 posti per addetti a piccole e medie imprese, di
cui solo due terzi con interventi agevolati.
La debolezza strutturale dell'industria di trasformazione meridionale
è un dato innegabile cui va data assoluta priorità nelle
politiche regionali nazionali e comunitaria. Queste politiche vanno
modernizzate, ma non stravolte, e tanto meno cancellate, come analisi
affrettate e rozze sui loro effetti pretenderebbero. Ad esempio, la
pretesa di Bruxelles (Direzione Concorrenza della Commissione) di
escludere dalle agevolazioni quei territori meridionali il cui sviluppo
industriale ha assunto di recente un andamento più vivace che
nel resto dell'area (e cioè regioni come Abruzzo e Puglia)
è da rigettare con fermezza. La giusta esigenza di graduare
gli incentivi all'interno del Mezzogiorno tra regioni più o
meno sviluppate non va confusa con una applicazione schematica ed
erratica del sistema di incentivi o, peggio, con un'applicazione punitiva
proprio verso quegli "embrioni", di "sviluppo autopropulsivo"
che aspettiamo da oltre quarant'anni e che cominciamo forse ad avere
in qualche arca limitata del Sud. L'obiettivo dev'essere quello di
estendere le aree di successo, e non di spegnerne gli stimoli vitali
e, si auspica, diffusivi.
Così come, dopo la crisi medio-orientale, va fatto un doppio
sforzo per evitare che questa nuova vitalità imprenditoriale
abortisca sul nascere: da un lato, un impegno più continuo
dello Stato e dell'intervento ordinario nel miglioramento delle infrastrutture
vitali per la vita sociale ed economica, come la scuola, i trasporti,
le comunicazioni, la sanità, l'ordine pubblico e la giustizia;
dall'altro, un'attenzione maggiore del sistema agevolato verso i cosiddetti
investimenti immateriali delle imprese.
Oggi, l'impresa moderna deve investire sempre più in formazione,
ricerca, software, marketing, controllo e certificazione qualità,
servizi avanzati di ogni tipo, se vuole competere sui mercati internazionali,
e un sistema moderno di agevolazioni allo sviluppo deve trovare i
modi per spostare gradualmente il peso degli aiuti dagli investimenti
materiali a quelli immateriali. Altre uscite di sicurezza non ci sono.
Una cento mille
mafie
Palazzi da
novanta
Aldo Bello
La tragedia del
Sud continua e si aggrava, mentre lo Stato non riesce ad annientare
- e nemmeno a contenere - il cartello del crimine organizzato. La
società e l'economia meridionali talvolta sembrano scivolare
verso una situazione ove grandi patrimoni di civiltà e di risorse
umane finiranno travolti da una criminalità di stampo colombiano.
In tale situazione, ogni componente della società va riesaminata;
e, tra queste, non ultima, quella economica. Forse è stato
il "mancato sviluppo economico" a generare eventi perversi
di questo tipo? O è stata, al contrario, la "crescita
del benessere" legata ai trasferimenti pubblici? Due domande,
che spesso diventano tesi mal poste, sulle quali è opportuno
soffermarsi.
Osservando i livelli di reddito, è evidente che il Sud ha avuto,
nel corso del periodo post-bellico, una notevole crescita. Il suo
reddito pro capite si è triplicato e attualmente è pari
a quello del Centro-Nord degli anni Sessanta. Nello stesso periodo,
la struttura settoriale si èprofondamente modificata con l'occupazione
agricola passata dal 53 al 17 per cento, mentre quella nei servizi
vendibili è ora al 40 per cento. Molto cresciute anche le infrastrutture.
Ma il divario col Centro-Nord è rimasto molto ampio; sotto
alcuni aspetti è addirittura aumentato negli anni Ottanta.
Posto così uguale a 100 l'indicatore di prodotto per abitante
della Cee, mentre il nostro Centro-Nord raggiunge il livello di 123,7
il Sud è a quota 70,7. Malgrado la dimensione del divario (cialtronescamente
ignorato dai lamentosi profeti del separatismo legaiolo), non siamo
sulla linea del dramma, perché il Sud è in posizioni
contigue a quelle della Spagna, e sta molto meglio dell'Irlanda, del
Portogallo e della Grecia.
La vera, grande anomalia del Sud viene dall'occupazione. Il tasso
di disoccupazione è quasi raddoppiato in meno di dieci anni,
e ora si avvicina al 23 per cento, contro il 7 per cento circa del
Centro-Nord. Per le previsioni nel 2000, la popolazione in età
lavorativa aumenterà di 850 mila unità nel Sud, a fronte
di un calo di 900 mila unità nel Centro-Nord. Se si aggiungono
la forte disoccupazione giovanile, un'ulteriore espulsione di addetti
dall'agricoltura, il massiccio afflusso di nord-africani, ci si rende
conto di come la situazione attuale e le prospettive siano tutt'altro
che esaltanti.
Dalle precedenti contraddizioni tra livelli di reddito e disoccupazione
emerge l'evidente necessità di riesaminare le politiche per
il Sud e i grandi trasferimenti di fondi pubblici. Due le specifiche
discrasie. La prima è la bassa quota di occupati nell'industria
(sulla popolazione) che nel Mezzogiorno e pari al 36 per cento della
media Cee, contro il 46 per cento del Centro-Sud della Spagna, il
65 per cento dell'Irlanda, il 79 per cento della Grecia, il 110 per
cento del Portogallo, tutte aree con un reddito medio pro capite più
basso del Sud d'Italia. Carente è quindi anche la cultura organizzativa
tecnico-industriale. La seconda, che consegue alla prima, è
dunque che i grandi trasferimenti di fondi pubblici sono andati a
sostenere in prevalenza i redditi e la domanda (determinando quindi
anche forti importazioni dalle industrie del Nord) piuttosto che la
produzione industriale locale. La conclusione è una: il problema
del Sud non riguarda certo oggi le risorse finanziarie, ma la loro
peggiorata destinazione. Si deve prendere atto che a fronte di eccellenti
gruppi dirigenti che operano secondo le leggi e il mercato, ne sono
esplosi altri interamente volti ad ottenere fondi statali e sussidi
improduttivi in un intreccio clientelare con tragiche contiguità
alla delinquenza professionale dove opera anche una parte dei disoccupati.
Così, i molti sacrifici dei meridionali (servitori dello Stato
ed emigrati, ceti produttivi e accademici di alta levatura), l'impegno
dei fondi pubblici e dei contribuenti, non serviranno a molto, finché
lo Stato, rifondando anche se stesso, non avrà spazzato via
l'intreccio criminal-clientelare. Ma lo vogliono realmente, tutto
questo, i Palazzi da novanta?
Una volta o l'altra dovremo pur cercare di spiegare a noi stessi perché
l'Italia del dopoguerra è la nazione europea con più
"emergenze", quella che ha avuto - ed ha - più misteri
irrisolti, più stragi, più terrorismo, più criminalità
organizzata, più scandali. E il Paese nel quale si gode di
più impunità. Le spiegazioni date finora sono state
parziali e viziate. E tuttavia, il momento di una spietata esplorazione
morale e sociale sembra essere ancora lontano. Sull'attuale società
italiana si è solidificato un sistema di potere, produttore
di ricchezze e di benessere, in condizioni di resistere quasi a tutto,
e soprattutto all'esigenza di analizzare con sincerità le cause
culturali e storiche della situazione attuale.
L'Italia "moderna" ha poco meno di un secolo di vita. L'unificazione,
con la conquista del Regno del Sud, non soddisfece né il Nord
né il Sud. La conquista di Roma creò un supplemento
di lacerazioni. Solo il primo conflitto mondiale e il fascismo riuscirono
a unificare, nelle speranze e nelle illusioni: torme di contadini
meridionali morirono sul Carso e sul Piave, insieme con i contadini
veneti; torme di contadini meridionali e veneti partirono con pari
entusiasmo per l'Abissinia. Ma il secondo dopoguerra ripropose le
divisioni e le contrapposizioni. In realtà, è mancato
un vero principio unificatore, il cemento profondo dello Stato come
collettività morale e culturale. E il Sud ha sempre nutrito
risentimento, come un figlio adottivo trascurato rispetto all'erede.
Del resto, la convinzione del Mezzogiorno di essere oppresso e sfruttato
è antica: Francesco Crispi, deputato della Sinistra e poi presidente
del Consiglio, uomo al quale non mancava il senso dello Stato, protestava
come siciliano contro "leggi non fatte per noi". (Straordinario
il fatto che nessuno abbia aperto bocca all'inizio della crisi mediorientale:
avevamo riserve petrolifere per due anni, e i prezzi dei carburanti
sono andati ugualmente alle stelle; la Fiat aveva registrato bilanci
positivi per centinaia di miliardi, ma metteva in cassa integrazione
decine di migliaia di operai di Torino e delle società collegate,
passandoli a carico dell'erario pubblico proprio mentre mieteva successi
internazionali con acquisizioni di altre imprese e proprio mentre
si discuteva di ridimensionamento del debito pubblico; la Borsa andava
a picco, e si prospettava la tassazione del capital gain; si varavano
nuovi balzelli, ma nessuno metteva mano ad una autentica riforma fiscale;
e si glissava rapidamente sul fatto che i valdostani hanno diritto
ad ottanta litri di carburante al mese a 3 70 lire al litro, che veneti
e brianzoli continuano ad essere i maggiori evasoti fiscali europei
e che regioni e attività agricole, industriali, zootecniche
intorno al Po hanno ridotto la Padania in un letamaio mangiasoldi).
I favori - storici, innegabili - accordati all'altra Italia hanno
spinto le mafie meridionali a trasformarsi e a crescere: con mutazioni
puntuali, efficienti, efficaci. Oggi, la mafia è una grande
organizzazione criminale, ma non si ritiene tale. Si considera una
grande associazione commerciale-produttiva, che deve agire in condizioni
di sfavore rispetto all'industria e al commercio "normali".
Presume che, come del resto in America, la sola possibilità
che i finanzieri e gli industriali privilegiati le hanno lasciato
sia il campo delle attività illecite, con la suburra sociale,
la prostituzione, il contrabbando, la droga, la rapina, l'estorsione,
le uccisioni a pagamento, il racket: e che quindi deve attuare questa
forma di accumulazione primitiva, da riciclare e investire poi in
attività pulite, lecite. Dunque: l'esplosione della potenza
mafiosa di questi anni è legata a un grande fatto culturale,
l'esplosione dello spirito del capitalismo nel Sud. Abbandonata a
se stessa, tollerata (prevista? orientata?), gente senza scrupoli
ha dato vita a una corrente "deviata" del capitalismo, che
non rispetta alcun limite e fa ricorso anche all'assassinio come arma
di concorrenza. E' un'autentica esasperazione di tipo sacrale dell'idea
capitalistica: è un'idea stalinista dell'impresa. L'impresa
e i suoi profitti vengono prima d'ogni altra cosa al mondo: chi si
oppone, all'interno o all'esterno, va eliminato. Ovviamente, quest'idea
paranoica si giova delle storture e delle ingiustizie italiane, come
lo stalinismo si giovava delle storture e delle ingiustizie del mondo
libero. Tutto questo i nostri Palazzi lo sanno. Anzi, lo hanno saputo
con molto anticipo. Due anni fa, il capo della polizia previde che
l'Antistato si sarebbe rafforzato e che avrebbe addirittura minacciato
lo Stato. Venne insolentito dai politici.
E' stato scritto che, mentre ovunque crollano muri e sistemi, in Italia
resiste, nei dibattiti pubblici, lo stile ideologico. Per il quale
ci sono solo nemici da esorcizzare a colpi di moralismi, di retorica
e di invettive, invece di problemi da analizzare razionalmente, prospettando
le soluzioni possibili. Prendiamo il caso del cartello del crimine.
Disponiamo di ottime descrizioni e spiegazioni del fenomeno. Ma l'intelligenza
che molti applicano nell'analisi del problema sembra svanire quando
il discorso si sposta sui possibili rimedi. Allora si torna allo stile
ideologico: prediche e invettive sostituiscono di nuovo il ragionamento.
E in questo modo alla gente comune non si offre la descrizione delle
diverse soluzioni possibili né una valutazione dei rispettivi
vantaggi e svantaggi. E' un persistente vizio italico. In sintesi,
possiamo dire che, rispetto alla situazione attuale, in quella parte
dell'Italia meridionale più soggetta ai morsi dei poteri criminali
ci siano tre (e soltanto tre) possibili alternative.
La prima è quella "populista": consiste nel sostituire
"Caudillos" onesti e capaci di mobilitare carismaticamente
i consensi dei "descamisados" alle "oligarchie"
corrotte e colludenti col sistema mafioso. La proposta populista,
che rammenta persino nel linguaggio i populismi latino-americani,
si regge su due pilastri: amministrazioni locali capaci di gestire,
in stretta collaborazione con lo Stato centrale, le opere pubbliche,
sottraendole all'ipoteca mafiosa e offrendo occupazione ai "descamisados"
in competizione con l'offerta dell'imprenditoria criminale e, in secondo
luogo, un apparato repressivo ispirato a criteri di giustizia "sostanziale",
capace di reprimere i clan mafiosi aggirando gli' ostacoli che il
garantismo giuridico pone normalmente all'azione degli inquirenti.
La soluzione populista può contare sul sostegno di una patte
del mondo cattolico e della sinistra comunista. Del catto-comunismo
essa mantiene l'ostilità per il garantismo liberale e la diffidenza
per il mercato privato. Per i populisti l'economia pubblica, che domina
il Sud (e grazie alla quale ingrassano i poteri criminali), non va
smantellata, ma solo bonificata attraverso un passaggio di consegne:
dai politici corrotti ai populisti onesti. Se perseguita con coerenza,
la proposta populista può alleviare nel breve termine i danni
più visibili prodotti dalla pressione criminale. Soprattutto
essendo espressione di una tipica ideologia del sottosviluppo, essa
corrisponde alla domanda e alle aspettative di quei settori della
società meridionale che vorrebbero certamente liberarsi dal
giogo criminale, ma senza pagare il prezzo della modernizzazione capitalistica,
senza dover fronteggiare le incertezze e i rischi del mercato, senza
fare a meno dell'assistenzialismo pubblico, (un po' come quei contadini
dell'Europa centro-orientale che vogliono la libertà e il benessere
dell'Occidente, ma senza rinunciare al Welfare comunista).
Gli svantaggi della soluzione populista sono insiti nella sua stessa
inevitabile temporaneità (sono sempre temporanei i fenomeni
caudillistici) e nel fatto che essa non è assolutamente in
grado di modificare le condizioni economiche e i tratti delle culture
meridionali che sono alla base dei fenomeni mafiosi.
La seconda è quella "militare". Se ne parla ormai
sempre meno timidamente, ma è chiaro che con l'aggravamento,
che sembra inarrestabile, della situazione, l'opzione militare è
destinata ad attrarre crescenti consensi. Essa presuppone la formalizzazione
dello stato di guerra con tutto ciò che ne consegue: leggi
d'emergenza, temporanea sospensione dei diritti costituzionali nelle
zone d'insediamento mafioso, esautoramento dei poteri locali, intervento
militare diretto dal centro. Siamo ai cannoni di Bava Beccaris.
L'opzione militare ha una tradizione: essa venne di fatto usata, proprio
nel Sud, dall'unica classe dirigente degna di questo nome che l'Italia
unificata abbia avuto: la Destra Storica. Ma in ogni caso presenta,
a sua volta, diversi ed enormi svantaggi. Il primo è che non
potrebbe alleviare, ma anzi aggraverebbe, il problema - da cui tutto
discende - della sfiducia verso lo Stato da parte delle popolazioni
meridionali. Uno Stato che si limita a sostituire al volto corrotto
e inefficiente che oggi ha in quelle zone un volto puramente repressivo
può forse raggiungere temporanei successi militari contro la
delinquenza organizzata, ma difficilmente può innescare quel
"circolo virtuoso" di fiducia nell'autorità pubblica
e di azione pubblica competente di cui il Sud ha bisogno. Inoltre,
la soluzione militare ha un altro svantaggio: quello di lasciare intatti
i nodi economico-sociali in cui si compendia la questione meridionale.
Infine, essa porrebbe gravi problemi, e rischi di involuzione autoritaria,
per il paese nel suo complesso: posta l'indivisibilità del
sistema giuridico nazionale, come si fa a sospendere temporaneamente
le garanzie in alcune zone d'Italia, senza che gli effetti si facciano
sentire anche in tutte le altre?
La terza soluzione è quella "liberal-liberista".
Essa propone una applicazione intransigente delle regole dello Stato
di diritto liberal costituzionale. Nel presupposto che solo in questo
modo (è quanto provò a dire Leonardo Sciascia, ma si
trovò di fronte contraddittori troppo rozzi per capire di che
cosa egli stesse parlando), lo Stato potrebbe arrivare, col tempo,
a erodere la cortina di diffidenza che lo circonda. Inoltre, la soluzione
liberal-liberista si affida al blocco dei trasferimenti di denaro
pubblico dal centro, allo smantellamento dell'economia assistita e
alla liberazione delle forze di mercato, nel presupposto che più
"pubblico" si smantella nel Sud, più si restringe
e prosciuga l'acqua nella quale nuotano i pesci del cartello del crimine,
e più condizioni si pongono per lo sviluppo economico. Quest'ultima
soluzione è ritenuta la sola che potrebbe, nel medio termine,
avviare a soluzione la questione meridionale e ridimensionare i poteri
criminali. Il suo maggior svantaggio è che per i benefici di
medio-lungo termine che promette chiede un prezzo elevato a breve
termine: la distruzione dell'economia parassitaria con conseguenti
altissimi (temporanei?) costi sociali.
Ma soprattutto questa soluzione è avversata dal "comune
sentire": né i politici legati al sistema malavitoso né
i populisti - anche se per ragioni diverse - possono tollerare una
drastica contrazione del peso dell'economia pubblica nel Sud. La sola
strada che, forse, potrebbe avviare a soluzione il problema risulta
quindi politicamente sbarrata. Se così è, nel prossimo
futuro dovremo aspettarci un dibattito su questi temi interamente
dominato dai populisti e dai militaristi, con ciascuna delle due fazioni
impegnata a vantare i pregi della propria ricetta.
Ma è facile scommettere che, così stando le cose, altro
non faremo che consegnare ai posteri, intatta nella sua gravità,
quella questione meridionale il cui stato è chiarito, molto
meglio che dalle indagini sociologiche, dal lugubre elenco dei morti
ammazzati che ogni giorno dobbiamo diffondere attraverso i mass media.
Repubblica
sudamericana?
Lo stato che
c'è
Norberto Bobbio
Le lamentele che
si vanno ripetendo monotonamente da anni, specie nei momenti di recrudescenza
dello criminalità, sull'essenza dello Stato, sono insopportabili.
Lo Stato esiste, e come!, anche in Sicilia. Forse che in Sicilia non
esiste un governo regionale, addirittura a statuto speciale, che gode
di privilegi che altri governi regionali non hanno? Non esiste in
tutte le città siciliane, a cominciare da Palermo, un governo
locale? Non esiste una pubblica amministrazione in Sicilia? Non si
svolgono in Sicilia, come in tuffo il resto del Paese, regolari elezioni
che chiamano i cittadini a eleggere i propri rappresentanti? Non ci
sono i partiti in Sicilia, e i partiti non sono in una società
democratica lo strumento principale, riconosciuto dalla Costituzione,
per far partecipare i cittadini alla vita dello Stato?
Il continuare a far credere che lo Stato consista soltanto negli istituti
della repressione del crimine, polizia, carabinieri, magistratura,
per poter spiegare la nuova spietato uccisione di un magistrato che
faceva Il proprio dovere adducendo l'insufficienza degli organici,
l'inefficienza dell'apparato repressivo, è il solito modo,
cosciente o incosciente che sia, per distrarre l'attenzione della
gente indignata e atterrita dallo Stato che esiste, e su cui ricadono
le maggiori responsabilità di quel che accade in quella regione,
e in altre regioni meridionali. Lo Stato che esiste è lo Stato
democratico-rappresentativo, completo di tutti i suoi organi', in
pieno possesso dei suoi poteri'. Giustamente e saggiamente Alessandro
Galante Garrone ha scritto che, se è vero che sotto accusa
è lo Stato in generale, si dovrebbe parlare più precisamente
di "governo, amministrazioni pubbliche, partiti, uomini' singoli,
fuori dalle solite generalizzazioni". E aggiunge: "Un discorso
da fare con più calma". Il discorso deve cominciare, a
mio parere, dalla constatazione inoppugnabile che lo Stato esiste
anche in Sicilia. Ma lo Stato che esiste è quello che non solo
non è riuscito a sconfiggere in tanti anni il male antico della
mafia, ma ha permesso che questa diventasse una potenza smisurata,
sempre più minacciosa sino ad apparire invincibile. L'autrice
di un noto libro, ("Cosa non solo nostra"), ha affermato
in un'intervista che "dal dopoguerra a oggi la mafia siciliana
è diventata la più potente organizzazione criminosa
su scala mondiale" e che esso è "la principale responsabile
della diffusione delle droghe in Europa dal 1951". Sarà
un'esagerazione. Ma che in tutti questi anni la potenza della mafia
in Sicilia non sia stata debellata, è di pubblico dominio.
Sino a che punto riusciamo a renderci conto che tutto questo accade
non in una Repubblica sudamericana lontana mille miglia da noi, ma
in una regione della civilissima, o che si ritiene civilissima, Italia,
dove non solo esiste uno Stato, ma esiste un governo rappresentativo,
che trae legittimità e forza da una Costituzione democratica
avanzatissima?
Risposta su
tutti i fronti
Giancarlo Caselli
Magistrato, ex membro CSM
La principale
caratteristica dei modelli di criminalità mafiosa emersi ed
affermatisi in Italia negli ultimi tempi sembra essere la loro vitalità
e capacità di espansione. Nonostante i colpi subiti, infatti,
le organizzazioni criminali più consistenti hanno saputo diventare
vere e proprie strutture economiche, che ci loro modo producono ricchezza
e danno lavoro: interessando (spesso in maniera sommersa) moltissime
persone, che vengono così a trovarsi coinvolte in una rete
di collegamenti e di rapporti che è sempre più difficile
rompere. Di più: un complesso e sofisticato sistema di alleanze
e scambi con pezzi dei mondo economico e politico (spesso fondato
su forme anche solo implicite di intimidazione) ha fatto, di tali
organizzazioni criminali, centri di diffusione di illegalità
nelle istituzioni e nella società (comitati d'affari di varia
composizione, tangenti, appalti e concorsi truccati ne sono - purtroppo
- dimostrazione evidente).
Questa illegalità diffusa, che si intreccia con pesanti forme
di disgregazione dei tessuto sociale e con storiche carenze dello
Stato (in particolare della pubblica amministrazione) crea e ricrea
- con continuità impressionante - spazi enormi per le organizzazioni
criminali. Enormi e puntualmente riempiti, con il ricorso a tutte
le tecniche d'intervento: dalle più moderne (grandi traffici)
alle più tradizionalmente brutali (estorsioni, microcriminalità
strategicamente orientata, ecc.). Il risultato complessivo di questa
situazione bene è stato definito come "incancrenimento
della criminalità in diverse aree dei Paese". Con tale
incancrenimento, la criminalità riesce a permeare di se stessa
interi territori, controllandoli pressoché in esclusiva. Ecco
perché (come osserva Arlacchi in un suo saggio) se anche In
molti Paesi dell'Occidente esistono "esempi di gestione disinvolta
ed illegale di risorse pubbliche", se anche negli Stati Uniti
e altrove esiste un potere mafioso molto forte, in nessun Paese esiste
un potere paragonabile - per capacità di influenza reale -
a quello detenuto dalla mafia In Italia.
Il pericolo, di fronte a questo stato di cose, è che la crescente
sfiducia verso lo Stato finisca per appannare (fino a cancellare dei
tutto) le motivazioni a ribellarsi e lottare. Il controllo dei territorio,
realizzato nelle forme opprimenti che sono tipiche dei potere mafioso,
finisce per determinare una saturazione dell'ambiente che altera valori
e comportamenti. Senso di impotenza e tendenza alla rassegnazione
ne sono la conseguenza. Mentre si vanificano l'opera e gli sforzi
di quanti vorrebbero continuare a reagire.
In questo contesto, che è davvero poco definire drammatico,
non si può che ribadire l'assoluta necessità di procedere
con determinazione ed energia ad un piano organico e globale di interventi,
articolato su tutti i fronti interessati: da quello repressivo a quello
politico, economico e sociale. Solo in questo modo si potrà
arrestare la caduta della tensione civile che sembra purtroppo serpeggiare
nell'attuale fase, restituendo allo Stato il controllo dei territorio
e della situazione nel suo complesso.
Cose nostre
/ Mafia bianca all'italiana?
L'aria che
cammina
Guido Salerno
I superlatitanti
ricercati sono 17, e la loro cattura comporterebbe effetti certamente
disgreganti e di sicuro sbandamento all'interno delle organizzazioni
criminali di appartenenza. Sono gli uomini che tirano le fila di mafia,
'ndrangheta e camorra; gli stessi che, dopo le spettacolari retate
e i relativi maxiprocessi degli ultimi anni, hanno riorganizzato truppe
e reti di gregari, ma non solo più in Sicilia, Campania e Calabria:
nel giro di affari sono ormai entrate altre regioni ricche del Sud,
come la Puglia, quarta "area a rischio mafioso" della penisola,
e regioni ad alta concentrazione finanziaria del Nord, come l'Emilia,
la Lombardia, la Valle d'Aosta e il Veneto.
Le cosche della Sicilia orientale fanno capo a Benedetto ("Nitto")
Santapaola, personaggio tipico della mafia dei colletti bianchi, alla
testa di un'organizzazione vastissima di interessi, e con relazioni
rilevanti con esponenti della politica, dell'amministrazione pubblica
e della finanza. Accreditato nei cosiddetti "ambienti che contano",
non solo siciliani, Santapaola è il punto di riferimento esclusivo
dei "corleonesi" della Sicilia occidentale, Totò
Riina e Bernardo Provenzano. Il primo è in assoluto il capo
di Cosa Nostra Siciliana, mentre il secondo, fino a poco tempo fa
un comprimario, è stato successivamente relegato al ruolo di
braccio destro.
Riina è il nuovo Luciano Liggio, un monarca assoluto che ha
trasformato radicalmente l'organizzazione con due operazioni a vasto
raggio: la prima è consistita nell'eliminare la vecchia "cupola",
o "commissione", della cui esistenza sospettava il generale
Dalla Chiesa, e la cui operatività collegiale venne confermata
da numerosi pentiti nel corso dei maxiprocessi; la seconda si è
tradotta nella pratica, mutuata dalla strategia delle Brigate Rosse,
della "compartimentazione", il sistema di mimetizzazione
fondato sull'anonimato nelle città, e con comunicazione solo
a livello di graduati, di luogotenenti, ciascuno noto solo, al proprio,
e non agli altri gruppi di soldati semplici.
Fra i grandi latitanti, altri due nomi di spicco: Salvatore Greco,
noto come "il senatore", (fratello di Michele Greco, "il
papa", in galera e sotto processo), eminenza grigia di Cosa Nostra,
sempre defilato, con numerosissime relazioni politiche, finanziarie
e amministrative locali; e Carmelo Zanca, venuto fuori indenne dal
processo per la strage di Piazza Scaffa, nella quale furono uccise
otto persone, ma condannato all'ergastolo in contumacia al maxiprocesso.
Complessivamente, sono 16.302 le persone sospettate di lavorare full
time per la mafia. Di questi personaggi i centri raccolta dati dell'Antimafia
sanno quasi tutto: precedenti penali, vincoli di parentela e d'amicizia,
livelli di affiliazione, giri di affari, luoghi frequentati, soprannomi
usati, modi di comportamento, metodi di "lavoro" prediletti.
E sono 817 le società o imprese alle quali gran parte di costoro
fanno capo. Questo è lo "zoccolo duro" di Cosa Nostra
Siciliana, al quale fanno riferimento le indagini su grandi appalti
pubblici (come la terza corsia Roma-Napoli, soprattutto nel tratto
Frosinone-Capua; o la centrale termoelettrica Enel di Gioia Tauro);
i collegamenti con la camorra per appalti (la strada valdostana per
il Monte Bianco) e subappalti (48 non autorizzati, 28 violazioni alle
norme sulla certificazione antimafia, 305 violazioni al decreto di
intermediazione delle prestazioni di lavoro solo nei primi sei mesi
dello scorso anno); per gli omicidi; per il riciclaggio del denaro
sporco; per le estorsioni; per il traffico di titoli; per le speculazioni
in Borsa; per gli attentati.
I gruppi mafiosi siculo-calabresi sono 359, quelli camorristici sono
67, quelli pugliesi di recente formazione sono una trentina: calabresi
e siciliani dispongono di circa 10 mila uomini armati, i campani di
circa 5 mila, i pugliesi di 1.300. Di fronte a questi eserciti di
scherani stanno 449 pentiti e collaboratori della giustizia, i quali
hanno consentito di ridisegnare le nuove mappe della criminalità,
di perfezionare 114 "accessi" bancari in 32 istituti di
credito per esaminare i movimenti su singoli libretti o conti correnti,
di acquisire numerosi elementi a carico di pubblici amministratori,
di valutare in 3 mila miliardi i proventi del lotto clandestino, di
mettere in cantiere un dossier sui canali di riciclaggio e di "legittimazione"
della black money, di avviare una parallela indagine analitica sugli
spostamenti di capitali dalle regioni ad alta intensità mafiosa
a quelle dell'Italia centro-settentrionale con l'acquisto preferenziale
di aziende agro-vinicole, di alberghi, di gioiellerie e pelliccerie,
di ristoranti; di appartamenti, di terreni edificabili.
L'assedio di
Milano
Emblematico è il caso della Montimmobiliare, che il narcotrafficante
Sergio Coraglia aveva messo a capo di altre società di costruzione,
con decine di cantieri aperti a Bollate, Carrugate, Opera, Rozzano,
Cesano Boscone, Cornaredo, Settimo Milanese, Liscate, su terreni fatti
diventare edificatori grazie a complicità locali ora sotto
inchiesta. Coraglia e gli altri creatori della "Cosca Nord"
facevano capo alla "famiglia" Resuttana, potentissima in
Palermo. Alleati con la 'ndrangheta calabrese, gestivano società
di copertura per il riciclaggio delle narcolire ed espandevano gli
imperi immobiliari grazie a società finanziarie lombarde compiacenti.
Senza, tuttavia, che questo escludesse altre attività mafiose
tradizionali. Mafia, camorra e 'ndrangheta esercitano il "pizzo":
secondo un rapporto del sostituto Guido Viola, a Milano un negoziante
su dieci paga la tangente e tace. Finanza, imprenditoria e mercato
immobiliare lombardi sono percorsi dal denaro sporco del Sud e del
Centro, e Milano è diventata un gigantesco "lavatoio";
insieme con Nizza, dove alcuni milanesi operavano in contatto con
Michele Zaza, esponente di primissimo piano della camorristica "Nuova
Famiglia", arrestato un anno e mezzo fa.
Quello dell'edilizia non è il solo campo in cui avviene il
riciclaggio. Una parte notevole del denaro sporco (i capitali provenienti
da sequestri di persona sono poca cosa nel contesto delle migliaia
di miliardi di lire dell'economia del crimine) viene investita in
titoli di Stato e in titoli atipici. E' nella Borsa, dunque, che attraverso
mille rivoli giunge gran parte del denaro da riciclare: fenomeno difficile
da controllare, anche perché, comunque, sempre più destinato
a collegarsi a flussi transnazionali.
Il sacco di
Roma
Se Milano piange, Roma non ride. Per le cosche del Sud, la capitale
è una base sicura per le complesse relazioni internazionali
e per le coperture del traffico di cocaina e di eroina. Altissimo
concentrato di politica, di pubblica amministrazione e di commercio,
con l'aeroporto di Fiumicino e con gli scali di Ostia e di Formia-Gaeta,
Roma è uno snodo di prim'ordine, la "business house"
della mafia, giunta dapprima sul litorale, molti anni fa, con i Coppola,
e in seguito con le famiglie di Palmi alleate con i "corleonesi".
La camorra, invece, ha risalito la costa attestandosi lungo l'asse
Afragola-Mondragone-Cassino ed effettuando investimenti sicuri dopo
il terremoto dell'Irpinia: settori privilegiati, l'acquisto, il taglieggiamento,
il totonero. Da parte sua, la 'ndrangheta, alleata con la mafia, traffica
in licenze commerciali, in speculazioni sui terreni (che hanno fatto
saltare il mercato immobiliare nel Sud-Pontino) e in riciclaggio di
denaro sporco.
La camorra ha un personaggio di riferimento preciso, Ernesto Bardellino,
che da tre anni vive a Formia. Altri personaggi di rilievo delle mafie
calabresi e siciliana vivono in soggiorni obbligati, come a Riano
Flaminio, oppure hanno fatto acquistare (e poi si son fatte cedere)
licenze commerciali a persone dalla fedina penale pulita, ponendo
le basi di attività intorno alle quali ruotano gli interessi
sporchi del narcotraffico, del "pizzo", dei sequestri di
persona.
Molto complicato è il rapporto tra piovre e malavita romana,
soprattutto dopo la fine degli equilibri, stabiliti negli anni '70,
tra la banda della Magliana e Pippo Calò, il cassiere della
mafia. Oggi siamo in presenza di una ricerca di nuova stabilità,
costata finora almeno una trentina di morti ammazzati. Una nuova "pax
mafiosa", è ritenuta indispensabile soprattutto per due
motivi: ogni scontro apre un nuovo fronte di indagini, che si saldano
con altre in corso da parte del Commissariato Antimafia, con gravi
rischi per l'organizzazione; l'instabilità rende poi più
difficile l'espansione dell'economia mafiosa, com'è accaduto
per le indagini che hanno impedito di aggiudicarsi grossi appalti,
quali quelli dell'università di Cassino, o delle Terme di Latina.
Ma c'è anche un altro aspetto sul quale puntano gli investigatori:
quello della proliferazione delle finanziarie, che a Roma e nel Lazio
aprono e chiudono nel breve spazio d'un mattino e che spesso sono
risultate essere solo un appartamento con telefono. Sono strumenti
di riciclaggio, strozzinaggio, traffico e controllo del gioco d'azzardo,
che applicano la tecnica colombiana delle centrali di raffinazione:
possono essere smontati e trasferiti nel giro di un'ora.
Verso una "società
del crimine"?
Se, dunque, il vero nemico del Sud è l'inestricabile nodo tra
continua emergenza di bisogni sociali, controllo politico sulla gestione
delle risorse pubbliche e interessi delle imprese coinvolte in questa
gestione, è altrettanto vero che le tre piovre sono in grado
di tessere all'interno del sistema politico-amministrativo rapporti,
collusioni e garanzie d'impunità, inseriti in un circolo vizioso
che si instaura tra sviluppo interrotto, assistenzialismo, aumento
del potere criminale e crisi delle istituzioni. O si spezza questa
catena, in ciascuno e in tutti i suoi anelli perversi, oppure assisteremo
alla nascita di una diffusa società del crimine, parallela
alla società civile, operante sull'intero territorio nazionale:
come accade negli Stati Uniti, dove la "mafia bianca" è
in grado di manovrare fino a quindici milioni di voti; come in Corea,
nel Sud-Est asiatico, o nel Sudamerica, dove le mafie sono governi-ombra
e gestiscono economie reali. Criminose, ma miliardarie in dollari.
Politicamente determinanti, e ormai inestirpabili.
Criminalità
e crisi morale
Michele Giordano
Arcivescovo Metropolita di Napoli
La serie efferata
di delitti della criminalità organizzata, che ha coinvolto
persone ignare ed estranee alla lotta tra i vari clan e finanche Innocenti
fanciulli, ha seminato - per la sua vastità, crudeltà
e continuo crescita sgomento e sconcerto. Apprezziamo tutti coloro
che, rappresentanti dello Stato o semplici cittadini, si rifiutano
di considerare tale fenomeno come una fatalità alla quale non
è possibile reagire in alcun modo: dobbiamo invece riaffermare
- con le parole e soprattutto con i fatti - la certezza che è
possibile liberare le nostre regioni da un cancro che potrebbe portare
alla rovina, alla morte; ed è possibile, ovviamente, solo a
patto che ognuno faccia la sua parte.
Anzitutto, lo Stato con le sue istituzioni di polizia, la cui azione
va ulteriormente potenziato con migliori attrezzature ed una migliore
professionalità, tenuto conto dell'alto indice di "specializzazione"
con cui opera oggi la criminalità organizzata. Al ministero
di Grazia e Giustizia e alla magistratura si chiede, invece, di assicurare
una più puntuale e rapida amministrazione della giustizia penale:
la consapevolezza che i delitti non vengono puniti perché non
si riesce a scoprirne l'autore, oppure che - in caso di condanna -
c'è sempre la prospettiva di sfuggire alla pena attraverso
le maglie larghe della giustizia penale italiana incoraggia senz'altro
i delinquenti.
Ma non si tratta solo, per lo Stato, di svolgere un'opera di repressione.
Più necessaria e urgente è l'opera di prevenzione. Sappiamo,
infatti, che nel fenomeno della criminalità organizzata molto
incidono la disoccupazione giovanile e il degrado sociale e civile
dell'area urbana che gravita intorno alle metropoli. Occorre perciò
creare posti e occasioni di lavoro, bonificare zone e quartieri, creare
scuole e opere sociali.
Crisi lunghe, addirittura perenni, degli enti locali - spesso causate
dalla logica distorto della spartizione dei potere - di fronte a problemi
giganteschi da risolvere - come le emergenze dell'acqua, della casa,
dei lavoro sono il punto debole e drammatico della situazione. Auspico,
per gli enti locali, stabilità, concordia, impegno nella realizzazione
del bene comune; e rivolgo una parola di compiacimento e di incoraggiamento
a quanti stanno già operando in questa direzione.
Ma dobbiamo anche avere il coraggio di dichiarare che a nulla servirebbe
l'azione dei pubblici poteri se non fosse accompagnato da un'intensa
azione educativa da parte della famiglia e della scuola oltre che,
in particolare, della Chiesa. Bisogna infatti rendersi conto che alla
base dei fenomeno delinquenziale non c'è solo una grave crisi
sociale, dovuta a subitanei' cambiamenti che hanno sconvolto equilibri
e regole di comportamento, disorientando le persone e alimentando
gravissimi problemi come la disoccupazione; c'è anche una -
ancora più grave - crisi morale e religiosa, che ha portato
alla caduta di quasi tutti i valori e al rigetto delle più
fondamentali norme morali e religiose, a cominciare da quelle riguardanti
il rispetto della vita umana, dal concepimento al termine naturale.
Su ogni legge morale e su ogni valore religioso, nella cultura dominante
che ci avvolge e che respiriamo, ha preso il sopravvento l'idolatria
dei denaro, visto come il bene supremo e assoluto, da guadagnare -
in poco tempo e in gran quantità - anche a costo di uccidere
o di infliggere spaventose sofferenze a creature inermi come i bambini.
E' contro questa idolatria - spesso purtroppo esaltata anche dai mass
media - che particolarmente la Chiesa deve combattere.
Alla comunità ecclesiale spetta il compito di inculcare con
tenacia e con pazienza il senso autentico della vita umana, che si
trova pienamente solo in Dio, la legge derivante dal Creatore e perciò
rispondente alle esigenze più profonde della natura dell'uomo,
in modo particolare l'assoluto rispetto della vita umana, insistendo
nel proclamare l'insegnamento di Gesù sul denaro "iniquo"
e la impossibilità di servire insieme Dio e Mammona.
Senza questa opera educativa profonda e radicale, ogni altra azione,
pur necessaria, mi richiama la storiella di colui che schiacciava
con le mani i moscerini uno ad uno, invece di pensare a bonificare
il pozzo che ne produceva a centinaia di migliaia.
Società
ed economia
Una follia
punire il Sud
Sebastiano
Maffettone
Tre elementi diversi,
ma complementari, fanno pensare che il Mezzogiorno vivrà, nell'immediato
futuro, momenti difficili.
Innanzitutto, esiste nel Paese un sentimento diffuso di scontento
per il Sud e i meridionali. Il successo delle leghe non è solo
elettorale. Nasconde anche antiche e mal sopite diffidenze, insieme
con la rinascita vigorosa di distinzioni etniche e culturali poco
rassicuranti. In sostanza, mentre prima si tendeva a credere che il
divario Nord-Sud fosse da attribuire alle circostanze, ora ci sono
pochi dubbi che la "colpa" sia dei meridionali.
In secondo luogo, queste sensazioni e intuizioni popolari trovano
conforto nella più affermata dottrina sociale. I giuristi pubblici
sostengono con rinnovato vigore le tesi delle autonomie locali, con
la implicita raccomandazione che un Mezzogiorno più separato
e indipendente sul piano istituzionale sarebbe alfine capace di colmare
le proprie deficienze sociali.
I politologi riprendono a leggere il Cattaneo federalista. Gli economisti
celebrano, con sorprendente entusiasmo, i fasti della logica di mercato.
Per cui, il Sud soffrirebbe di una perversa abbondanza finanziaria,
rimossa la quale, solo una "salutare" scarsità potrebbe
rendere i suoi abitanti nuovamente autonomi, operosi, e efficienti
sul piano economico. Poco importa a codesti neoreaganiani di provincia
che la loro ricetta richiederà costi umani e sociali terribili
in nome di un successo futuro e incerto.
I sociologi, infine, ripropongono l'idea di una criminalizzazione
pervasiva delle popolazioni meridionali. Secondo alcuni di loro, la
mentalità mafiosa e camorristica sarebbe così diffusa
perché frutto irrinunciabile di una cultura tradizionale dominante.
Come si può notare, tutte queste tesi teoriche riprendono,
in maniera certo formalmente più seria e responsabile, le sensazioni
diffuse che sono alle spalle del fenomeno leghista: il Mezzogiorno
deve essere progressivamente separato dal resto del Paese e impoverito.
In terzo luogo, fenomeni reali sembrano imporre, indipendentemente
dalla volontà della gente comune o degli studiosi, una cura
severa. Le difficoltà in cui si imbatte ogni finanziaria sembrano
essere sempre meno occasionali e sempre più strutturali, con
la conseguenza che l'abituale finanziamento alle regioni meridionali
diventerà, nel prossimo futuro, estremamente improponibile.
Inoltre, la presenza di nuovi agguerriti mercati, in concorrenza con
i nostri, a cominciare dai Paesi assetati di consumismo dell'Europa
Orientale, creerà impreviste difficoltà per eventuali
investimenti nel Sud d'Italia.
I tre elementi che abbiamo qui sottolineato hanno origine diversa.
Coincidono, però, nel proporre un'unica dolorosa ricetta. Il
Mezzogiorno dovrà subire tutte le asprezze di un "vuoto
deflativo", come lo chiamano gli economisti, per avere l'opportunità
di ritornare ad occupare la sua posizione nel Paese con pari dignità.
Lo stato del benessere dovrà essere ridotto o smantellato per
ottenere un sia pur minimo risultato.
C'è poco dubbio che ci siano elementi di verità in questa
pur amara conclusione. Il modo, ad esempio, in cui politici e imprenditori
meridionali gestiscono la spesa pubblica e consentono un livello di
consumi non giustificato dalla produttività, è spesso
scandaloso. E' lecito, però, dubitare dello zelo ideologico
che l'accompagna. Perché i tre aspetti che abbiamo presentato
si rinforzano l'uno con l'altro, contribuendo a creare l'immagine
di un Mezzogiorno assediato. Su questa immagine, cupa e punitiva,
ci sembra giusto esercitare un esplicito sospetto intellettuale. E'
perlomeno curioso che la forza delle idee sposi, senza dubbi o tentennamenti,
gli ostinati pregiudizi dei lumbard, in un momento storico effettivamente
complesso e preoccupante.
Il fine ultimo di una politica per il Mezzogiorno dovrebbe essere
l'integrazione culturale economica, prima che sociale, di questa pane
del Paese, come completamento dell'opera di riunificazione nazionale.
E' implausibile credere che l'immagine di un Mezzogiorno assediato
possa contribuire a ciò.
Ma il Nord
ci rimette?
Paolo Savona
L'economia meridionale
è presa tra due fuochi incrociati: da un lato giungono bordate
pesanti sull'uso scorretto dei fondi che ad essa vengono destinati;
dall'altro vengono le sferzate della concorrenza interna e internazionale.
Le centrali di fuoco sono alimentate da valutazioni sociali, economiche
e politiche che vanno individuate con precisione per essere neutralizzate.
Sul piano sociale, larghi strati della pubblica opinione settentrionale
sono convinti che il Sud viva a spese del Nord. Sul piano economico,
questa convinzione non è suffragata né dai dati delle
entrate e delle uscite del settore pubblico nel Mezzogiorno né
dai dati della destinazione della domanda dei beni di consumo e di
investimento meridionali tra Nord e Sud. Il contributo che il mercato
meridionale, composto da 33 milioni di abitanti, dà allo sviluppo
del mercato settentrionale, composto da 22 milioni di abitanti, attraverso
i suoi acquisti al Nord, è elevato, prossimo a un terzo del
benessere di questa parte della popolazione italiana. All'incirca,
l'altro terzo del benessere del Nord viene dalle esportazioni e il
residuo dalla domanda interna. Da questa ripartizione delle "fonti
del benessere", dovrebbe derivare un pari interesse del Nord
a mantenere buoni rapporti col Sud, come con l'estero. Ben conosciamo,
invece, la diversa considerazione che i due universi ricevono dalle
popolazioni settentrionali. E' ben noto che il contributo dato dal
Mezzogiorno al benessere del Settentrione dipende per quasi il 40
per cento dai trasferimenti del bilancio pubblico al Sud, finanziati
con l'imposizione fiscale e con l'indebitamento pubblico. La pubblica
opinione settentrionale ritiene che questi trasferimenti derivino
interamente dai propri esborsi fiscali. Questo convincimento è
infondato.
Una certa parte, almeno un terzo, viene dalle stesse imposte e tasse
pagate dai contribuenti meridionali; più di un terzo proviene
dal meccanismo della progressività delle imposte tra aree che
presentano diversità di reddito pro-capite in rapporto di 2
a 3; il residuo è l'effettivo finanziamento del Nord al Sud.
Una stima grossolana consente di considerare questa percentuale pari
al contributo dato dal Sud al benessere del Nord attraverso i suoi
acquisti, stimabile intorno al 12 per cento. In sintesi, il Nord si
autofinanzia (e dunque "non ci rimette") e in tal modo mantiene
un minimo di condizioni soddisfacenti nel Sud. Questi calcoli hanno
un mero contenuto statistico, "ragionieristico". Se si ipotizzasse
la cessazione di tutti i trasferimenti pubblici al Sud, il benessere
del Nord si ridurrebbe in misura maggiore di quella stimata, in quanto
indurrebbe cadute di domanda o di risparmio proporzionalmente più
ampie. Se il Sud interrompesse i suoi scambi di beni e servizi col
resto del Paese, produzione e finanza del Nord presenterebbero gravi
tensioni da adattamento alla nuova situazione.
Sul piano politico si riflettono queste errate valutazioni della componente
economica del problema Nord-Sud e la spinta sociale che da esse hanno
origine. Ciò è comprensibile, ma non giustificabile.
Quali che siano l'origine e il contenuto della "questione meridionale",
essa deve essere affrontata secondo un'ottica democratica: di una
democrazia che si prefigga di garantire pari opportunità ai
propri cittadini, secondo un'ispirazione liberale, e un minimo di
giustizia distributiva, secondo una più moderna coscienza sociale.
Le Nazioni o aree geografiche che non si prefiggono di garantire un
assetto politico che offra pari possibilità a tutti i cittadini
e una distribuzione del reddito e della ricchezza con diversità
"accettabili" sono destinate a forme di organizzazione sociale
basate sulla violenza nelle sue diverse forme (criminalità
spicciola o organizzata, teppismo, droga, oppressione di Stato). Per
non scontentare qualcuno dei moderni filosofi sociali citando uno
solo di essi, mi limito a ricordare che già Platone scese in
difesa dei due citati pilastri su cui si fonda una sana Repubblica:
pari opportunità e adeguata giustizia sociale. La politica
non può quindi registrare solo la spinta antimeridionalistica.
Il suo primo dovere dovrebbe essere quello di diffondere corrette
informazioni statistiche sullo stato dell'economia. Il secondo, quello
di attuare forme di intervento adeguate alle nuove necessità
dei mercati aperti alla concorrenza interna e internazionale. Oggi
questa politica è molto carente nell'assolvimento dell'uno
e dell'altro dei propri doveri e qualche responsabilità ce
l'hanno anche i meridionali che, pur formando maggioranza numerica
nel Paese, non esercitano coerentemente questa loro forza democratica
proponendo soluzioni "ragionevoli".
Così
muore il Sud
Guido Gentili
Il meridionalismo
politico non c'è più. Ma ci sono mafia e camorra, che
vedono accresciuto il loro potere, e c'è la paralisi decisionale
e operativa dello Stato. E' questa la triplice crisi che stringe d'assedio
il Sud e che fa di intere regioni, isolate dal resto del Paese, un
blocco sociale nuovo, alimentato dalle emergenze continue e dal "controllo
politico sulla gestione di risorse pubbliche e interessi delle imprese
a vario titolo dipendenti da tale gestione". Non poteva essere
più amara, e severa, l'analisi della Svimez sullo stato del
Mezzogiorno. La crisi della legalità, del meridionalismo e
dello Stato fanno di un pezzo dell'Italia un terreno abbandonato,
dove convivono modernizzazione fittizia e vecchi residuati socio-culturali.
Ecco, così, "le sopraffazioni e gli asservimenti",
la confusione tra pubblico e privato, gli "scambi di protezioni
e le fedeltà personali": un bel tuffo, insomma, in un
lontano passato "lazzaronesco e feudale" che si perpetua
nel nuovo assistenzialismo.
Certo, fanno bene i padri nobili dell'intervento straordinario ad
avvertire che l'Abruzzo non è la Calabria e che la stessa criminalità,
pure così forte in alcune zone, è fenomeno che tocca
parti circoscritte della società meridionale. Ma non sfuggono
loro le radici del disagio, e della protesta, che stanno alla base
del successo politico delle Leghe: il Nord, che vuole gestire la sua
integrazione con l'Europa, non sa che farsene proprio di quello Stato
inefficiente ed assistenziale dal quale al contrario il Mezzogiorno
chiede di essere sussidiato.
Finita la stagione delle grandi utopie e dell'attesa delle "rivoluzioni"
a Sud, la politica meridionalistica è stata travolta dalle
leggi speciali e dalla fittissima rete di deroghe in nome e per conto
dell'emergenza. E la stessa Svimez, che pure ripropone il valore della
moderna impresa concorrenziale, e quindi dell'industrializzazione
non assistita, per infrangere il blocco sociale degli anni 180, è
consapevole che l'esito della partita con un coacervo di interessi
ben più forte del vecchio "blocco agrario" è
tutt'altro che scontato.
La mafia tende a sostituirsi allo Stato; ma, per accrescere i suoi
guadagni, le sue quote di mercato e le garanzie di impunità,
è anche interessata a rapporti di collusione con chi opera
al suo interno. Da qui, l'affermarsi di un circolo vizioso che si
instaura tra sviluppo interrotto, assistenzialismo, aumento del potere
criminale e crisi delle istituzioni.
La catena andrebbe spezzata. Ma come? E' a questo punto che si apre
la voragine del meridionalismo, quello non cialtrone e non lacrimoso,
smarrito (speriamo non per sempre) nel buco nero degli interventi
a pioggia. Per ora, lo ammette la stessa Svimez, non è affatto
chiaro chi, e come, possa iniziare a tagliare gli anelli di questa
catena. Contrapposta al nuovo, granitico blocco, questa nebbia progettuale
costituisce l'aspetto forse più inquietante delle già
difficilissime prospettive del Mezzogiorno. La legge che doveva sostituire
l'intervento straordinario presenta un bilancio fallimentare. I piani
per il Sud sono diventati elenchi di opere inutili e poco trasparenti.
Lo Stato e una burocrazia romana, che vive solo di procedure ed ignora
i bisogni dell'economia reale, sono lontani.
Perché meravigliarsi, allora, se un'area vasta, opaca e non
concorrenziale come il Meridione è destinata ad essere sempre
più emarginata?
Mezzogiorno
Stato e Mercato
Enzo Giustino
Il richiamo al
senso di responsabilità dei gruppi sociali contenuto nel documento
dei Vescovi italiani sul Mezzogiorno poneva tra l'altro il quesito
di come la società meridionale potesse superare la condizione
di "dipendente verticale verso le istituzioni". In altri
termini, di come si potesse rendere il Sud più "soggetto"
che "oggetto" di sviluppo.
Commentando in particolare questa parte del documento, mi ero chiesto
se una risposta a questa fondamentale domanda non andasse ricercata
nella formula "più Stato, più mercato". Una
formula, cioè, che ponesse fine ad una malintesa solidarietà
nei confronti di popolazioni che devono certamente trovare nello Stato
tutte le garanzie per una convivenza giusta, civile, serena, ordinata,
ma che ha al suo interno forze e risorse sufficienti per riscattare
e determinare il proprio futuro sotto il segno di uno sviluppo civile
ed economico. Una formula che contribuisse a ribaltare l'immagine
di un Sud avido e sprecone, "spesa-pubblico-dipendente".
Una formula che aiutasse a svincolare le forze sane dalla soggezione
del clientelismo politico là dove si manifesta e si impone.
Di tutto questo non si è parlato nel consueto convegno annuale
dei giovani dell'industria su "Stato e Mercato", (argomento
non nuovo, almeno per la Confindustria). Il tema ricorre spesso nelle
manifestazioni e nelle prese di posizione dell'organizzazione imprenditoriale.
Insistervi è infatti non solo utile, ma necessario, visto che
nel nostro Paese interferenze, vincoli e condizionamenti sono ancora
tanti. Al riguardo, vorrei osservare che ogni qualvolta si discute
di questi problemi, in qualsiasi sede, si ha l'impressione che l'argomento
non può interessare le regioni meridionali. Esse non potrebbero
essere coinvolte in questo discorso perché destinatarie di
politiche speciali, perché votate all'assistenzialismo, perché
incapaci di intendere certi valori e certi principii, infine perché
ormai dominate e costrette dalla delinquenza organizzata. Si potrebbe
anche obiettare che i rapporti fra Stato e mercato interessano globalmente
il Paese e che non è il caso di "specializzare" la
discussione in chiave meridionale. E' vero! Tuttavia, la società
meridionale dev'essere stimolata e sollecitata a ritrovare se stessa.
Non nella forma dell'aiuto o di quella malintesa solidarietà
di cui si diceva, ma contribuendo a creare una corrente di opinione
che, sulla base di obiettive e serie analisi, possa consolidare la
prospettiva non di un Sud in procinto di staccarsi dal resto dell'Italia
e dell'Europa, ma di un Sud forte delle sue ragioni, delle sue tradizioni,
della sua storia, delle sue possibilità, perfettamente integrate
con l'Italia e con l'Europa.
Certo, non si possono cancellare in un sol colpo questioni come ad
esempio quella relativa "all'economia della catastrofe",
(com'è stata definita la politica di intervento per le zone
terremotate), oppure quella degli "ammazzamenti" che monopolizzano
le cronache. Tuttavia si deve riflettere e discutere, non solo per
riferire, commentare, giudicare e magari condannare. Ma anche per
capire. Solo due riferimenti. Primo: non è vero che la spesa
pubblica, nel Sud, cumulate insieme ordinaria e straordinaria, sia
quantitativamente superiore a quella che una ordinata redistribuzione
delle risorse le assegnerebbe. Secondo: il fenomeno malavitoso, almeno
in alcune regioni, può essere contenuto. Si afferma, in proposito,
che è necessaria una incidente politica di risanamento e di
sviluppo. Allora, alcune domande: vi può sopperire, in luogo
dell'intervento pubblico, se non del tutto almeno in parte, il privato
e quindi il mercato? Vi sarebbero, però, due nodi da sciogliere.
Come si fa a garantire la neutralità della "politica"
che comunque non è solo un'esigenza esclusiva del Sud? Come
si può garantire che i nuovi investimenti non siano considerati,
se pubblici, nuovo alimento per la delinquenza organizzata; e, se
privati, controllati, se non addirittura indotti dalla stessa? Chissà
se ci saranno indicazioni in merito, nell'immediato futuro.
Addio, ragazzi
del '43
Luigi Compagnone
Quarantasette
anni e mezzo fa, il 27 settembre '43, cominciarono le Quattro Giornate
napoletane. Tredici anni e mezzo fa, agosto '77, il boia nazista Kappler
evase a Roma dall'ospedale militare del Celio. Qualche giorno dopo,
un quotidiano politico della Germania Federale scrisse tra l'altro
che noi italiani' avremmo dovuto farla finita di parlare della Resistenza,
poiché essa fu "soltanto una manovra per metterci dalla
parte dei vincitori". Spero che, dopo la caduta del muro di Berlino,
sia caduto anche quell'articolista. Il quale forse non sapeva, o fingeva
di non sapere, che la Resistenza italiana era nata a Napoli, e che
tra i ribelli (come gli imboscati chiamavano i partigiani) si videro
molti ragazzini dei nostri vicoli. E molti di loro persero la vita
dopo aver fatto saltare in aria più di un carro armato teutonico.
Quei ragazzini non avevano combattuto per "mettersi dalla parte
dei vincitori". Quando gli innocenti si rivoltano contro i carnefici,
non si mettono dalla parte di nessuno. Essi pensano soltanto, per
istinto e per sofferenza, a liberarsi dalla violenza e dal terrore.
Come fecero quei ragazzini, che dettero una lezione di vita civile.
Essi, gli "scugnizzi". Ossia i diseredati.
Ma tutti i napoletani - ripeto, tranne gli imboscati - divennero "ribelli".
Ossia offrirono una civilissima lezione. Un solo esempio: il colonnello
Scholl, che aveva fatto massacrare gente inerme, un giorno offrì
un compenso di "lire mille e viveri" a ognuno che gli avesse
consegnato un "traditore". Napoli, che di fame se ne moriva,
rifiutò quei viveri e respinse il ricatto della fame. Esempio
raro di fame e nobiltà. Eppure la fame è stata sempre
il nostro nume indigeno. Una storpia letteratura ha rappresentato
questa città come una affamatissima tribù che si arrende
sempre ai maccheroni. Nessuno ha mai accennato ci una Napoli che,
almeno quella volta, non si arrese alla pastasciutta. Fu questa, soprattutto,
la sua grande Resistenza. Una resistenza al di sopra del color locale,
al di sopra dei soavi e sospirosi canzonettari. Ma quella resistenza
al morsi dello stomaco non ha fatto ancora storia né letteratura,
anche se è viva nella memoria della nostra giovinezza.
Quarantasette anni e mezzo sono passati. Quasi un nero mezzo secolo.
E Napoli si è arresa ad altri morsi. Non i morsi della fame
vicaiola. Ma i morsi della fame miliardaria, nel cui nome si uccidano
persino i ragazzini. Anche questi, vittime innocenti. Come i ragazzini
del '43.
Vogliamo celebrarli? E celebrare quelle quattro splendide e terribili
Giornate? Cretineria burocratica. E ipocrisia. Perché non si
celebra un rimorso. Il rimorso di aver tradito quella Napoli, che
resistette ai viveri e alle lire dei colonnello Scholl. Ma che oggi,
almeno in gran parte, non resiste a camorre d'ogni risma e d'ogni
ceto, affamate di miliardi e corruzione, di appalti e mangerie, di
imbrogli e di delitti.
Addio, quindi, ragazzi del '43. Non siamo degni di celebrare il vostro
esempio, né degni di onorare a freddo la speranza con cui alimentaste
la nostra giovinezza. E poi, perché portare in giro la vostra
fiaccola di verità? Magari si corre il rischio di bruciare
una barba o una parrucca. Fetide barbe, fetide parrucche. Fetida "nuttata",
che non passa da se stessa. Facciamola passare. noi, senza nessun
rispetto per le barbe. le parrucche, i miliardi e la paura.
Italia e Mezzogiorno
La decadenza
risale alla fine di Roma
Guido Salerno
Coloro i quali
ritengono di poter dividere l'Italia in partes tres (com'era la Gallia
ai tempi di Giulio Cesare) forse non sanno, o sanno molto bene, che
dividere la penisola a qualsivoglia livello significa decretarne la
fine. Questo, almeno, insegna il passato. Accadde così, infatti,
con la prima divisione della storia, avvenuta nell'evo antico, dopo
oltre mezzo millennio di unità trascorsa, prima, tra il III
e il I secolo a. C., in maniera provvisoria e parziale (sia in termini
geografici sia dal punto di vista politico-amministrativo), nella
forma della "federazione" che legava a Roma e ai territori
che facevano parte integrante della Repubblica, una per una, le singole
e varie comunità "italiche" (dell'Etruria e della
Magna Grecia, dei Sanniti, degli Umbri, dei Campani, degli Apuli,
dei Lucani, dei Bruzi, ecc.); poi, dal I secolo a.C., in senso integrale,
dopo l'estensione della cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell'Italia,
dallo Ionio alle Alpi, e la loro comune e generale organizzazione
nel sistema dei municipi.
Unificata dunque da Roma, dopo essere stata per secoli un vero e proprio
mosaico di popoli, di costumi, di lingue, l'Italia fu dalla stessa
Roma divisa, alla fine del III secolo della nostra era, per ragioni
strategiche e nell'ambito della generale riforma amministrativa cui
l'imperatore Diocleziano sottopose l'Impero per adeguarlo alle mutate
esigenze di governo e soprattutto alle sempre gravi necessità
della difesa.
L'Italia che, alla stregua delle province (quasi sempre sdoppiate),
era stata inclusa in una "diocesi" (la VII, detta Italiciana)
comprendente, oltre la Sicilia, la Sardegna e la Corsica, anche la
Retia, a Nord (vale a dire gran parte della Baviera e il Tirolo) e,
a Sud, la Numidia e l'Africa Proconsolare (cioè l'Algeria,
la Tunisia e la Tripolitania), fu al suo interno divisa in due parti
o "vicariati", dal titolo di Vicarius che ebbero i rispettivi
governatori. Linea di divisione tra le due parti, il "confine"
naturale - l'Appennino tosco-emiliano, tra i fiumi Magra e Rubicone
- che separa l'Italia peninsulare da quella continentale e che già
era stato politicamente operante prima del 49/42 a.C. quando, per
volere di Cesare, divenne Italia anche la Padania, che fino ad allora
era stata la provincia della Gallia Cisalpina.
L'Italia a nord dell'Appennino fu denominata "annonaria",
dato che, come già accadeva in genere per le province dotate
di una certa ricchezza e di una buona produzione agricola, essa venne
sottoposta al tributo in natura a favore dell'Annona dello Stato;
l'Italia a sud dell'Appennino fu detta invece "urbicaria"
(o "suburbicaria") semplicemente perché in essa si
trovava l'Urbe o, meglio, perché in vario modo essa gravitava
(anche col compito di rifornirla) attorno a Roma, la quale peraltro
ne faceva parte. Roma, infatti, conservò la sua - autonomia
di governo che, per quanto non fosse di competenza del Senato, faceva
capo alla carica tradizionale del Praefectus Urbis (il "Prefetto
della Città") affiancato ora da un Vicarius del Prefetto
del Pretorio.
Il governatore dell'Italia "annonaria" ebbe il titolo, abbreviato,
di Vicarius Italiae, con sede a Milano; il governatore dell'Italia
"urbicaria" prese ovviamente il titolo di Vicarius Urbis:
sede naturale, Roma.
E' appena il caso di sottolineare come in queste titolature il nome
Italia fosse riferito alla sola Italia settentrionale la quale, da
questo punto di vista, si trovò ad essere (o così dovette
apparire) come l'unica Italia o l'Italia per eccellenza (ciò
che accentuò la divisione anche in senso nominale). Per l'Italia
centro-meridionale e insulare tornarono così più facilmente
(e come segno d'incipiente disgregazione) a prevalere i nomi regionali
(Apulia, Campania, Umbria, Samnium, Etruria e poi Tuscia), fortemente
caratterizzati e di antichissima e tenace tradizione, mentre nell'Italia
settentrionale i nomi regionali continuarono a rimanere in sottordine,
essendo alcuni artificiali (Aemilia, Transpadana), altri di accezione
territorialmente meno compatta e definita (Liguria, Venetia). La conferma
si ha negli scrittori dell'epoca, specialmente cristiani, i quali
facendo riferimento all'articolazione interna dell'Italia considerata
ancora come un'unità, elencano i diversi nomi delle regioni
centro-meridionali facendoli poi seguire da quello dell'Italia, con
l'evidente significato di "parte restante dell'Italia" che
però, essendo - questa - quella settentrionale, faceva di essa
la sola ad essere designata complessivamente con quel nome.
Ad agevolare poi la distinzione, stava il fatto che tutta l'Italia
settentrionale si trovava in un periodo di prosperità e di
progresso civile senza precedenti, proprio mentre l'Italia centro-meridionale
e insulare stava andando incontro ad una crisi dalla quale, sia pure
con gli alti e bassi dei secoli successivi, si può dire che
non si è più ripresa (sicché è possibile
anche affermare che nacque allora il "problema meridionale").
Diventa infatti assolutamente antieconomica ogni attività,
dall'agricoltura, già da tempo compromessa dalla piaga dei
latifondo, all'artigianato "industriale" privo di sbocchi
di mercato; e con la disoccupazione era subentrato lo spopolamento,
mentre si diffondeva la malaria e imperversava il brigantaggio.
Quanto alla fioritura dell'Italia settentrionale, essa era stata grandemente
favorita per il fatto che la regione s'era venuta a trovare, nel giro
di pochi decenni, al centro dell'Impero o, quanto meno, degli interessi
e delle iniziative del governo centrale, tutto intento alla difesa
delle pericolanti frontiere del Reno e del Danubio e alla salvaguardia
delle province transalpine, delle quali la Padania costituiva, rispetto
alla loro "prima linea", il naturale "retrovia".
Si aggiunga la funzione di "cerniera" che la stessa Padania
esercitava tra la parte occidentale e quella orientale dell'Impero
(sempre più spesso divise, ma ancora strettamente legate) e
la conseguente importanza dei collegamenti e dei traffici (militari
e annonari, prima di tutto; ma inevitabilmente anche culturali e artistici,
economici in senso lato e persino religiosi) che l'attraversavano
passando per un asse Est-Ovest che aveva completamente soppiantato
quello Nord-Sud, aggravando così l'emarginazione del Mezzogiorno,
ormai escluso dalla "circolazione vitale" dell'Impero.
Così fu per tutto il IV e per buona parte del V secolo. Le
cose cambiarono con le invasioni "barbariche". Tramontato
l'Impero di Roma, Goti, Longobardi, Bizantini, Franchi, non riuscirono
più, di volta in volta, a far propria l'intera Italia. Anzi,
se ne disputarono fieramente le varie parti. E allora fu tutto un
seguito di divisioni che riportarono la situazione a un nuovo mosaico,
almeno da un punto di vista politico-amministrativo. Perché
l'idea dell'Italia come entità unitaria rimase, nonostante
tutto, viva e operante (anche se, significativamente, il "Regno
d'Italia" ricostituito nel Medio Evo, all'interno del Sacro Romano
Impero, riguardò solo l'Italia settentrionale; come sarà
poi, del resto, molti secoli dopo, col Regno dell'Italia napoleonico).
E per tornare all'antica unità dovettero trascorrere circa
quindici secoli.
Sul filo della
memoria
Il Sud e il
"Mondo"
Il problema meridionale
venne posto dal settimanale fondato e diretto da Mario Pannunzio (e
uscito dal febbraio 1949 al marzo 1966), con grande energia, al centro
dell'attenzione. Tale sottolineatura fu affidata, significativamente,
alla penna di Ugo La Malfa. "Se noi vogliamo dare un significato
- egli scriveva nel '49 - uno scopo, un fine alla nostra attività
nazionale, se noi vogliamo trovare qualcosa di nuovo e di estremamente
impegnativo intorno a cui galvanizzare le forze della giovane Italia
democratica, se vogliamo dare uno slancio alla nostra capacità
creativa, dobbiamo far perno sul problema, storicamente tramandatoci,
del Mezzogiorno. Nessun altro problema è più maturo
e più impegnativo di questo e nessun problema può essere,
allo stato delle cose, dopo aver dato una certa struttura politica
al nostro Paese, più urgente di questo".
Nel modo in cui "Il Mondo" affrontò la questione
meridionale appare evidente la confluenza di due linee di pensiero
(una confluenza, peraltro, che caratterizzò un po' tutta la
rivista): quella di Salvemini e quella di Croce. Fu infatti Vittorio
De Caprariis (un intellettuale di formazione crociana) a rendere omaggio
a Salvemini sulle pagine del "Mondo", scrivendo: "Negli
Scritti sulla Questione meridionale direi che l'attenzione a collegare
il particolare al generale, a cogliere il nesso tra i problemi e una
situazione generale è così evidente che bisogna essere
lettori veramente distratti per non avvedersene. E certamente questa
attitudine a risalire continuamente dai dati concreti ai fatti più
generali e ai principi non è l'ultimo merito di un libro che,
iniziato cinquant'anni fa, nel 1896, sembra che sia stato tutto scritto
ieri". E di Salvemini "Il Mondo" condivise il giudizio
sull'attività di agitazione sociale e politica svolta dai comunisti
nel Sud ("I comunisti cercano ovunque i punti d'appoggio per
sollevare il più esteso malcontento possibile. E in quel lavoro
per reclutare comunque malcontenti promettono tutto a tutti, anche
se quel che fanno sperare agli uni fa a pugni con quello che fanno
sperare agli altri").
Si può dire che la linea portata avanti da "Il Mondo"
sul problema meridionale si differenziò profondamente sia da
quella dei comunisti (che era puramente strumentale e finalizzata
a una politica antiliberale e antidemocratica) sia da quella di coloro
che non vedevano l'importanza di un grande impegno nazionale per l'industrializzazione
del Sud e si limitavano ad auspicare le condizioni in cui le modeste
attività artigianali e industriali, più naturali e meglio
rispondenti ai bisogni dei luoghi, potessero vivere, svilupparsi e
progredire. Contro questa impostazione insorgerà Francesco
Compagna, per il quale lo Stato non poteva limitarsi ad assecondare
con una politica di incentivi un fragile tessuto di piccole imprese.
Certo, non si trattava di creare artificialmente qualcosa dal nulla,
bensì di infrangere quel "privilegio per cui attualmente
una parte del Paese accentra nelle proprie mani la produzione degli
strumenti del lavoro proprio e del lavoro dell'altra parte".
L'obiettivo era dunque di "rendere le condizioni di partenza
dell'insediamento industriale in determinate "zone industriali"
del Mezzogiorno uguali alle condizioni di partenza che le iniziative
incontrano nelle regioni meglio dotate del Nord".
Ed è stata questa, in effetti, la politica seguita: una politica
che ha registrato errori e sconfitte, ma anche successi, e in taluni
casi grandissimi successi, al punto che l'economia e la struttura
sociale meridionali hanno conosciuto uno sviluppo notevolissimo, che
non trova riscontri in altre regioni arretrate dei Paesi industrializzati.
A questa politica il liberalismo democratico del "Mondo"
diede, negli anni difficili della sua impostazione e del suo avvio,
un contributo tutt'altro che trascurabile di analisi, di idee e di
proposte Sarà un vero peccato, se andrà perduto (per
i risvolti attuali, soprattutto) per colpa di pregiudizi nordisti
e della criminalità mafiosa meridionale.
La disoccupazione
giovanile
Drammi meridionali
Franco Compasso
Per affrontare
alla radice il secolare divario che contrappone il Sud al Nord dei
Paese, occorre attivare una seria e radicale politica per l'occupazione.
E' sempre il Mezzogiorno l'area più colpita dalla disoccupazione.
Ed il dato più allarmante consiste nella crescita della disoccupazione
giovanile nelle regioni dei Sud. Ancora una volta, la Svimez si è
incaricata di fornirci un quadro obiettivo della condizione dell'occupazione
in Italia: nel 1988 la disoccupazione meridionale registrava un allarmante
segmento di essa, pari al 70% di persone in cerca di prima occupazione.
La disoccupazione effettiva, rimasta pressoché invariata nell'intero
Paese tra il 1987 e il 1988, di fronte ad una contrazione nelle regioni
centro-meridionali (-8,7%) faceva registrare un sensibile aumento
nel Mezzogiorno (+8,1%). In questi ultimi anni, le politiche per l'occupazione
(in particolare la 863/1984) hanno continuato ad operare con scorsi
risultati per il Sud. Si è infranto nella realtà meridionale
l'enfasi scriteriata azionato a tutto vapore per esaltare Il "miracolismo"
dei contratti di formazione-lavoro. Introdotti per favorire l'occupazione
giovanile attraverso una maggiore liberalizzazione dei mercato dei
lavoro (la 863 consente alle imprese di assumere, con richiesta nominativa
e rapporto a termine, giovani tra i 15 ed i 29 anni), i contratti
di formazione-lavoro hanno conseguito risultati negativi per l'occupazione
giovanile nel Sud. I dati parlano chiaro: nel 1988 i contratti di
formazione-lavoro hanno interessato complessivamente, a livello nazionale,
493.643 unità lavorative, di cui solo 44.473 nel Mezzogiorno
(449.170 nel Nord).
E' amaro constatare come sia tuttora troppo debole la partecipazione
dell'apparato produttivo dei Mezzogiorno all'utilizzo delle nuove
strategie e dei nuovi strumenti previsti dalle politiche per l'occupazione.
Ciò non aiuta i giovani dei Sud a trarre vantaggio da norme
ed incentivi che avrebbero dovuto creare in loco occasioni di lavoro
aggiuntive. Ancora una volta è il Nord che piega al suo profitto
leggi predisposte per favorire la ripresa produttiva ed occupazionale
del Sud. E troppo chiedere ai leghisti lombardi di riflettere su questi
dati prima di dare fiato ai loro tromboni?
Aspirazioni e frustrazioni dei giovani meridionali, esigenze di diplomati
e laureati che intendono il lavoro come un diritto e non come un privilegio
elargito dai potentati clientelari sono al centro di una vasta, documentata
ed interessante indagine, curata dal sociologo Alessandro Cavalli,
per conto del Formez-Iard. La condizione giovanile nel Mezzogiorno
è stata scandagliata in tutta la sua complessa realtà:
la radiografia dei Formez è oggettiva ed impietosa. Essa scruta
nella profondità di un "sistema" meridionale che
persiste ad elargire "posti" e non a garantire il lavoro.
Lunghi decenni di clientelismo arrogante hanno alimentato l'illusione
- come osserva acutamente il Presidente del Formez, Sergio Zoppi -
che "il diritto al lavoro (ma anche la produttività e
l'utilità sociale dei lavoro) si vanifica spesso nella gestione
clientelare dei "posto"".
La condizione giovanile nel Sud appare in tutto il suo peso di irrisolto
dramma civile e sociale quando si registrano perverse connessioni
tra le opportunità di lavoro e le attività illegali,
la marginalità e la precarietà dell'occupazione "ingessate"
nell'economia sommersa di vaste aree urbane, la difficile convivenza
con la forza-lavoro extracomunitaria. Tutto ciò conduce ad
esasperare condizioni di rassegnazione e fatalismo in cui vivono migliaia
di giovani meridionali che, come indica la ricerca, non "hanno
fiducia sulla possibilità di esercitare qualche controllo sul
proprio destino". la realtà complessa del Sud non può
farci abbandonare le strade della speranza e della fiducia. E di fronte
ad una condizione giovanile, che nel suo complesso èdrammatica
e preoccupante, avvertiamo segnali che indicano una fase di crescita
di alcuni valori, In particolare tra i giovani con li velli di istruzione
e tassi di partecipazione associativa superiori alla media. Essi credono
e si battono per avviare un processo di modernizzazione della società
e delle istituzioni. E' vero: si tratta di un processo lungo e complesso,
che ha però una dinamica propria inarrestabile, e che alla
distanza potrà avere ragione dell'attuale immobilismo. In fondo
la "fiducia" è la prima risorsa morale e civile dello
sviluppo, l'unica capace di sradicare nel Sud la rassegnazione e la
subalternità ad un potere clientelare corrotto e corruttore.