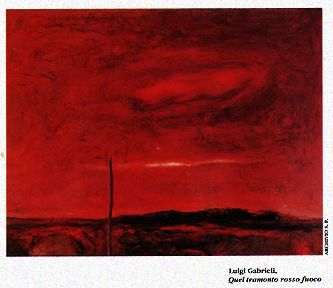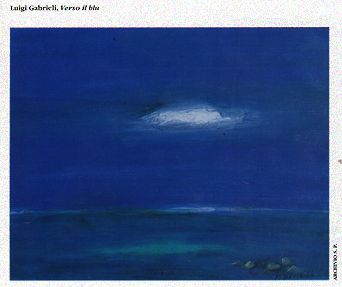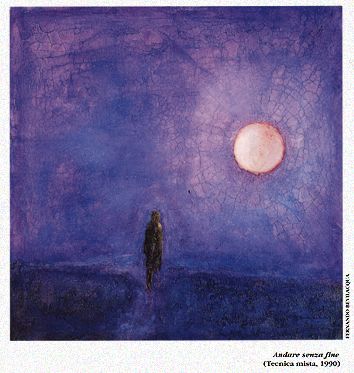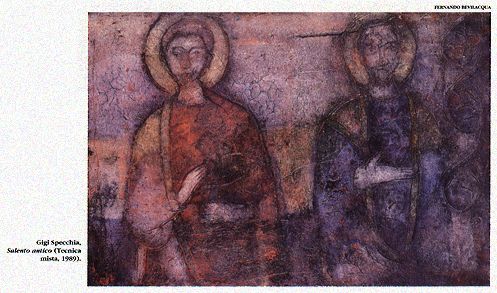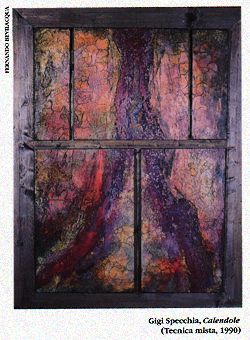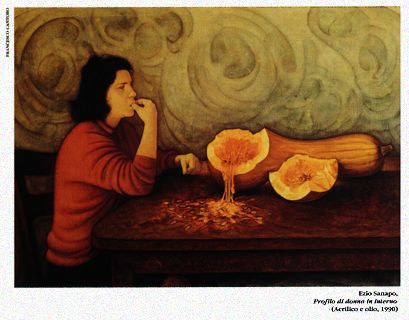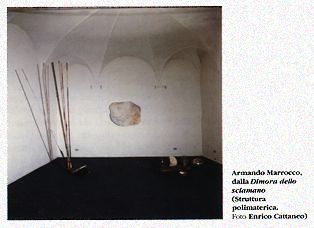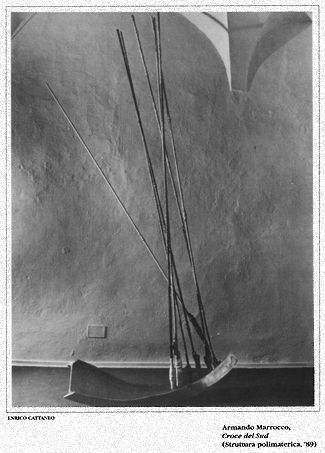Il
colore dell'esilio
Luigi Gabrieli
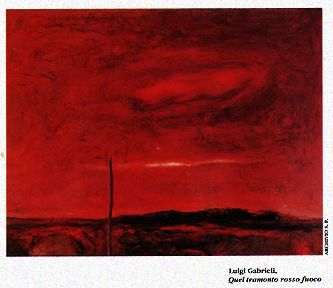
Si può
spendere una vita sperimentando.
Sperimentando la pedagogia, per esempio, nel difficile mestiere dell'insegnamento;
o in quello, ancora più impegnativo, dell'organizzazione e
della direzione di un istituto d'arie. Ci vuole molta passione per
districarsi tra i meandri e i cavalli di frisia della burocrazia,
per alzare pietre e aule, per articolare i canoni. scientifici del
lavoro e proiettarli poi come scommessa per il futuro dei giovani.
E' passata anche per queste iniziative la strategia della formazione
professionale di cui parlavano i meridionalisti più credibili
nei giorni in cui si doveva fermare un'emigrazione che dissanguava
il Sud e si doveva risolvere il problema. del pane quotidiano. Chi
ha la memoria corta ha dimenticato tutto questo, e ha messo in un
angolo grigio della storia locale chi ha operato in silenzio, ma concretamente
e con dedizione, pagando anche in prima persona, in questa missione
ideale. E, specularmente, si può spendere il resto della propria
vita sperimentando l'esercizio macerante dell'arte, in un cono d'ombra
riservato e schivo, lontano comunque dai clamori della mondanità
e dalle speculazioni del mercato: recuperando di volta in volta i
valori intuiti, e traducendoli sulla tela nella loro intatta essenzialità.
Così Gabrieli ha vissuto questa contraddizione: uomo d'attività
pubblica, punto di riferimento di docenti e di giovani intelligenze
da formare e da consegnare alla società; e maestro di cospicua
caratura e di originale spessore per la sua parte privata di esistenza,
dietro le pareti.- bianche di una casa e di uno studio che sono scrigni
con ricchezze artistiche inestimabili. Ricchezze fruite da pochi,
e forse pochissimi amici ed estimatori: ai quali le porte non si aprono,
si spalancano. E allora soltanto si può sfogliare una crestomazia
superba di opere e leggere in presa diretta un continuum al quale
il tempo non ha lasciato alcuna patina: tanto è fresco - e
attuale - lo svolgersi delle immagini, e tanto la sintonia tra l'evento
e la sua narrazione è enucleata dal contesto della cronaca
ed è trasferita su un piano metastorico.
Una pittura remota, dunque, dalla caducità del documento e
dalla estemporaneità del (neo)realismo. E tutta dentro ai valori
e ai simboli di un mondo autentico e profondo, con gli echi eterni
della sua solitudine, dei suoi assorti stupori, del suo sottile dolore:
che tessono la trama di vite altrimenti larvali. Ed è forse
per questo che anche all'interno delle soluzioni formali più
eleganti si coglie il filo di una segreta malinconia: balenante appena,
e affidata al segno dello spazio e del colore, al fondale di una luce
sorgiva, all'inquietante scenario che travalica sempre i confini della
tela, alle intense sinfonie del colore. Non è la collera dell'emarginato,
è la pietas dell'esiliato nel microcosmo del borgo natio; ed
è il sigillo di una dimensione artistica e di una valenza intellettuale
che non si sono consumate in se stesse, ma hanno rotto schemi mentali
e sbarramenti culturali locali per farsi matrice vitale di un 'arte
che ha frantumato le cesure dello spazio e le angosce del tempo. A
suo modo, un Ulisside che, navigando i mai! inesplorati della ricerca,
e - capitolo per capitolo, cantica dopo cantica - narrando l'umana
testimonianza della sua avventura, ci lascia presagire la sua irraggiungibile
Itaca: la sua "ragione" artistica ultima e pur mai esaustiva,
messaggio etico - anche - che emerge dal deserto argilloso all'ombra
della Serra di Sant'Ermete.
Scarabocchiavo i quaderni. Già alle Elementari ebbero modo
di notare che ero un disegnatore. I miei genitori, allora, mi invogliarono
a studiare arte. I mezzi economici erano scarsi, ma con molti sacrifici
frequentai la Scuola d'Arte "Giuseppe Pellegrino" di Lecce.
Mai chiesto nulla a nessuno, e mai le autorità pubbliche si
interessarono a me, se non per "consigliare" i miei a ritirarmi
dagli studi per non pesare sulla famiglia. Finite le scuole leccesi,
cominciai a dipingere, per procurarmi qualche migliaio di lire e poter
studiare all'Istituto d'Arte di Firenze. Alti! sacrifici, miei e familiari.
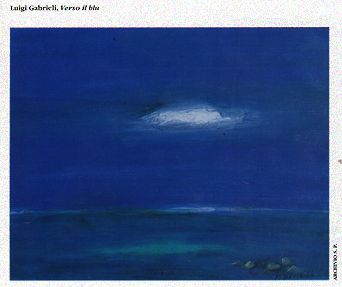
Appena diplomato, sostenni l'esame del Corso Magistrale - così
si chiamava allora - conseguendo l'abilitazione all'insegnamento delle
materie artistiche. Ritornai a Matino. Mio padre era morto. Tentai
le vie dell'impiego, e non quelle dell'arte, perché dovevo
sopperire alle necessità della famiglia che aveva vissuto tutta
per me. Umano e logico che mi comportassi così. Del resto,
non mi sono sposato, pur avendolo potuto fare. Ebbi alcune ore d'insegnamento
all'Istituto d'Arte di Lecce. Dopo tre anni, morto il presidente Pellegrino,
cercarono di allontanarmi. Mi recai a Roma, esposi il mio caso a un
capo-divisione del Ministero. Riottenni l'insegnamento e, dopo un
anno, il trasferimento a Sulmona. Poi, passaggio a Castelmassa, in
provincia di Rovigo: ci rimasi sette anni. In seguito venni nominato
titolare della cattedra di Disegno Geometrico e Professionale di Castelmassa.
Non potendo raggiungere quella sede perché era in corso la
guerra, rimasi a Lecce, insegnante in una scuola "non classificata",
poi in una "classificata", un Istituto d'Arte, addirittura,
ma con stipendio inchiodato, cioè analogo a quello della "non
classificata". Proteste inutili. Fino a che venni nominato Direttore
di un Istituto d'Arte in Sicilia. Non accettai perché non volevo
abbandonare famiglia e terra natale. Dopo diversi anni, fui nominato
Direttore dell'Istituto d'Arte di Poggiardo: una scuola tutta da organizzare.
Titubai, ritenendo il compito molto arduo. Fu il Direttore dell'Istituto
d'Arte di Lecce, Barletti, a spingermi ad accettare, anche per venir
fuori dall'iniqua posizione in cui mi trovavo. Lavorai sodo. Infine
venni trasferito all'Istituto d'Arte di Parabita, di nuova istituzione.
Vi rimasi per quattordici anni. Fine della mia odissea. Ora, eccomi
qua.
C'era una ragione per la quale eri considerato eccentrico?
Quando, a Lecce, mi venne affidato l'insegnamento di Decorazione pittorica,
cercai di dare un nuovo movimento all'arte, facendola uscire dalle
vecchie, radicate tradizioni delle scuole e delle botteghe d'arte,
che si incentravano solo su esercitazioni di disegno dal vero. Sono
cresciuti in questa concezione alunni diventati poi tra i migliori
pittori, da Pignatelli a Massari e a De Filippo. Dalla copiatura accademica,
fotografica, di mestiere, alla ricreazione personalizzata: questo
fu il passaggio rinnovatore, al quale partecipò un altro insegnante
di valore, Aldo Calò. Per parte mia, portai avanti quel discorso
creativo fino all'ultimo giorno d'insegnamento, e chi ne ha fruito
ha avuto poi splendidi riconoscimenti.
Sei partito da un tipo di paesaggio e di figurativo che in fondo avevi
intorno, era quello che ti circondava: natura e antropologia ti mettevano
a disposizione tutto quel che volevi vedere, osservare con i tuoi
occhi. Vogliamo parlare di questo primo periodo della tua pittura?
A dire il vero, non ho mai avuto maestri. Mi ritengo un autodidatta.
Ovunque sono andato, ho solo perso degli anni. Anche a Firenze, al
tempo in cui frequentavo l'Istituto d'Arte, si era in condizioni di
arretratezza didattica. Stesso discorso per Lecce: riproduzione tale
e quale, per essere considerati bravi. Allora mi proposi di esternare
quel che sentivo, e senza mettermi in commercio, perché non
ho mai ambito vendere quadri per vivere. Ma rimanevo ancora legato
al vero, anche se in una forma molto diversa dal verismo calligrafico
corrente. Fino a che ho sentito la necessità di contenere il
nostro paesaggio nella più semplice maniera possibile, e nella
più essenziale, senza smarrire quella che è l'autentica
fisionomia della nostra terra e della gente che ci vive: ho dato alla
campagna quell'arsura, quella durezza che il contadino deve vincere,
col lavoro, per farla produrre, cioè per umanizzarla. Poi ho
dipinto cose che mi sembrano interessanti, non più segnate
da quella iniziale semplicità, ma più impressionistiche:
il quadro vive in paesaggi di luce, di aria, di sole, di gente, e
diventa operante, e nello stesso tempo segno di vita vissuta. Mi sono
immedesimato nella gente che anima questa terrra col suo lavoro, senza
perdere di vista lo scenario paesaggistico, con i suoi propri cieli,
con le sue proprie nuvole che passano e si disperdono, con i sassi
che affiorano, con le case che chiudono infinite solitudini.

Quale rapporto
c'è, nei tuoi quadri, fra il tema e il colore?
Il tema è la nostra terra. Il colore è determinato dai
continui mutamenti dell'atmosfera, delle scene tante volte drammatiche,
che impressionano, che meravigliano; dai cieli di Terra d'Otranto
che, dall'alba, variano di minuto in minuto, e si fanno luminosi,
turbolenti, a momenti apocalittici: sempre bellissimi, perché
cieli di poesia.
Tu dici che ormai tutti dipingono. Ma tu drammatizzi il colore, e
dunque il quadro. E questa drammaticità la rendi con colori
forti, anche con colori scuri. Tutta la problematicità della
vita è sottesa nelle tue tele. Mentre moltissimi vedono un
Salento un poco idilliaco, con serenità diffusa, con espressioni
chiariste. Come mai questa tensione nella tua arte?
Dipende, dalla natura. Io sono stato sempre poco tranquillo, e d'altro
canto non mi hanno mai lasciato in pace. Allora esprimo questa pittura
tesa, tragica anche, quasi mai idilliaca. E forse è stato un
bene avere trasposto tensioni, difficoltà, dolore, nelle sere,
nelle albe e nei giorni che si affacciano, nei tramonti e nei giorni
che finiscono: nei crepuscoli, più che nella luce piena. Nella
luce piena è come se veda qualcosa di non bello della vita.
La luce piena fa vedere troppe cose che non piacciono e che atterriscono.
Poi c'è stata ancora un'altra stagione...
Quella dell'astratto. Ho pensato che tutto quel che avevo fatto era
facile da raggiungere, mentre l'astratto è tutt'altro che agevole.
Non basta sporcare una tela, non èsufficiente sottendere una
figura. Nell'astratto vivono solo la materia e le emozioni.. sono
escluse le avventure.
L'avventura ci fa incontrare tanta commercializzazione e così
poca arte...
E' così. Per questo dico che ormai tutti dipingono. Ma l'arte
dov'è?
Parliamo dei tuo rapporto col mercato. Tu non ami esporre, e vendi,
se vendi, col contagocce. Perché?
Perché ritengo che non siano cose di grande interesse.
Ma questo non deve giudicarlo chi vede le tue cose?
Gli intenditori sono pochi.
E non è, questo, un modo di non far partecipare anche questi
pochi intenditori alle emozioni dell'artista? In altre parole: non
sei un po' egoista?
Sono egoista perché non vendo, e non vendo perché non
mi sento di barattare un mio quadro. E poi, il mercato è quello
che è. Qui ci ,sono falsi mecenati, che pensano di comprare
per investimento. Comprano a futura memoria, per accrescere dei capitali.
Queste operazioni noti possono essere condotte in Puglia, ma nei grandi
centri metropolitani. Da noi sono occasioni rare. E poi, confesso
francamente, non vendo perché non sono mai contento di quello
che faccio. Non lo ritengo all'altezza della grande pittura. Io non
mi sento un grande pittore. Io me le guardo, le mie tele. Me le godo
io...

Quale impulso
ti dà l'ispirazione, e ti porta di fronte a una tela bianca?
Ho cercato sempre, in questi ultimi tempi, di fare il paesaggio per
il solo fatto che non ho mai potuto avere delle modelle. E poi il
paesaggio mi emoziona di più, e ha un gran numero di variazioni.
Con la figura si può cadere facilmente nella retorica e nell'accademia,
cioè nel già visto. Ma è difficile anche il rapporto
col paesaggio, del quale è necessario seguire le trasformazioni
storiche e urbanistiche, le mutazioni, i movimenti evolutivi. Ecco
perché ho sempre sentito la necessità di aggiornarmi,
di vivere in sintonia col presente.
Tu hai scritto: "Pugliese di nascita, amo la mia terra".
Che cosa ti ha dato di più, questa terra?
La visione della buona gente, della gente sana, della gente onesta,
della gente semplice, della gente laboriosa. Ecco che cosa mi ha dato
di più. E io sento ancora questi valori.
Ma ora la gente è cambiata, almeno in parte; anche quella che
ti circonda...
E' cambiata parecchio, ecco perché mi sento e sono un isolato.
In parte è peggiorata, in parte è migliorata. Non mi
meraviglia niente di quello che succede, perché oggi ci siamo
moltiplicati, viviamo tutti un poco più stretti, c'è
in giro tanto materialismo, siamo condizionati da tanto consumismo.
Noi cerchiamo di cogliere i lati positivi. Quelli negativi li lasciamo
da parte, li colgano gli altri. Mi interessano le cose buone, apprezzo
i meriti. I demeriti non so capirli.
Progetti artistici?
Sento il bisogno di dover fare qualcosa. Cercherò di fare del
mio meglio.
In che direzione, e con quali altre ricerche?
Persevero sempre nella direzione di ricerca sulla carne viva della
tela. Può cambiare l'intonazione dei colori, secondo il mio
modo di sentire di un dato momento; ma la ricerca è una costante
che mi ha fatto sempre buona compagnia. E continuerà a farmela.
Tutto questo piace a Ercole Pignatelli, che quando scende da Milano
viene subito a trovarmi e vuoi vedere le mie cose. Dice - ma lo dice
lui - che sono un grande maestro, e a proposito delle mie tele fa
nomi di grandi pittori francesi o inglesi. Ma io non ci credo.
Non ti sottovaluti, forse, per contrappasso?
Dico quel che sento. Io so solo di essere molto rigoroso, perché
la pittura è difficile, l'arte è difficile, raramente
si raggiunge un capolavoro. Se poi nelle mie cose ci sono dei valori,
lo vedano gli altri. Io dipingo perché passo il tempo. Mi piace
dipingere e mi piace vedere, osservare ciò che ho dipinto.
Mi piace riflettere sulle mie tele. E mi fa piacere se un intenditore
trova belle le mie cose. Per questo persevero.
Una dedica di Pignatelli sul quadro "La masseria" dice:
A Luigi Gabrieli / il mio Picasso salentino". E' un giudizio
lusinghiero di un vecchio allievo...
Se restiamo soli, e gli amici non li abbiamo intorno, ma solo fuori
e lontano, è perché le nuove generazioni non sentono
la pedagogia dell'arte. Non so che cosa, quale meccanismo si sia rotto.
O sono le scuole, oppure è il modello di vita che è
stato imposto. Non parlo solo della pittura, ma della scultura, della
poesia, della musica classica. Lo spettacolo ha preso il posto della
bellezza. Ma i giovani si stanno sentendo defraudati, svuotati: e
vogliono colmare il vuoto perché non sono insensibili, e reclamano
una nuova spiritualità, quella che manca alle generazioni che
stanno in mezzo, tra la mia e l'ultima nata, e che hanno mandato in
esilio valori, contenuti, giudizi e rapporti con l'arte. C'è
solo il silenzio. C'è una zona di tetra e a volte insolente
indifferenza che ha creato solo tanta desolazione. Si guardi il caso
di Matino. Ho cercato di parlare di valorizzazione del centro storico,
e sono stato guardato di traverso, come se avessi detto cose insensate.
Così si sono consumati tanti piccoli delitti. Se manca ogni
sensibilità, se mi trovo intorno il deserto, che cosa posso
farci?
Il colore del
grico
Gigi Specchia
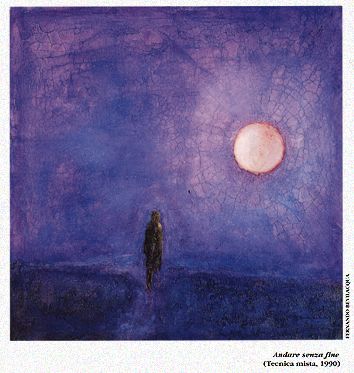
Un monumento corale
alla nostra storia. L'elemento basilare, tattile, che impasta le nostre
case, intride il nostro pane, coagula il nostro sangue, dà
spessore alle nostre parole. Umile e tenace, misterioso nell'origine
etimologica, disponibile a piegarsi all'estro creativo e poi irriducibile
nella presenza ilare e invadente. Totalizzante. Monocromo, eppure
maliziosamente correo nella condiscendenza mimetica che cattura e
rimanda metri timbrici e tonali di luci e di colori. Umanissimo. Tra
i "mari spenti e i sogni profumati e i corpi senza pelle"
che "seccano al sole", "danzano sulle cattedrali angeli
cui il tempo ha cancellato il volto": la Grecia di Specchia,
la piccola patria dal ventre carsico e dal corpo di tufo. Il tufo,
appunto: questa materia prima mai inerte, che celebra da millenni
il trionfo della malinconia mediterranea, mimetizzandola nelle laminature
balenanti della calce; questa nervatura vitale, che da età
immemorabili si è innestata nei gangli sensibili della nostra
civiltà e del nostro pensiero. Il tufo tentacolare. Il tufo
che ha alzato "cattedrali in negativo" nelle tagliate, nelle
cave in cui Fellini ambientò il suo Minotauro. Il tufo fiero
della sua disarmante povertà. Il tufo che ha svelato a Specchia
le sue campiture labirintiche, le favole, le allusioni, le allegorie,
e poi l'umana testimonianza della realtà: e ne ha fatto un
operaio sognatore.
A dichiararlo è proprio l'artista: "Lentamente, a mano
a mano che la grande spatola danzava sul tufo, nasceva il segno. Ognuno
faceva la sua parte.- l'uomo delle cave accendeva l'aurora".
Raccolta e accettata così, la confessione non sembra porre
problemi a chi si appaghi di una immediata, epidermica "diversità".
Ma chi spazi fra le scansioni del cammino pittorico di Specchia alti!
dati vede emergere; e quindi quella "diversità" appare
certamente uno snodo, ma più come consapevolezza, conoscenza,
dominio, che non repentina illuminazione. Il suo archetipo resta la
"piccola Grecia": ma da questo, e attraverso questo, ha
indirizzato l'investigazione all'interno e all'esterno del perimetro
grico, ha esplorato tutti i possibili rapporti, reticoli e coordinate
non stagionali, raccogliendo il senso autentico di quanto - nelle
radici, negli esiti - è espressione di una koinè, di
una civiltà che urla la sua nostalgia per un'origine tradita
e riconoscendosi in una accumulazione di stimoli e di esperienze della
vita collettiva. Ma, a dispetto di una morte dell'arte, in versione
hegeliana, non solo qui il ritorno della pittura è essenzialmente
costituito dal riaffiorare dello specifico che non ignora la tecnica,
né lo spettro dei linguaggi e delle metodiche, né la
cultura, né la storia dell'arte; né l'essere, la realtà,
il tempo. Il crogiuolo alchemico di Specchia non può essere
ritenuto un rozzo mortaio, un contenitore di inattive misture.
All'interno delle sue tele è intenso il dialogo tra materia
e simbolo, tra natura e ragione, tutti pittoricamente avvinti in un
'organizzazione sintattica che oggettiva una personale visione - e
filosofia - di un processo di coscienza creativa.. remoto, comunque,
da ermetismi esoterici, lo stesso "simbolo" restando in
lui retroterra antropologico, memoria ancestrale rielaborata in valenze
di solitaria - e rischiosa - modernità. Ad allontanare il rischio
è il rifiuto dell'effimero, delle forme arbitrarie che appartengono
alla periferia della semiotica, delle colorazioni infervorate in mistici
in trugli, dell'abbandono all'illusione rappresentativa. L'espansione
stessa della metafora di Specchia resta imbrigliata in segni pittorici
che non promettono cifre ambigue, ostentazioni, travestimenti; bensì
una realtà già conoscitiva ed anche emotiva: con i suoi
conflitti speculari - sofferti sulla pelle - tra gli orizzonti concreti
del mondo e la sfera onirica dell'anima. Che poi tutto questo abbia
saputo esprimere coniugando l'arenaria primordiale con incredibili
azzurri e rossi e pervinca e viola e marron, è approdo materico
cromatico, ed è segreto semantico di Specchia: la sua ultima
metafora artistica.
Sto perdendo la testa. Pensavo di poter lavorare chiuso nel mio studio.
Invece questo tipo di pittura mi ha creato un problema: mi ha costretto
ad uscir fuori, a stare tra la gente.
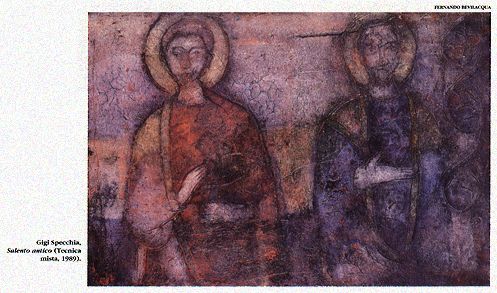
E allora?
E allora mi sono ritrovato. Ho come recuperato tutti gli anni della
mia vita e tutta la forza della mia dignità. Senza la pittura
non avrei conosciuto tanti amici, e mai avrei rotto il muro della
mia riservatezza. Ora devo convivere con tutto questo. Il passato
è veramente passato. Per questo ne parlo, ma: solo da un anno,
e con poche persone: perché voglio chiudere per sempre con
esso.
Che cosa ti dà il presente rispetto a quel passato?
Una vita semplice, serena, quella che tutti dovrebbero vivere. E poi,
io faccio il pittore per realizzarmi come uomo, non solo per guadagnare:
per migliorarmi, per stare insieme a tanti amici, per arricchire la
mia conoscenza e le mie conoscenze. Io ho avuto una vita difficile.
Mio padre aveva combattuto la guerra d'Africa, restando fuori per
otto o nove anni. Quando tornò a Sternatia, aveva i vestiti
a brandelli, si vergognava di entrare in paese; allora sedette sull'orlo
di un pozzo, in una nostra proprietà, e attese che passasse
qualcuno. Solo quando gli portarono degli abiti nuovi', venne a casa.
Per me ebbe inizio una vita molto dura, avevo quattro anni, e progettava
un mio futuro di ingegnere navale. A cinque anni sembravo invece destinato
a condurre le nostre terre. Mio padre era possessivo, non violento.
Quel senso del possesso fino a che punto ti condizionava?
Fino al punto che, per trovare un minimo di libertà, decisi
di fingermi pazzo: recitai la mia parte bene e a lungo, ne ero addirittura
orgoglioso. Ma evidentemente non avevo fatto i conti con l'intuizione
di mia madre, che una volta capì tutto: eravamo nella più
piccola stanza di casa, illuminata da una luce fioca. Quando si rese
conto che ero tutt'altro che folle, lo riferì a mio padre,
che mi picchiò. Ma per lei fu come un rito liberatorio. Ne
abbiamo riparlato trent'anni dopo. Anche lei era succube di un uomo
che, sebbene noto in paese come spirito mediatore, in grado di comporre
liti tra uomini e risolvere conflitti d'interessi, infondo era uno
spirito forte. D'altra parte, io non potevo ribellarmi e fuggire,
la famiglia per me era tutto. Quando mio padre morì, avevo
vent'anni. Eravamo in un Policlinico. Quando il medico ci fece capire
che ormai non c'erano più speranze, presi mia madre sottobraccio
e le parlai a lungo. Cominciavamo tutto daccapo.
E fino ad allora?
Fino ad allora ero stato costretto a lavorare in campagna, e a governare
i cavalli. Alle 4-4,30 del mattino seguivo alla radio il "Bollettino
dei naviganti", nella speranza che annunciasse piogge e tempeste:
così sarei rimasto in casa per dedicarmi alla pittura. Ero
stato a Roma per un breve periodo, avevo visitato musei e monumenti.
Ma solo una volta tornato in paese tutto mi era sembrato più
chiaro, più lucido nella mente. Avevo due amici che frequentavano
il liceo artistico. Proposi loro un progetto; io avrei messo a disposizione
la tela, loro l'avrebbero dipinta, e in questo modo io avrei appreso
i rudimenti dell'arte. Accadde invece che, comprata la tela, e chiesti
i colori ad un altro conoscente, presi i pennelli e il produssi un
Cristo che avevamo in casa; poi fu la volta di un giovane angelo di
Raffaello (che ora è alla Pinacoteca di Brescia): ma accorciai
l'età di quell'angelo, da 18-20 a 10-12 anni. In seguito, prima
esperienza in una galleria leccese.
Ci fu anche un'altra esperienza, emigratoria ed artistica...
Tre anni, a Milano, frequentando i corsi superiori nella Scuola d'atte
del Castello Sforzesco e alla Bottega degli Artisti, di Vincenzo Gatto,
allievo di Romiti, che era stato amico di Modigliani. Qui, in realtà,
sfruttavano un po' gli allievi. Ma io mi ero fatto furbo. Dissi che
non mi interessava la pittura, bensì la scultura. Infatti,
feci uno splendido esercizio di scultore, carpendo contemporaneamente
i segreti della pittura di Gatto. Quando feci ritorno in Terra d'Otranto,
mi misi a studiare il paesaggio con un fine preciso: capire bene l'anima
della mia terra, per poter essere pittorenarratore in grado di raccontare
sulla tela". Questo nuovo tirocinio si è concluso un paio
di anni fa.
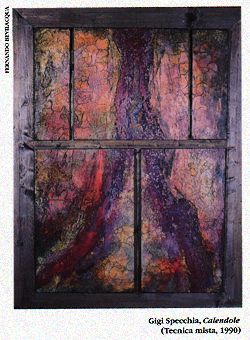
Dopo di che?
Ho incominciato a parlare del Salento in chiave non più locale,
ma universale, coni 'è universale tutto ciò che è
povero, umile, emarginato. Ho analizzato la storia dell'arte salentina
nel contesto nazionale e mondiale. E ho scoperto che i nostri pittori
avevano un grande valore: il colore. Il colore lo avevano nel sangue,
circolava nelle loro vene, dava un senso alla loro vita e alla loro
arie. Ma era anche la loro tomba, perché, tranne rare eccezioni,
non li spingeva sulla via della ricerca.
Che tipo di ricerca?
Quella che dà il ritmo dell'evoluzione e il polso delle mutazioni
della vita. Ad esempio: ad un certo punto, mi accorsi che chi veniva
nei nostri paesi, e a Sternatia per quel che mi riguarda, era attirato,
dalle straordinarie volte delle nostre case, dai pilastri che le reggevano,
dagli spigoli, dalle vele che le formavano. Ecco, mi dissi, un discorso
che può essere universale. Come universale era stata la poesia
che aveva illuminato una bellissima stagione del Sud. Così
"Foglie di tabacco" di Bodini ispirò la mia "Casa
salentina". E così "Agosto 1943" di Quasimodo
ispirò le mie "periferie", nelle quali descrivevo
certamente strutture salentine, ma che potevano essere anche quelle
di Harlem, di Soho, di Calcutta, del Cairo o di Rio: con la loro solitudine
infinita, con la miseria tangibile, con i silenzi di morte. E "Il
e a silenzio della morte" è il titolo dell'ultima mia
"periferia".
In Salento, come altrove nel mondo, ci sono anche "periferie
storiche" col fascino e col mistero del loro essere, possono
influire sul nostro modo di esprimerci, di realizzarci come uomini
e come artisti...
Sono le nostre bellissime "pietre", i menhir, i dolmen,
quel che resta del mondo messapico; e poi San Nicola di Casole, il
Centoporte di Giurdignano, il Centopietre e la stupenda dirimpettaia
chiesa di San Giovanni a Patù; e poi ancora le nostre strutture
urbanistiche, che sono uniche, case e corti e piazze e strade che
si possono vivere dall'interno, come salotti, ritrovi comuni della
gente comune: lo scenario nel quale si è svolta da sempre la
nostra storia, cioè la storia della gente semplice che ha realizzato
tutto questo perché l'arte e il colore, come ho detto, li aveva
nel sangue.
Noi siamo soliti parlare di "paesi abbaglianti" e di "sole
a picco". Ma Specchia non ha, quasi per contrappasso, un motivo
ispiratore diverso?
La notte e i notturni, che non sono mai tetri, da noi e nel resto
del pianeta. Sono quelli che emergono dalla luna borbonica di Bodini,
dalla luna all'orizzonte di Giovanni Francesco Romano, dalla luna-luna
di Garcìa Lorca: luna testimone, amore e dolore, commedia e
tragedia del nostro e di tutti i Sud. Luna come spia dell'amore negato
da un numero infinito di madri che per millenni hanno mentito ai propri
figli, di giorno, quando erano costrette a lasciarli per il lavoro
nei campi, e volevano esorcizzare il distacco e l'assenza; e spia
dell'amore viscerale' quando, la sera, li mettevano "alla lettèra",
e finalmente potevano liberare il gesto dolcissimo di una carezza,
ed esprimerlo, quell'amore privato e prigioniero, "sorvegliandoli"
nel loro sonno innocente.
Infine, e siamo ai nostri giorni, il tufo...
Io volevo descrivere le volte e i pilastri che incantavano la gente
che veniva da fuori. D'altra parte, l'intonaco è sempre esistito
nel discorso pittorico: basti pensare agli affreschi. Ma come supporto
alla tela era estremamente precario. Fu Guttuso il primo a prendere
in considerazione il Vinavil, che considerava - forse per paradosso
-la scoperta del secolo. L'impasto è di Vinavil, di tufo e
di calce. Ma è necessario avere le idee chiare sul progetto
e la mano decisa nel realizzarlo, dal momento che la prima fase è
condizionata dalla scultura, e solo in un secondo momento interviene
l'elemento pittorico vero e proprio. In fondo, coinvolgendo il tufo
nelle mie tele, ho assemblato le mie due ricerche in arte: pittura
e scultura, con l'intervento di elementi architettonici. Una nuova
prospezione, fra l'altro, l'ho avviata con "Le cave di Sant'Isidro",
ancora attive, presso Maglie. Queste, e le altre che sono presso il
cimitero di Lecce, sono in funzione dal Settecento. La grana di questa
nostra pietra è così preziosa da poter essere considerata
la pelle della struttura, come l'oro negli affreschi e nelle icone
delle basiliche ortodosse. Io sono affascinato dalle linee del romanico
salentino. Ho voluto rendere omaggio a Santa Caterina d'Alessandria,
di Galatina, con una "Madonna" incastonata in una stele.
E un po' "gotica" è anche la "figura",
quando è entrata nelle mie tele. "L'urlo" è
solo due braccia che si liberano verso il cielo, come in fuga dalla
prigione della materia.
Quello della libertà, o della liberazione, è un tema
ricorrente...
Fin da ragazzo sentivo il bisogno dello spazio, della velocità,
del vento in faccia. Per questo giocavo al calcio, dicevano persino
che ero bravo; ma io giocavo con i calzoni lunghi e con le pesanti
scarpe contadine, e detestavo la celebrità. Amavo la libertà
e la pittura. Mia madre? Non mi ha mai osteggiato, com'è invece
accaduto ad altri spiriti sognatori, da Toma a Casciaro, a Martinez.
Ero già adulto, quando rimasi solo con lei: per me, lei è
tutto. Le "cose", in una casa, hanno un ruolo importante,
figuriamoci le persone; e figuriamoci mia madre, una quasimodiana
dulcissima mater. Non so e non minteressa sapere se sentimenti come
questi siano fuori moda. Per quel che mi riguarda, non dovremmo mai
perdere di vista certi valori. I quali, prima di tutto, ci migliorano;
come ci migliora l'esser credenti, il sentirsi rafforzati persino
da tutto ciò che di brutto accade in giro, il dover affrontare
una vita difficile, l'esser disponibili nei confronti degli altri.
Ecco: io dipingo per gli altri, per la gioia dello spirito degli altri.
Per parlare con gli alti! ho dovuto imparare l'italiano: sono stato
costretto a dialogare con me stesso, per tanto tempo, ma non in grico,
bensì in italiano, correggendomi, confrontandomi con il linguaggio
degli altri, e ho vinto anche questa scommessa. L'altra scommessa,
quella di crescere uomo e di crescere in modo onesto e pulito, senza
compromessi, è un esercizio che durerà tutta la vita.
Però, quanto ho parlato... Indimenticabile. Ci vedremo, a Sternatia,
al "Mocambo", con gli amici e con le frise al pomodoro di
Vito e con la fisarmonica di Uccio?
Il colore della
rivolta
Ezio Sanapo

Narra per discorso
diretto e per nude enunciazioni, anche quando i suoi soggetti figurali
realizzano analogie sociali o assonanze psicologiche. Tutte le sue
tensioni emotive passano come attraverso un rovello etico: e non è,
questo, un dato caratteriale; ma piuttosto una straordinaria vitalità
che si sublima nell'ossessione interiore di ri-umanizzare i valori
autentici del suo mondo e di sintonizzarli su un'alta qualità
d'invenzione. Operazione non facile, perché artisticamente
eversiva: antitetica agli elementi acquisiti del linguaggio "classico",
cioè tradizionale, e quindi al di qua degli steccati delle
contaminazioni oleografiche, e tutta dentro l'essenza moderna dell'arte.
Non è stata un'operazione indolore. Sanapo si è dovuto
affrancare dall'esperienza dell'artigianato e da quella -simultanea
- dell'emigrazione: vale a dire da due condizioni riduttive, e tutte
volte alle urgenze della produzione e della sopravvivenza. E in seguito
si è dovuto lasciare alle spalle una narrativa pittorica che
pure fu di grande spessore e di sorprendente rivelazione: quella della
"cultura contadina", ormai datata anche per il Sud di Levi
e di Scotellaro, quello dei volti di terracotta, delle mani nodose,
dei rumori di zappe come sirene di ciminiere. Evocato, quel Sud grondava
retorica: tramontato nella memoria collettiva, "non permeava
più l'anima della nostra gente". Il nuovo filo conduttore
si dipana allora in una ricerca delle diverse qualità e dei
valori contemporanei dell'immagine, raggiunta attraverso una meditazione
che si realizza in modo intrinseco all'operazione stessa della sua
atte. Dalle sue tele si rivela il senso Profondo del suo continuo
risalire alla verità storica, che propone di volta in volta
riflessivamente (la tarantata) o provocatoriamente (ragazzi al ricamo);
ma in un orizzonte di desolazione, o forse solo di spleen, e certamente
nel corto circuito della difesa estrema della sua interiore libertà,
di individuo e di artista. C'è sempre, al fondo della sua pittura,
una dilatazione quasi religiosa del deserto della miseria (fisica,
culturale) che lo assedia e insidia con i suoi fraudolenti bagliori
e fantasmi. Di fronte ai quali accende toni e gradazioni di passione
dolorosamente rattenuta, che lasciano presagire la deflagrazione dialettica:
e per questo rivisita - e sarebbe forse meglio dire indaga - in chiave
di recupero ideologico e di chiarezza valori, simboli, luoghi, uomini
della sua terra. E' in questa fase che Sanapo porta al massimo rigore
i mezzi espressivi, piegando il mestiere alla necessità di
un colloquio critico speculare all'innovazione artistica. E' un cammino
solitario, ma tra i più suggestivi: il nascimento" delle
forme è alla base per lo scavo della tela, del confronto di
masse e colori, della perfezione degli stilemi. Col risultato di una
seducente armonia tra intenzioni ed esiti, fra inesauribilità
della ricerca e rispondenza dell'atto creativo. Di qui, la forza e
la purezza (nelle figure, nei paesaggi) dei suoi modi stilistici,
che sottendono quasi un'ansia panica di farsi messaggio, di comunicare:
senza cadere mai nei ricatti romantici o nelle lusinghe barocche;
-aiutato, in questo, da una biografia intatta e da scelte necessariamente
decisive che hanno comunque eluso ogni astuzia della ragione. E se
èvero che questo artista si è mosso nella pienezza dell'esperienza
umana e professionale, rifuggendo da immotivati trasformismi e adescamenti
commerciali, per giungere libero alle radici del fare pittura e alle
radici deI problema-uomo; se èvero che le sue stesse ricerche
sono state coerenti e conseguenti sul piano pittorico, allora le sue
tele possiedono un autentico sigillo d'arte.
Da piccolo non facevo altro che disegnare: per terra, con i gessi
sui muti, col lapis; persino sui cartoni che stavano dentro le lenzuola
e le coperte della dote delle ragazze. Evidentemente avevo una buona
mano, c'era in quelle cose che tracciavo qualche incognita che richiamava
l'attenzione, cioè che esulava da quel che facevano gli altri
ragazzi della mia età. I primi album da disegno io li ho visti
quando a scuola non ci andavo più. Fui costretto a smettere
alla quinta elementare, che a quei tempi era l'ultimo anno della scuola
dell'obbligo. Allora il sindaco, il mio insegnante, persino il parroco
fecero pressioni su mio fratello. Il quale voleva fare di me un muratore,
visto che aveva un'impresa edile...
Risultato?
L'ho fatto per un anno e mezzo o due, anche per dimostrare che il
lavoro non mi pesava. Poi, per quindici o vent'anni, ho fatto l'imbianchino.
E quando è nato il pittore?
Il pittore non più d'occasione è emerso dopo l'esperienza
della Svizzera. Oltre tutto, un'appassionata militanza politica mi
aveva portato a contatto con le problematiche sociali, soprattutto
locali, e in particolare col mondo contadino, del quale scoprii valori
e cultura. Mi gettai a capofitto in questo mondo, che prima di partire
per i Cantoni Elvetici avevo ignorato, tutto preso com'ero dal consumo
di massa delle canzonette, del calcio, della televisione. A diciassette
anni, l'emigrazione. I friulani mi chiamavano "bocia": ero
giovanissimo ed ero solo, ma abbastanza sveglio da riflettere sui
problemi degli eradicati come me, in presa diretta. Vi rimasi, con
varie pause, dapprima due anni, poi altri quattro, metà dei
quali da sposato. Mi comportai da perfetto emigrato: casa e lavoro,
risparmio, nessun impegno culturale, solo il contatto con gli italiani,
e in seguito il gusto del rapporto con gli elvetici, ai quali dichiaravo
con orgoglio la mia appartenenza al Sud d'Italia.
E una volta tornato definitivamente?
Una volta tornato definitivamente, dopo anni di isolamento trascorsi
senza esprimere nulla, esplose il pittore. E incominciai proprio con
le facce genuine dei contadini, con i loro usi e costumi, col loro
lavoro quotidiano, con i loro riti, con il loro culto dei morti, con
le loro processioni, col tarantismo. Ma anche con l'esplorazione del
mondo artigiano, soprattutto della gente che cuciva tomaie, che esercitava
a domicilio il cosiddetto sommerso, che poi era un vero, e proprio
lavoro nero: 24 tomaie, per 12 paia di scarpe, retribuite in tutto
con seimila lire. In questo modo, come attività complementare,
e come obbligo morale, direi, divenni anche sindacalista: ma sul versante
sociale e umano, non su quello assistenziale. Ho combattuto tante
battaglie, un po' anche alla carbonara, con incontri nelle case della
gente che finivano per tradursi nell'ascolto delle loro vicende, di
spicchi di vita, di ansie, di speranze. Tutto ciò mi offriva
l'opportunità di conoscere i risvolti più segreti, più
genuini, e a volte più drammatici, delle persone con le quali
avevo stabilito un contatto più assiduo. E tramutavo questo
bagaglio di conoscenza in consapevolezza culturale.
Ma allora la cultura contadina non era in crisi, se non proprio in
via di estinzione?
Sì, ma io volli far leva su quei valori, che potevano essere
riscoperti, riconosciuti, ripresi. Fu allora che misi definitivamente
da parte l'impegno politico e mi dedicai a quello artistico.
Avvertivo che col quadro potevo essere più convincente; che
potevo stabilire una sintonia più diretta, più immediata,
ma anche più profonda con i miei interlocutori.
Fino a quando la cultura contadina è stata il tema emblematico
ed esclusivo dei tuoi quadri?
Fino al giorno in cui intuivo che non permeava più l'anima
della, nostra gente, e che stava esaurendo la spinta che pure era
stata fortemente propulsiva. Tutt'al più, poteva essere presa
come metro di confronto con l'esperienza e con l'antropologia culturale
attuali. Io, del resto, non ho mai amato la retorica, dunque non potevo
ossificarmi e rifare quel che avevo già fatto. Così,
il giorno in cui venne uno da Parma, e mi chiese di dipingere una
tarantata, sulla tela emerse una figura immobile, riflessiva: non
esisteva più la base culturale di una volta, quella che le
permetteva, o le imponeva, di ballare. Era un mondo tramontato. Proprio
allora smisi di interessarmi pittoricamente ai riti, se non per rapportarli
al nostro tempo e alla nostra realtà contingente: proiettandoli
nell'evoluzione culturale e sociale della nostra terra, e non lasciandoli
più fermi, pietrificati, metastoricizzati.
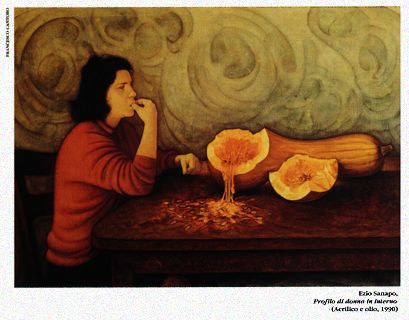
Questa censura, nei primi anni Ottanta...
Proprio allora cominciai ad avvertire una certa ambiguità nei
pensieri e nei comportamenti della gente, che stava perdendo ogni
coscienza, ogni memoria storica, e non sapeva più che cosa
fare.. aveva perduto l'anima d'una volta, ed era diventata corriva,
prevenuta anche nel rapporto con gli altri. Ho sempre pensato che
siamo stati tutti correi, tutti complici, tutti colpevoli di questa
caduta. Tutti insieme abbiamo abbandonato le nostre buone e pulite
capacità creative e ci siamo rifugiati sotto l'ombrello assistenziale;
tutti abbiamo venduto un brandello della nostra identità individuale
e culturale. Io parlavo con gli altri, e sentivo che gli altri non
erano più liberi: erano, e si sentivano, condizionati.
E nella pittura come si è espresso questo stato d'animo?
Con molta sofferenza. Con un gesto di rivolta, o di rivalsa: due ragazzi
che ricamavano. Per richiamare l'attenzione in modo provocatorio,
brutale, se si vuole anche violento. Ma di una violenza stemperata
dal colore. Credevo che fosse giusto così, che occorreva tenere
aperto il dialogo, che non si poteva e non si può vivere di
monologhi C'era uno scotto da pagare, e lo pagai in prima persona:
presi una certa distanza sia dalle persone sia dall'ottimismo possibilista
del passato. Avvertivo d'avere a che fare con un mondo ostinato, chiuso
in un guscio durissimo. Allora era necessario mandare un segnale preciso,
deciso. E credo d'aver fatto bene. Non erano più gli anni '70,
quando con la gente era possibile parlare, scambiare idee, stimolare.
curiosità culturali, incrociare opinioni. Eravamo ormai in
tempi di riflusso. Con i miei quadri in galleria, la gente si fermava
a qualche metro, o si bloccava al centro della strada. Qualcosa la
indisponeva. Era probabilmente l'effetto di quel segnale. Io non ho
mai provato a riconquistarla. Ho scelto una parentesi difficile, un
mio tempo di riflessione. D'altra parte, sono stato sempre fermamente
lontano dalla mercificazione delle mie opere.
E adesso?
Da qualche tempo c'è qualcosa che mi incoraggia a fare quel
che facevo prima. Ho letto i dati del Censis: straordinariamente confermano
l'analisi dell'individuo e della società che io rappresentavo
nelle mie tele. Vien fuori un uomo assorto, in bilico quasi. L'uomo
dell'attendismo. Stavo dipingendo una grande tela, con un gruppo di
famiglia in esterno; e, fuori, appunto, tutti gli indumenti, anche
intimi, di ciascun componente, legati ad un filo: fuor di metafora,
una famiglia felice fra le pareti domestiche, ma fuori, in esterno
cioè, legata da un solo ultimo filo. Infelice. Nuda.
Che cos'è, dopo le esperienze fatte, per te, la pittura?
Un fatto spontaneo e necessario, come per chi sente il bisogno di
parlare, di confidarsi con qualcuno. Ma l'atto di dipingere, in particolare,
è paragonabile a un libero e solitario volo nell'immaginario,
alla ricerca di qualche verità latente. I segni sulla tela
sono la visione delle cose di chi dipinge. L'importanza o meno dei
segni fa sì che tutto deve necessariamente essere ridiscusso
con quanti, interlocutori o destinatari dei messaggi, sentono il bisogno
di un raffronto. La pittura è quindi un fatto isolato, a completezza
del quale è necessario e urgente un minimo di rapporto umano.
E il quadro?
Per me, è la sollecitazione ad una riflessione sulla nostra
presenza rispetto ad una realtà artificiosa e materializzata
da luoghi comuni e da abitudini e regole imposte. Il colore, poi,
è una sensazione mutevole, sospesa e in attesa di essere afferrata
e indirizzata verso uno spazio o una dimensione, dove trova una sua
giustificazione e provoca un'emozione.
Quale percorso ha seguito il tuo colore?
All'inizio, credo più caldo, e più scuro, in riferimento
alle cose che rappresentava; poi, con lo stacco degli anni '80, più
aderente alla realtà effettuale.. vista a occhio nudo.
Qual è l'impatto con la tela vergine?
La tela, per quel che mi riguarda, è una cosa originariamente
piatta; in quanto tale, a guardarla, mi provoca angoscia e sofferenza.
Il primo impulso che mi viene è quello di scavarla, di spalancarla,
per vedere che cosa c'è dentro, se c'è. Il soggetto
di un quadro appena completato mi dà per un attimo benessere,
e l'illusione di una conquista fatta. Poi tutto diventa conquista
degli altri, patrimonio comune. A me rimane la vaga insoddisfazione
di sempre, lo stato che avrebbe un comune e banale interruttore, lì,
in attesa di essere acceso da qualcuno o da qualcosa.
E l'artista?
Presumo che l'artista sia una persona come tutte le altre; o almeno,
dovrebbe assalti, se non fosse per il fatto di essere più esposto
agli altri. Rispetto alla realtà che lo circonda, è
collocato su un piano superiore, ma per motivi di ordine pratico,
così come sta su una casa un'antenna, che ha la funzione di
captare impulsi e di trasmetterli per un normale e necessario uso
e consumo.
Il colore del
ritorno
Armando Marrocco
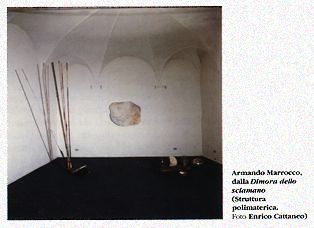
La prima magia
fu quella della fuga: dopo un lungo esercizio artigiano, nelle botteghe
più celebri, dove si lavorava su tutto: legno, pietra serena,
marmo. Da Vico Freddo alla metropoli lombarda il passo era lungo,
l'avventura quasi senza confini. Non c'erano le autostrade, il viaggio
in treno durava millenni, il clima mutava da stazione a stazione,
bisognava avere ali d'acciaio per passare dai pastellati mediterranei
ai grigi metallizzati d'Oltrepò.
Per dare un nome alla sfida, la seconda magia: resistere a tutto,
e intanto appagare la voracità cognitiva, colmare i vuoti lasciati
da una provincia eccentrica, vivere in presa diretta quel che l'arie
testimoniava giorno dopo giorno. Ci sono percorsi inenarrabili nella
vicenda di ogni artista; ci sono percorsi che Marrocco non narra ancora,
perché molte ferite sono ancora aperte. Raramente apre uno
spiraglio biografico: ed è come se sia passato dallo scalpello
sul marmo alle mani che impastano quel marmo e altre - tutte le altre
-
materia prima quasi per incanto, o per un incantamento che deve pur
averlo posseduto dal primo giorno: tanto è naturale in lui
la fusione interiore che poi proietta nella pittura e nella scultura,
e se potesse lo farebbe anche nella musica, se questa avesse corporeità,
fosse tangibile e visibile. E' anche per questo artista a tutto compasso.
Per questo, e per le esperienze che ha trascorso non epidermicamente,
ma in immersione totale. Tant'è che ha fatto dell'eclettismo
un suo personale e costante scavo, dentro una coerenza artistica riconoscibile
all'impatto: ed è, questa, la terza magia, perdurante nel suo
rievocare mondi perduti forse nella memoria, ma non nell'anima: riecheggiano
così simboli mesopotamici, con tutto ciò che sottendono
di remoto, preistorico e protostorico, da favoloso Catai; ed egizi,
con tutto ciò che riverberano fino alla nostra contemporanea
solarità piena o crepuscolare (d'alba, di tramonto); e infine
d'un paese senza tempo e senza coordinate, d'una latitudine atlantidea
alla quale Marrocco - come in un gioco di specchi - allude, ma che
lascia intatta in un inattingibile mistero.
Eppure, niente è più concreto di una scultura. Niente
più visibile. Ma è qui il grimaldello dell'arte di Marrocco:
nel sospendere spazio e tempo su piani indefiniti, fuori d'ogni metro
contingente, e nel lasciarli fluttuare liberamente, come gli aquiloni
che libera sulle serre salentine, che vanno oltre le nuvole; e nell'immergerci
in questa sua straordinaria dimensione spazio-temporale che non lascia
varchi all'evasione. Si è tutti imprigionati e quasi dissolti
fra gli arredi sciamani o fra le antenne e le vele fenicie o fra le
folgoranti comete dalle lunghe scie: si diventa microcosmi complementari
del macrocosmo totalizzante di Marrocco. Che non conosce confini neanche
nelle tele, le cui false cornici sono esse stesse pittura-scultura,
ed esorbitano, sfuggono per dinamica interna alla costrizione dell'angolo
retto, e suggeriscono geometrie primitive e giochi esoterici: dominando
la parete e vivendo di luce propria, come i riflessi sole-luna negli
artifici singolari della sua (e nostra) rappresentazione galattica.
E tutto questo, piegando materia ricca e materia povera ai disegni
della fantasia e alle esigenze degli stilemi. Bronzo, tela, legno,
carta, e quanto altro possa ricreare il paesaggio onirico, trovano
nelle mani di Marrocco lo strumento demiurgico ideale. Forse proprio
perché c'è con l'artista un rapporto analogico pieno,
e c'è una rispondenza di espressione senza riserve. Sta di
fatto che Marrocco e le sue tele e le sue sculture sembrano enuclearsi
insieme, e simultaneamente, dal paesaggio effettuale, per farsi, simultaneamente,
noumeno sumerico: origine dell'idea del mondo e della storia: estrema
magia, questa, attinta forse ai cieli dei suoi ritorni, dell'artista
intendo dire, tra le rughe della terra e gli orli del mare, che lo
rivedono, monello ancora, e brizzolato, ora nelle stagioni delle sue
nostalgie.
Ho frequentato le scuole a Galatina, poi l'Artistico a Lecce: qui,
per tre anni, rimasi come insegnante di scultura. Sono scultore, pittore,
scenografo, mi interesso di arredo con gli architetti.
Com'è nata, a Galatina, questa passione?
Ero sui sette-otto anni, e mio padre, per non vedermi in giro per
i vicoli, mi mandò presso uno scalpellino, uno dei più
importanti del paese. Di lì, la passione per la scultura, per
la decorazione, per la pittura...
E arriviamo a ventidue anni e mezzo. E in seguito?
Presi il treno e andai a Milano, lasciando l'insegnamento senza nemmeno
chieder permesso ai miei. Galatina, il Salento e la Puglia non mi
davano quel che volevo, e io volevo fare le mie esperienze di un certo
tipo, dentro il vivo della cultura italiana, e non solo di quella
regionale. E questo mi ha poi spinto verso nuove ricerche e nuove
situazioni intellettuali che altrove soltanto avrei potuto trovare.
Anche se da noi c'era l'informazione, tuttavia era indiretta, e mai
simultanea. Uno come me le esperienze artistiche le deve vivere sulla
propria pelle: anche se è dura. Deve viverle in presa diretta,
e non attraverso i libri, oppure a singhiozzo.
Allora non hai avuto maestri in Salento?
A parte quel che mi ha potuto dare quello scalpellino, o come si chiamava,
"maestro scorniciatore", per farmi le basi, il parterre,
per il lavoro sul marmo, sulla pietra leccese, sul legno, devo dire
che in un certo senso la scuola mi ha completato. Ma si trattava pur
sempre di una preparazione artigianale e locale. Allora pensai che
andando al Nord le mie esperienze si sarebbero arricchite, e così
credo che sia stato. Anche se poi, a distanza di tempo, quell'arte-artigianato
iniziale torna ad affiorare come un fenomeno importante, come bagaglio
di cultura e di tradizione popolare, come antropologia. Come "fare
fisico" Perché la memoria in me è diventata quasi
un mito che mi porto dietro e che poi trapianto, sempre con orgoglio,
ovunque mi trovi.
E hai avuto successo?
Non si giunge mai alla meta. Però ho creato un mio piccolo
universo che la gente incomincia ad apprezzare per la sua genuinità,
per le sue strutture-pensiero ricche di antica spontaneità.
Pian piano mi si sta dando ragione, anche per quel tipo di cultura
che ci collega non solo alla Madre Grecia, ma soprattutto a quel padre
oriente, dall'Africa del Nord all'Egitto e alla culla del mondo, quell'ombelico
mesopotamico che sta fra il Tigri e l'Eufrate, che sono sempre entrati
nelle vene e nei meandri carsici dei pugliesi.

La piramide come scultura perfetta?
Che ci portiamo nel sangue.
Salento terra di artisti. Ma destinati ad emigrare. Per mancanza di
mercato, per l'inesistenza di un rapporto di committenza?
Sì. Per chi vuol vivere d'arte, solo ed esclusivamente d'arte,
non ci sono orizzonti. Forse perché in questa terra l'arte
è ovunque, persino nell'aria che si respira, dunque tutto ciò
che riguarda la produzione estetica si trova già nella natura
e chi vive qui è consapevole di tutto questo. Se poi questo
tipo di natura (paesaggio, uomo, clima) si riesce a trasferirlo su
una tela o in una scultura, diventa una componente del paesaggio stesso,
e non viene recepito come un fatto rilevante, come espressione dell'anima
dell'artista, come sua proiezione nella società in cui vive
in quel momento. Dunque, tutto sembra concesso o da concedere. Questo
è l'aspetto negativo del rapporto fra artista e mondo salentino.
Ed è un gran problema.
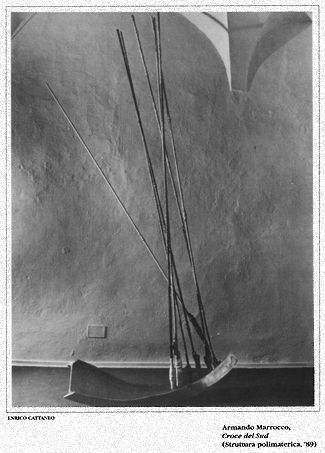
Allora è necessario trovare un mercato vivo...
Appunto. Un mercato nel quale si è capito da tempo immemorabile
che l'arte serve allo spirito, esprime il tempo vissuto, è
emozione simultanea alla creazione, ed è anche rapporto alienante
per chi rubacchia cultura qua e là.
Dei movimenti di questo ultimo quarto di secolo, quale hai vissuto
dall'interno, o quale in ogni caso ti ha sfiorato?
Tanti. Anche quando li recepivo di riflesso qui in Salento: l'arte
astratta, l'astratto concreto, l'arte informale (quando avevo vent'anni)...
in pittura e in scultura; poi, col tempo, mi sono orientato sempre
più verso un'arte totale, che abbracciava anche l'architettura
In seguito, la mia cultura esattamente "rupestre" e di tradizione
popolare ha avuto l'impatto con quella tecnologica. E con essa ho
dovuto fare i conti. All'inizio si è coinvolti per la vita
e per la morte, bisogna sopravvivere, affrontare le più disparate
situazioni. E infatti: quando giunsi a Milano, iniziava l'arte optical;
poi vennero quella cinetica, programmata, eccetera, fino alla fine
degli anni 160; e poi ancora tutte le altre correnti, che era necessario
percorrere ad una ad una, per farsi infine portavoce di ritorno ad
altri tipi di tradizioni, ancora più antiche di quelle vissute,
con l'aggancio a certe situazioni (e a certi miti) di matrice: Egitto,
Oriente, India e via dicendo, in senso inverso rispetto al corso del
sole. Tutte le correnti mi hanno sfiorato, e in alcuni casi mi hanno
anche graffiato. Mi son passate sulla pelle e ho pagato di persona.
Perché quando si entra in una situazione culturale non è
facile venirne fuori, perché in parte ti si connatura, ti imprigiona.
TU detesti l'etichetta...
Decisamente. Io sono un artista, un operatore eclettico. Ho sposato
l'eclettismo come fatto emblematico della mia vita. Le strade mi piace
percorrerle tutte e bene. Perché la verità non ce l'ha
nessuno in tasca.
Dopo la transavanguardia, l'eclettismo ha ancora cittadinanza nel
mondo?
Io credo che l'eclettismo vivrà sempre, perché anche
gli artisti della transavanguardia sono eclettici. Anzi, io ho anticipato
di gran tempo la loro situazione, anche se non sono inserito nel loro
filone. Un filone che coinvolge l'architettura, la scultura, la pittura,
la stessa musica. Essi stessi dicono di essere agganciati al post-moderno
e sono fuori dal post-moderno, al movimento moderno e ne sono fuori,
alla nuova figurazione e ne sono usciti. Ecco: tutto questo io l'ho
vissuto con un decennio di anticipo.
Se dovessi citare le tue cose più importanti, quali ricorderesti?
Tutte sono per me riferimenti importanti. Anche perché io non
butto via mai niente delle mie esperienze; anche perché ho
sempre fatto le cose con coscienza e con amore. Ma qualcosa prediligo,
come le ultime che sto realizzando, le strutture che riassumono tutte
le mie esperienze precedenti.
E riguardano?
Pittura, scultura, architettura, in una situazione di arte totale,
di spettro a 360 gradi, di respiro assoluto, che coinvolge non una,
ma - in una - tutte le espressioni artistiche, musica inclusa. Il
sogno è stato fare questo tipo di lavoro: un sogno che mi porto
sempre dentro e che mi fa andare sempre avanti. Forse, per completare
questa mia visione dell'arte totale, mi manca il cinema. Nel cinema,
col cinema, mi sono consumato, fin da ragazzo. Se non avessi fatto
lo scultore, avrei certamente puntato al mondo del cinema.
La più bella esperienza internazionale?
Seul, in Corea, con "La città-palafitta", che si
richiama un po' alle nostre cabile palafitticole sul mare, quelle
della nostra infanzia. Una "città di memoria e di sogno",
dunque. Quello di Seul èun lavoro in bronzo, quasi a livello
abitativo, ora sistemato nel Parco delle Olimpiadi. L'ho realizzato
con la collaborazione di un altro salentino, l'architetto Rosario
Scrimieri, coinvolto in particolare dall'aspetto dell'occupazione
spaziale. Bellissima esperienza.
Per il futuro, staremo a vedere. I sogni sono tutt'altro che tramontati.

Sempre rinnovandoti...
Certamente. Io lavoro in piena autonomia da quindici anni. Prima era
tremendo, perché come tutti gli emigranti ho fatto anche la
fame, in anni di fuoco. Quando, nel 163, giunsi a Milano, ce l'avevano
ancora con i meridionali, io non trovavo neanche un posto per dormire.
Poi, poco alla volta, mi sono creato uno spazio e un nome: hanno incominciato
ad apprezzare il mio lavoro ed a capire il mio linguaggio espressivo.
E ora non sono di quelli - e ne ho visti tanti - che sono stati costretti
a tornare indietro. E non intendo dire soltanto tornare al paese d'origine;
ma anche recedere dalle proprie illusioni, abbandonare il mondo dell'arte
che per il breve spazio d'un mattino li aveva resi celebri, e che
poi li ha fagogitati perché erano rimasti al punto di partenza,
o al "loro" punto darrivo, che non teneva conto dell'insegnamento
di Eraclito, secondo cui "tutto scorre", tutto muta, evolve.
E non si trattava solo di emigrati, ma di stanziali veri e propri,
a Milano, a Torino, a Roma. Questa è la scommessa terribile
dell'arte: anche quello che si ritiene un punto d'arrivo può
essere una trappola, il successo e l'inizio del crollo possono essere
simultanei se non ci si supera continuamente. Senza pretendere di
fare ad ogni costo "cose belle". Ci sono "cose brutte"
che sono molto interessanti. Io faccio cose che possono essere "bruttissime",
eppure hanno un riscontro culturale con quelli che mi seguono, mi
mettono in sintonia spirituale con tanta gente.
Sei fuori da tre decenni, ma ora torni di frequente nella terra d'origine.
In che cosa trovi cambiati questa terra e chi la abita?
In quasi nulla. O in pochissime cose. Il discorso sull'arte e per
l'arte e per la vera cultura non esiste. Tutto è fermo alle
feste patronali e alle fiere del paese, al folclore, allo spettacolo,
al linguaggio mediale mutuato dalla televisione. La cultura seria,
creativa, di confronto con le esperienze nazionali e internazionali
non esiste. Si dovrebbe riflettere su questa condizione di periferia
culturale, si dovrebbe ripensare un "modo di essere" senza
il quale non ha alcun valore morale alcun -modo di avere". Di
positivo c'è questo, per chi, come me, si sente un albero,
e torna alle sue radici: che chi torna, e riapre una breve parentesi
qui, si sente ricaricato, ritemprato, pronto poi ad affrontare nuove
situazioni. Ma forse questo è un fatto individuale, perché
non è il clima, non è il contesto che aiuta: chi mi
organizzerebbe, qui, un concetto con l'innesto di una mostra d'atte?
Chi ha il gusto della novità e del rischio? Dov'è la
professionalità? E dove la spinta a far conoscere alla gente
chi si è imposto altrove, o a far conoscere chi può
imporsi dal proprio "borgonatio"? C'è ancora chi
pensa che l'arte sia un hobby!Che poi la pittura e la scultura, da
noi, sono da sempre a vista d'occhio, sulle facciate delle case, nelle
mensole delle finestre, nei ferri battuti, nei colori dei muri. E
tutto questo non è nato dal niente, ha tradizioni remote. Se
si tenesse conto di tutto ciò, Salento, Puglia e, Sud avrebbero
centri storici e paesistici valorizzati al massimo, unici e molto
singolari; si creerebbe uno scenario in cui l'arte e l'artista sarebbero
accettati per il loro grado di intelligenza creativa, di missione
pedagogica, e non come personaggi eccentrici, col pallino del pennello
e dello scalpello... E così accade che i giovani che vengon
fuori dalle nostre scuole e accademie d'arte si buttano a capofitto
nella loro attività, ma poi si spezzano le ali all'impatto
con la nuda e cruda realtà locale; e devono cambiar mestiere,
o allungare l'elenco infinito dei disoccupati.
E se emigrassero?
Peggio ancora, perché andrebbero all'altro impatto, quello
con l'arte tecnologica (c'è già chi ritiene di poter
dipingere col computer; l'architettura da tempo opera col computer;
col computer si progettano splendidi e funzionalissimi aeroporti).
Ma nei nostri giovani non esiste una formazione tecnologica, nessuno
li ha introdotti in una cultura industriale o terziaria avanzata.
Sarebbe un'ecatombe. Io stesso sono un romantico, penso che l'anima
risieda nell'uomo e non in una macchina. Il futuro dei giovani, anche
dei giovani che coniugheranno arte e software, sarà molto triste
se si uccideranno i sogni, se si abbandonerà la manualità,
il contatto fisico con l'opera d'arte, se si farà ricorso solo
alla mediazione intellettuale e algida tra mente e macchina.
La critica interpreta sempre l'animus dell'artista?
Difficilmente il critico riesce a descrivere un'emozione determinante
nel momento della creatività. E' in grado di raccontare le
situazioni, di scoprire gli agganci dell'artista alle diverse culture
trascorse o contemporanee, ma mai può parlare sinceramente
di quel che si verifica nell'artista (nella sua anima, nel suo cervello,
nelle sue stesse mani) al momento della creazione. Il critico può
tracciare un cerchio e stabilire gli "ismi" ai quali verosimilmente
appartiene un artista, ma non può cogliere quel che di potenziale
c'è nell'artista, che nel momento stesso in cui elabora e rielabora
la sua opera si proietta nel futuro. Voglio dire che l'idea dell'opera
d'arte e l'opera d'arie stessa sono simultanee, si condizionano reciprocamente,
evolvono insieme mentre da fenomeni in potenza vanno realizzandosi
in fenomeni in atto. Il pensiero stesso, in realtà, è
opera d'arie; la sua manifestazione è un fatto meccanico. Dunque,
mentre si tocca la materia, si manipola l'argilla, si saggia la pietra,
si determina il momento decisivo: e nessun critico è in grado
di cogliere questa folgorazione, questa scintilla che è la
radice autentica e vitale dell'opera d'arte. E' proprio questo che
sfugge al critico, e più ancora allo storico dell'arte, la
cui maggior preoccupazione è identificare un artista, attribuirgli
un'etichetta. Forse è proprio impossibile che qualcuno possa
leggere l'anima di un artista, e meno che mai possa impossessarsene.
Quell'anima è in ogni opera d'arte. E proprio essa determina
la differenza tra artista e artista. E ancora di più: in uno
stesso artista, l'anima si esprime in modi diversi, da un attimo all'altro.
Ma la critica media fra artista e fruitore...
Sì, anche se spesso trova in un'opera d'arie cose che non ci
sono, che l'artista proprio non voleva esprimere e non ha espresso,
neanche preterintenzionalmente. Parlo della critica seria, non di
quella che imbroglia e che bara.