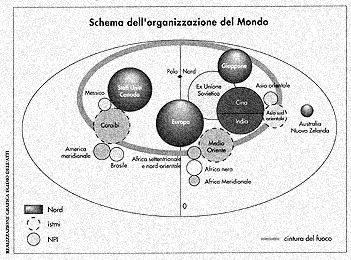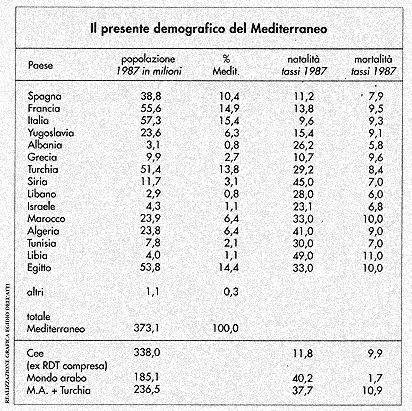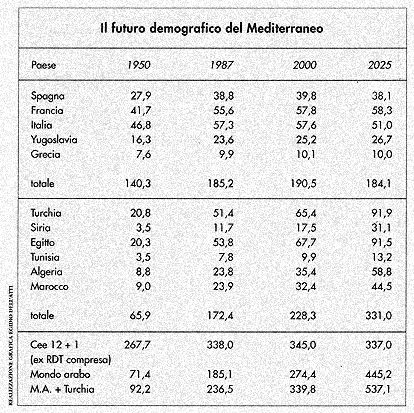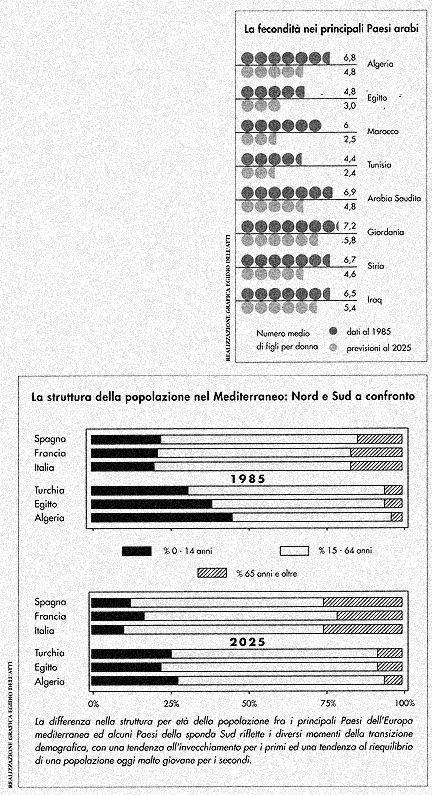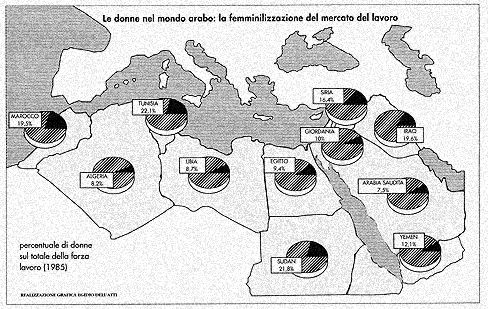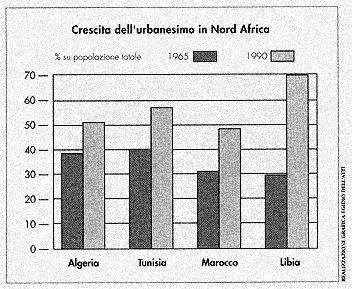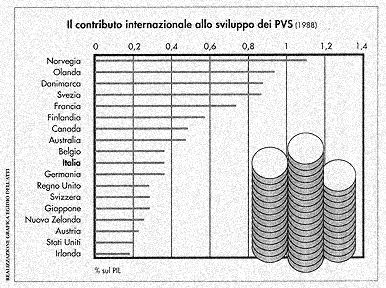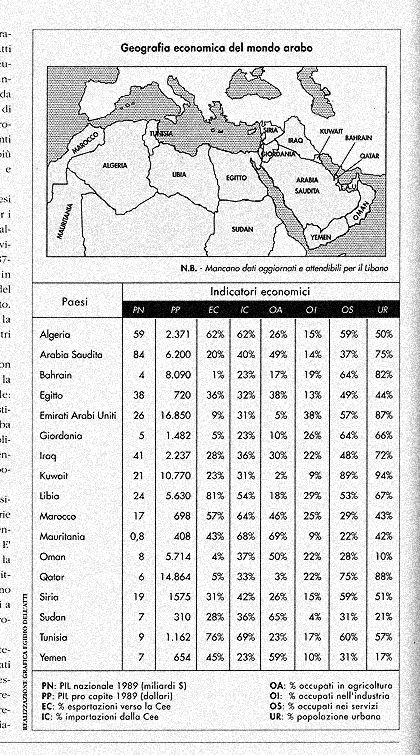Sul Mediterraneo
si affaccia oggi una gamma davvero vasta di realtà sociali
ed economiche profondamente diverse e in rapida trasformazione. Questa
varietà di situazioni viene generalmente divisa in due grandi
aggregati: la sponda Nord, che presenta redditi mediamente elevati
e una popolazione demograficamente matura, e la sponda Sud - nella
quale rientra anche la Turchia, "settentrionale" solamente
sotto l'aspetto geografico -, che si distingue invece per minor opulenza
e per una età media molto bassa. Mentre nei Paesi europei l'anzianizzazione
della popolazione lancia una sfida ai sistemi di welfare, pensati
e calibrati per una popolazione più giovane di quella attuale
e futura, nei Paesi della sponda Sud l'inflazione demografica rischia
di diventare un freno alle speranze di sviluppo.
Invero, il mondo mediterraneo presenta un profilo così variegato
e multiforme da non consentire una descrizione meramente dicotomica:
alla sponda Nord appartengono quattro Stati della Cee, ma anche alcune
parti di quel continente alla deriva che è l'Europa centrorientale
(Jugoslavia e Albania). Rientra invece nella sponda Sud lo Stato di
Israele, che è a tutti gli effetti un Paese a sviluppo avanzato.
Anche tra i Paesi arabi del Nord Africa non si registra una totale
omogeneità di comportamenti economici e demografici ma, come
vedremo meglio in seguito, è possibile localizzare modelli
sensibilmente diversi.
Nel corso delle pagine successive tenteremo di sondare alcuni aspetti
del futuro dell'area mediterranea allargata (comprendendo quindi,
oltre ai Paesi rivieraschi, gli altri Paesi appartenenti alle Cee
ed il mondo arabo nel suo complesso), partendo dall'analisi demografica.
Diciotto sono i Paesi che si affacciano sul mare Mediterraneo; se
escludiamo quelli di piccole e piccolissime dimensioni, possiamo limitare
la nostra attenzione a sei Stati europei (Spagna, Francia, Italia,
Jugoslavia, Albania e Grecia), che da soli rappresentano oltre il
50% della popolazione ed il 73% delle coste (al Nord più frastagliate),
a quattro Stati orientali (Turchia, Siria, Libano, Israele) e ai cinque
Stati nordafricani (Marocco, Algeria, Tunisia, Libia ed Egitto).
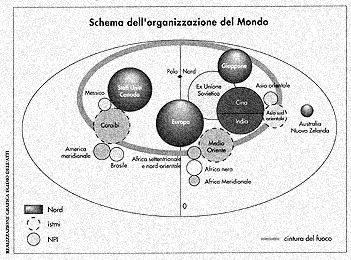
Mentre i valori
dei tassi di mortalità nei diversi Paesi non differiscono significativamente
(anche perché le diverse strutture per età delle popolazioni
tendono ad appianare il divario ancora esistente in termini di speranza
di vita), la distanza tra i tassi di natalità rimane elevatissima.
il rapporto tra tasso di natalità italiano e algerino è,
a titolo d'esempio, di 1 a 4.
Si possono facilmente intuire i problemi collegati ad una natalità
così elevata: in primo luogo fabbisogno alimentare, ma anche
pressione sul sistema scolastico e sanitario e, in prospettiva, pressione
sul mercato del lavoro.
Apparentemente eccezionale, il comportamento demografico dei Paesi
arabi rientra negli schemi della cosiddetta teoria della transizione
demografica.
A che punto si trova attualmente LA transizione demografica nei Paesi
arabi? Mentre la mortalità è ovunque in rapido declino
da almeno trenta anni, il calo del tasso di natalità stenta
invece a consolidarsi. Non mancano, è vero, segnali del fatto
che qualcosa si sta muovendo: ad esempio, il numero medio di figli
per donna in Algeria è sceso dal 1970 ad oggi da 8 a 6; esiste
inoltre Una correlazione negativa tra il livello di istruzione femminile,
attualmente crescente, e fecondità (a questo proposito si veda,
più avanti, il paragrafo sul lavoro femminile nei Paesi arabi).
Purtuttavia, anche ipotizzando un declino alquanto rapido (lei tassi
di fecondità, la popolazione araba si appresta a vivere nei
prossimi decenni la fase critica della propria transizione, quella
che comporta una vera e propria esplosione demografica: da 71 milioni
al 1950 si passerà a oltre mezzo miliardo entro i primi tre
decenni del prossimo secolo.
Bisogna osservare come all'interno del inondo arabo non sia possibile
individuare un'uniformità di comportamenti demografici: alcuni
Paesi (come Tunisia ed Egitto) hanno già sensibilmente ridotto
la propria natalità e potrebbero veder completato in pochi
decenni il processo transizionale; in altri Paesi (Algeria, Libia
e tutta la penisola arabica), gli indicatori sociali e demografici
lasciano prevedere una durata sensibilmente maggiore.
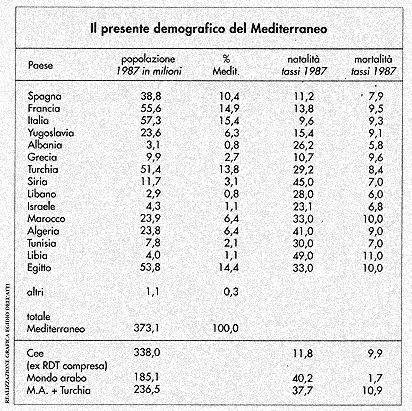
La separazione tra due aree demografiche (che possiamo definire a
"transizione breve" e "a transizione lunga") ha
molti tratti in comune con la profonda divisione geo-politica, dai
confini instabili, derivante dalle diverse risposte date dai sistemi
politici arabi alle pressioni della modernizzazione. Questa parziale
sovrapposizione dei confini del comportamento demografico a quelli
dei sistemi politico-religiosi mette in evidenza come l'analisi dei
fenomeni demografici - forse nel caso dei Paesi arabi più che
altrove - non sia scindibile dall'analisi delle culture e delle società
entro le quali gli individui agiscono.
La durata della transizione demografica e, di conseguenza, le dimensioni
finali delle popolazioni arabe sono evidentemente subordinate alle
direzioni e alla velocità di trasformazione della tradizionale
organizzazione familiare musulmana e all'abbandono della rigida divisione
dei compiti tra i sessi.
Ma la necessità di rivoluzionarie trasformazioni sociali affinché
sia completata la transizione demografica non costituisce una caratteristica
peculiare della società araba: a ben vedere, anche in Europa
durante il passaggio dalla fase pre-transizionale a quella post-transizionale
gli assetti sociali ed economici sono stati ribaltati da rivoluzionarie
trasformazioni: la diffusione di fratture intergenerazionali, la creazione
di un sistema di previdenza, l'universalizzazione dell'istruzione
connessa al passaggio da un sistema di reclutamento della manodopera
sulla base dello status familiare a quello sulla base delle capacità
personali, e così via.
Il ritardo nel completamento della terza fase della transizione da
parte delle popolazioni arabe determina un lungo periodo di intensa
espansione; le proiezioni segnalano come anche in un'ipotesi di rapido
declino della fecondità (ipotesi di prosecuzione delle tendenze
in atto), le forze d'inerzia demografica attualmente in moto porteranno
le popolazioni dei Paesi arabi a decuplicare le proprie dimensioni
nell'arco di un secolo.
Il rapporto numerico tra mondo arabo e Comunità europea si
sta perciò capovolgendo: solamente nel 1950 i Paesi oggi appartenenti
alla Cee avevano un peso demografico triplo rispetto a quello dei
Paesi arabi (dalla penisola arabica al Maghreb). Nel primo decennio
del secolo avverrà il sorpasso.
Si noti che in poco più di dieci anni la popolazione araba
aumenta di un numero di individui pari a quello di tutti gli italiani
e spagnoli messi insieme.
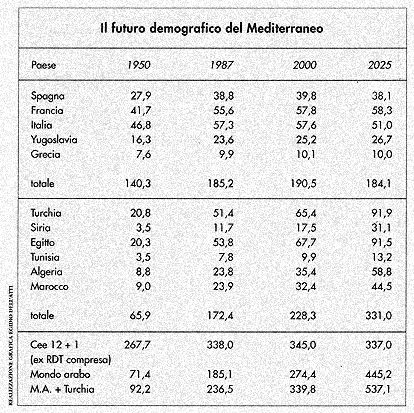
Strettamente correlate alle dimensioni di una popolazione è
la sua struttura per età: mentre le popolazioni europee, una
volta raggiunta la quasi-stazionarietà, si trovano a dover
fronteggiare i problemi legati all'invecchiamento, per i Paesi demograficamente
ancora dinamici il "problema" è attualmente costituito
dalla presenza di classi giovanili di enormi dimensioni.
Già oggi l'Algeria, che non raggiunge i 25 milioni di abitanti,
conta un numero di scolari superiore a quello registrato nelle scuole
italiane. E, come è ovvio, il divario tende a crescere.
La diversa composizione per età delle popolazioni mediterranee
è evidente: su un campione di persone appartenenti ai Paesi
europei troviamo la metà di giovani ed il triplo di anziani
rispetto alle presenze riscontrabili in un campione di eguali dimensioni
proveniente dalla sponda Sud. In entrambi i casi, il tasso di dipendenza
totale (che misura il rapporto tra popolazione 'la carico", cioè
inferiore ai 15 anni e superiore ai 65, e popolazione in età
lavorativa) èpiuttosto elevato, ma in prospettiva, tale indicatore
è destinato a peggiorare nei Paesi europei e a migliorare nei
Paesi arabi e in Turchia, per i quali si prevede una rapida crescita
della popolazione in età lavorativa.
Va quindi sottolineato il fatto che le Popolazioni abitanti le regioni
orientali e meridionali del Mediterraneo saranno chiamate a subire
nei prossimi anni trasformazioni straordinarie non soltanto dal punto
di vista quantitativo ma anche sotto il profilo della composizione
per età.
MAROCCO
Consistenza
della popolazione
Grazie ad un tasso medio annuo di incremento costantemente superiore
al 2,5%, la popolazione marocchina è cresciuta dai 9 milioni
del 1950 ai 20 milioni del 1980. Nel 1987 sono stati raggiunti i 24
milioni ed entro la fine del secolo saranno oltrepassati i 30 milioni
di abitanti.
La fecondità ipotizzata per le proiezioni declina dal valore
attuale prossimo a 6 figli per la donna a 4 nella metà degli
anni Novanta, per passare a 2,35 nel primo decennio del nuovo secolo
ed infine raggiungere la soglia del ricambio generazionale (2,1 figli
per donna) a partire dal 2013. Anche adottando questa ottimistica
ipotesi di deciso declino della fecondità, notiamo come la
popolazione cresca di circa 5 milioni di individui ogni decennio.
In termini relativi, la popolazione marocchina costituiva nel 1950
il 4,2% del complesso delle popolazioni che si affacciano sul mare
Mediterraneo; nel 1985 il peso demografico del Marocco è salito
a 6,2% ed entro la fine del secolo avrà superato il 7%.
La dinamica
del movimento naturale
Nel corso degli anni Ottanta le nascite annue si sono aggirate intorno
alle 800.000 mentre si sono avuti mediamente 240.000 decessi annui.
Il movimento naturale della popolazione è dunque scandito,
ogni anno, da un saldo positivo di oltre mezzo milione di individui.
Il declino della mortalità è in buona parte imputabile
alla riduzione del tasso di mortalità infantile, sceso dal
180 per mille dei primi anni Cinquanta (che corrisponde al decesso
di quasi un neonato sii 5) al 70 per mille alla fine degli anni Ottanta.
Anche in conseguenza di ciò, la speranza di vita alla nascita
è cresciuta del 50%, passando da poco più di 40 anni
agli attuali 60 anni. Entro il 2010 si prevede un ulteriore guadagno
di vita media i circa un decennio.
Le trasformazioni
nella struttura per età
Il fenomeno più evidente nell'evoluzione "qualitativa"
della popolazione marocchina è quella del relativo invecchiamento.
Attualmente l'età mediana è pari a 18 anni., ciò
significa che il 50% della popolazione non ha ancora compiuto il diciottesimo
anno di età. Nell'arco dei prossimi 40 anni tale valore dovrebbe
salire e superare i 32 anni.
La quota di anziani (65 anni e oltre) sul totale della popolazione
non supera attualmente il 4%. Il suo raddoppio è previsto entro
il 2027.
La forte riduzione nella quota di giovani e il parallelo (se pur più
lento) incremento nella quota degli anziani, si traducono in un progressivo
declino dell'indice di dipendenza o di carico sociale, che rapporta
l'ammontare di soggetti teoricamente "a carico" della società
(giovani e anziani) al numero di coloro potenzialmente in grado di
sostenerli.
Da questa netta riduzione (ogni persona a carico nel 1970 dipendeva
da un lavoratore, mentre a partire dal 2007 potrà contare sul
lavoro di due individui) emerge una chance di sviluppo per il Marocco.
La popolazione
in età lavorativa
La popolazione in età lavorativa - i cui limiti sono fissati
convenzionalmente ai 15 e ai 64 anni - tende ad aumentare il proprio
peso sul totale della popolazione.
La contrapposizione tra la consistenza dei flussi quinquennali di
ingresso nell'età lavorativa e quella dei flussi in uscita,
evidenzia, per almeno un paio di decenni, un'eccedenza dei primi sui
secondi dell'ordine di due-tre milioni di unità. In parallelo,
il tasso di ricambio della popolazione maschile in età lavorativa
si mantiene per un lungo periodo al di sotto del 20% per ogni 100
soggetti che fanno il loro ingresso nell'età lavorativa, ve
ne sono non più di 20 che raggiungono i limiti dell'età
pensionabile.
ALGERIA
Consistenza
della popolazione
Come per gli altri Paesi nordafricani, il secondo dopoguerra è
stato un periodo di fortissima espansione della popolazione algerina:
da poco meno di 9 milioni di abitanti nel 1950, si è passati
a circa 23 milioni e mezzo nel 1987, e le previsioni (nell'ipotesi
di una progressiva riduzione dei livelli di fecondità e di
saldo migratorio nullo) stimano per l'anno 2027 Una consistenza totale
pari a oltre 60 milioni di abitanti.
La rapida crescita della popolazione algerina fa registrare ritmi
particolarmente elevati anche rispetto agli altri paesi della sponda
Sud del Mediterraneo: il "peso" demografico dell'Algeria
era nel 1950 pari al 16,9% dei paesi arabi africani e al 4,1% rispetto
al complesso di tutti i paesi mediterranei. Nel 2000 si prevede che
tali valori diventino rispettivamente 19,3 e 7,8%.
La dinamica
del movimento naturale
Come si è visto, il tasso medio di incremento è stato
durante gli anni Ottanta e continuerà ad essere per almeno
un decennio superiore al 3%.
Nel 1987 sono nati in Algeria circa 800.000 bambini (un numero che
nessun Paese appartenente alla Comunità europea ha raggiunto
nello stesso anno). Per contro, i decessi sono stati pari a 161.000.
La differenza, pari a 639.000 individui, costituisce l'incremento
naturale annuo della popolazione algerina; durante gli anni Ottanta,
tale incremento non è mai stato inferiore alle 600.000 unità.
Come abbiamo già visto per il Marocco, un fattore determinante
della crescita demografica attuale, è localizzabile nel declino
della mortalità infantile, scesa verticalmente negli ultimi
anni.
Le trasformazioni
nella struttura per età
Il censimento della popolazione effettuato nel 1987 consente una lettura
approfondita dei tratti demografici algerini. L'aspetto che colpisce
di più rimane l'estrema giovinezza della popolazione: il 55%
dei cittadini algerini non ha 20 anni, mentre solo 6 persone su 100
superano la sessantina.
L'indice di dipendenza tende a ridursi man mano che le generazioni
consistenti nate negli anni Settanta ed Ottanta fanno il loro ingresso
nell'età lavorativa.
La popolazione
in età lavorativa
Come abbiamo già accennato per il Marocco, la futura straordinaria
concentrazione di popolazione in età lavorativa potrebbe costituire
una grande opportunità di sviluppo per i Paesi dell'area.
Certamente dal riuscito o mancato soddisfacimento delle aspettative
di lavoro di milioni di individui, dipendono la stabilità economica
e politica dei paesi interessati.
La contrapposizione tra la consistenza dei flussi annui in ingresso
nell'età lavorativa e quella dei flussi in uscita evidenzia
un'eccedenza dei primi sui secondi che giungerà a superare
nel prossimo secolo le 800.000 unità. Il rapporto tra soggetti
che faranno il loro ingresso nell'età lavorativa e soggetti
in uscita sarà 7 a I.
TUNISIA
Consistenza
della popolazione
La Repubblica di Tunisia è il più piccolo degli Stati
del Nord Africa: sul suo territorio vivevano nel 1950 circa 3 milioni
e mezzo di abitanti. Al censimento del 1984 (l'ultimo effettuato)
se ne sono contati il doppio. La dinamica demografica tunisina appare
meno esplosiva rispetto a quella registrata nei Paesi confinanti (Algeria
e Libia); di conseguenza, le proiezioni della popolazione prevedono
tassi annui di accrescimento più contenuti. La crescita relativamente
più lenta della popolazione tunisina si traduce in una perdita
di peso nell'ambito dei paesi nordafricani: dal 6,8% nel 1950 si passerà
al 5,4% all'inizio del nuovo secolo.
La dinamica
del movimento naturale
Sebbene il tasso di incremento naturale si mantenga al di sopra del
20 per mille, il deciso calo della natalità tunisina lascia
intuire un completamento del processo di transizione demografica in
tempi relativamente brevi.
Se escludiamo il Libano, la Tunisia è il Paese arabo in cui
si registra il minor numero di figli per donna: 4,4 nel 1987, mentre
nel 1970 erano 6. Un ruolo importante è stato svolto dall'accesso
generalizzato ai servizi di pianificazione familiare, praticamente
assenti nella maggior parte dei Paesi arabi.
Una seconda causa del rallentamento della fecondità è
costituito dall'abbandono della poligamia: solo 5 uomini sposati su
1.000 hanno più di una sposa in Tunisia, mentre la media araba
èpari a 56 per mille-, anche in questo caso bisogna riconoscere
alla popolazione tunisina un primato all'interno del mondo arabo.
Le trasformazioni
nella struttura per età
Come abbiamo visto, le differenze del comportamento socio-demografico
della popolazione tunisina sono notevoli rispetto al contesto arabo.
L'attuale struttura per età appare comunque squilibrata, e
dovranno passare ancora alcuni decenni prima che possa dirsi completata
la fase transizionale. L'età mediana è attualmente pari
a 20 anni. Salirà a 35 entro il primo trentennio del nuovo
secolo.
L'indice di dipendenza si aggira attualmente intorno al 74% ma è
destinato a scendere al 64% nel 1999 e sotto il 50% a partire dal
2008.
La popolazione
in età lavorativa
L'alto ritmo di crescita registrato negli anni Ottanta e Novanta,
si attenua progressivamente, pur senza esaurirsi: dalle 150.000 unità
annue si passa a 50-60.000.
Il rapporto tra flusso in uscita e flusso in entrata nell'età
lavorativa si aggira intorno a 4. Si noti che per la Tunisia la pressione
sul mercato del lavoro non avrà un'origine esclusivamente demografica,
ma sarà determinata anche dal processo di femminilizzazione
della forza lavoro attualmente in corso.
EGITTO
Consistenza
della popolazione
Oltre un quarto dell'intera popolazione araba risiede attualmente
in Egitto: nel 1950 la popolazione egiziana aveva già superato
i 20 milioni; al termine degli anni Settanta sono stati raggiunti
i 40 milioni e le nostre proiezioni segnalano come attorno al 2030,
anche ipotizzando una riduzione drastica dei tassi di fecondità,
l'Egitto sarà abitato da oltre 100 milioni di abitanti.
In termini relativi, nel 1950 la popolazione egiziana costituiva il
9,5% dell'intera popolazione dei paesi che si affacciano sul bacino
Mediterraneo. Mezzo secolo dopo, si prevede che il peso demografico
dell'Egitto sull'area sarà salito fino al 14,9%.
La dinamica
del movimento naturale
Durante gli anni Ottanta si sono avute in Egitto circa 1.600.000 nascite
all'anno, mentre i decessi si sono aggirati intorno al mezzo milione-,
il tasso medio annuo di incremento ha recentemente superato il trenta
per mille, valore che corrisponde al raddoppio della popolazione in
meno di 24 anni.
Questa accelerazione della crescita demografica va imputata al netto
calo della mortalità: all'inizio degli anni Cinquanta, un neonato
egiziano aveva una speranza di vita pari a circa 42 anni; uno su 5
non raggiungeva il primo compleanno. Oggi, la speranza di vita ha
raggiunto i 60 anni e la mortalità infantile colpisce un neonato
su 12; per il 2015 si stima che la speranza di vita salirà
fino a 70 anni, mentre la mortalità infantile declinerà
sino al 3,6%, un valore che rimane comunque estremamente elevato rispetto
ai livelli medi occidentali.
Le trasformazioni
nella struttura per età
Come per altri Paesi dell'area, l'età mediana egiziana è
piuttosto giovane: il 50% della popolazione ha meno di 20 anni ed
il 40% meno di 14. Per contro, il numero di anziani (sessantacinquenni
ed oltre) non supera il 4%.
L'indice di dipendenza o di carico sociale appare relativamente meno
alto rispetto alla media dei Paesi arabi.
La popolazione
in età lavorativa
La crescente immissione di leve giovanili particolarmente numerose
porterà la popolazione in età lavorativa a svilupparsi
più velocemente della popolazione totale, sino a comprendere
il 70% di quest'ultima.
La differenza tra i flussi annui in entrata e quelli in uscita dall'età
lavorativa, sarà durante i prossimi tre decenni pari a circa
un milione di Unità. Nel periodo in cui i 5 soggetti fanno
il loro ingresso nella fase della vita dedicata al lavoro, solamente
uno raggiunge i limiti dell'età pensionabile.
TURCHIA
Completiamo questa
breve serie di schede nazionali con la Turchia, Un Paese per alcuni
versi l'unico" nel contesto mediterraneo, diviso tra aspirazioni
occidentali (la Turchia è Stato membro di OCDE, Nato, Consiglio
d'Europa e ha presentato la domanda di ammissione alla Cee) e tradizioni
asiatiche, saldamente inserito nell'arca islamica ma, a differenza
degli altri Paesi musulmani della regione, non appartenente al mondo
arabo.
Consistenza
della popolazione
Come nei casi precedenti, l'intensità della crescita demografica
in Turchia si è mantenuta estremamente elevata a partire dal
secondo dopoguerra. Tra pochi decenni, la popolazione residente in
Turchia dividerà con la popolazione egiziana il primato di
popolazione più numerosa del bacino mediterraneo. Le proiezioni
si basano sull'ipotesi di prosecuzione delle tendenze riproduttive
in atto: dal 1950 ad oggi il numero medio di figli per donna è
sceso da oltre 6 a meno di 4; entro il 2020 si ipotizza un ulteriore
declino fino ad una media di 2,4 figli per donna.
La dinamica
del movimento naturale
Il tasso di natalità della popolazione turca si mantiene elevato
(circa 30 nati all'anno per 1.000 abitanti) mentre quello di mortalità
- anche a causa della struttura per età estremamente giovane
-si aggira intorno all'8 per mille; il tasso di accrescimento naturale
è quindi superiore al 2% annuo.
Ancora preoccupante è il livello della mortalità infantile:
nonostante i significativi progressi raggiunti nel campo dell'alimentazione
e della medicina, che hanno fatto dimenticare gli anni in cui un bambino
sii 4 non raggiungeva il primo anno di età, il tasso di mortalità
infantile è sceso sotto il 100 per mille solamente alla fine
degli anni Ottanta.
La speranza di vita alla nascita è di poco superiore ai 60
anni per entrambi i sessi.
Le trasformazioni
nella struttura per età
La Turchia presenta una popolazione strutturalmente giovane.
Le persone con un'età inferiore ai 15 anni costituiscono un
terzo dell'intera popolazione; per contro, la componente anziana è
piuttosto esigua: solo il 4% degli individui ha più di 65 anni.
I mutamenti previsti per i prossimi decenni modificheranno la struttura:
al 2025 si prevede che i giovani scenderanno sotto il 25% mentre gli
anziani supereranno il 9%. A seguito di queste trasformazioni, l'indice
di dipendenza (o di carico sociale) proseguirà la contrazione
iniziata durante gli anni Settanta.
La popolazione
in età lavorativa e forza lavoro
La popolazione in età lavorativa è cresciuta tra il
1950 e il 1985 da circa dodici milioni di individui a oltre ventinove
milioni; entro il 2025 è previsto un ulteriore raddoppio.
Di fronte a tali dati appare evidente l'enorme rilevanza che il fattore
demografico assume al fine di determinare sia l'offerta potenziale
di lavoro, sia le problematiche di equilibrio economico e sociale
che ad essa si ricollegano.
A differenza di quanto si registra sui mercati del lavoro dei Paesi
arabi (ai quali saranno dedicate le prossime pagine), il mercato del
lavoro turco è caratterizzato da una forte presenza femminile:
alla fine degli anni Ottanta oltre un terzo della forza lavoro era
costituita da donne; le previsioni stimano che tale quota debba salire
nei prossimi anni ed avvicinarsi al 40%.
Anche per questo motivo, appare estremamente elevato il numero di
posti di lavoro che il sistema economico turco dovrebbe creare per
garantire la stabilità dei tassi di disoccupazione di fronte
alla crescente immissione netta di forza lavoro: circa 5 milioni da
oggi alla fine del secolo (due dei quali destinati a giovani donne)
e 14 milioni nei successivi 25 anni.
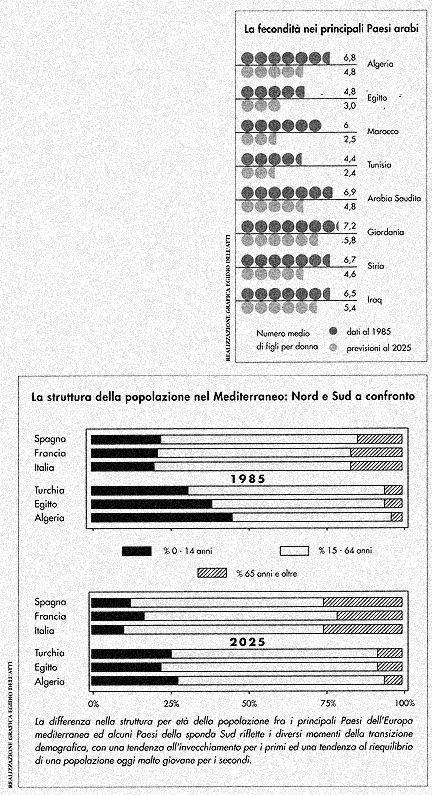
MERCATO DEL LAVORO
E CAMBIAMENTO
SOCIALE NEL MONDO ARABO
L'evoluzione demografica
presente e prevista per i prossimi decenni nei Paesi arabi è
dunque straordinariamente dinamica. Inoltre i ritmi di crescita delle
popolazioni in età lavorative sono ancora più sostenuti
di quelle delle popolazioni globali. Quale potrà essere l'impatto
di tale pressione demografica sui mercati del lavoro?
Nel 1985 la popolazione in età lavorativa nell'interno del
mondo arabo era costituita da circa 97 milioni di individui, il 70%
dei quali abitante in Stati nordafricani (i 5 Paesi mediterranei più
il Sudan).
Nello stesso anno la forza lavoro nei Paesi arabi era valutata intorno
ai 50,5 milioni; il tasso di attività globale (misurato sull'intera
popolazione in età lavorativa) era dunque pari al 52%, un valore
nettamente inferiore al 61% italiano. La ragione principale di questo
sensibile divario sta nel fatto che la presenza femminile sul mercato
del lavoro dei Paesi arabi è limitatissima.
I motivi della bassissima partecipazione delle donne arabe al lavoro
extra-domestico dipendono principalmente dalla netta divisione dei
ruoli tra i due sessi conforme ai principi della tradizione islamica
(non si tratta dunque di una caratteristica peculiare del mondo arabo
che, lo ricordiamo, rappresenta solamente un quinto del panorama islamico
mondiale): il privilegio del contatto con il mondo esterno (che si
attua dapprima grazie alla scuola e in seguito con la vita lavorativa)
è generalmente riservato all'uomo, mentre la vita della donna
si svolge entro i confini familiari.
Fino al 1960 ogni donna araba partoriva in media 7 o 8 figli; i tempi
di allattamento erano allora più lunghi di quelli attuali e
la speranza di vita non superava i 50 anni. Tutta l'esistenza di una
donna adulta era dunque dedicata allo svolgimento del ruolo materno.
Da venti anni a questa parte, tuttavia, si registrano importanti trasformazioni
nella società araba: tra i fattori di cambiamento più
rilevanti si segnala il generale innalzamento della scolarizzazione
femminile.
In tutti i paesi in via di sviluppo si registra un'ineguale partecipazione
scolastica per sesso: nel complesso dei PVS si registravano, all'inizio
degli anni settanta, 72 iscrizioni femminili alle scuole primarie
per ogni cento iscrizioni maschili. Negli stessi anni il rapporto
nei paesi arabi era di 56 per 100. La minor scolarizzazione femminile
nei paesi arabi è evidenziata dai tassi di analfabetismo.
In ogni Paese si registra per entrambi i sessi un netto miglioramento
dei livelli di istruzione; certo, il tasso di analfabetismo femminile
rimane ancora nettamente superiore a quello maschile; ma questo divario
è imputabile in primo luogo al fatto che i progressi della
scolarizzazione possono incidere solo marginalmente sull'analfabetismo
della popolazione adulta e anziana; va poi detto che alcuni punti
percentuali di differenza tra i due sessi nei livelli di istruzione
trovano una giustificazione nella struttura demografica: la popolazione
femminile, più longeva, è mediamente più anziana
di alcuni anni rispetto a quella maschile e, quindi, risente relativamente
meno del peso delle classi giovani più istruite.
La partecipazione scolastica femminile cresce, e questo fatto costituisce
una delle tendenze più rilevanti nelle società arabe
contemporanee.
infatti, anche se il maggiore accesso all'istruzione da parte di giovani
donne arabe non si traduce immediatamente in maggiore partecipazione
al mercato del lavoro, esso contribuisce a rimuovere una delle barriere
all'ingresso, quella dell'assenza di "sapere". Inoltre,
effetti immediati della maggiore scolarizzazione femminile investono
la sfera della fecondità: in primo luogo il prolungamento del
periodo dedicato all'istruzione ritarda il matrimonio e riduce dunque
la fase della vita destinata alla maternità; in secondo luogo
l'allungamento degli studi comporta un incremento notevole dei costi
sostenuti dalle famiglie per l'istruzione che potrebbe incidere sulla
decisione di mettere al mondo un numero elevato di figli; infine l'apertura
al mondo esterno data dalla scuola può offrire alla giovane
donna modelli di realizzazione personale alternativi a quello tradizionale
della maternità: la creazione di aspettative professionali
potrebbe anch'essa contribuire a limitare la fecondità.
A un maggiore livello di istruzione corrisponde dunque un minor numero
di figli e, di conseguenza, una maggiore disponibilità di tempo
da dedicare ad attività extra-domestiche. Quanto poi la maggiore
scolarizzazione delle donne arabe si traduca in una maggiore partecipazione
al mercato del lavoro non è facile prevedere: variabili imponderabili,
quali il ritmo e le traiettorie di sviluppo economico dei Paesi arabi
o il ritorno di sentimenti integralisti islamici, influiscono in maniera
diretta sulla praticabilità di attività extra-domestiche
da parte delle donne arabe.
Se tuttavia non interverranno elementi di freno e di disturbo alle
tendenze più recenti, ci si deve aspettare un forte aumento
della presenza delle donne all'interno della forza lavoro.
Sul versante maschile della forza lavoro nel corso degli anni Settanta
ed Ottanta si è osservata una contrazione piuttosto rapida
dei tassi di attività; le ipotesi assunte prevedono un rallentamento
del calo nel corso dei prossimi anni che porterà, a partire
dal nuovo secolo, ad una stabilizzazione della partecipazione.
Applicando alle proiezioni della popolazione in età lavorativa
i tassi di attività suddivisi per sesso e per età si
ottiene una stima dell'offerta di lavoro proveniente dai Paesi arabi.
Nell'arco di quattro decenni la forza lavoro araba crescerà
di oltre 103 milioni, il che significa che 103 milioni di individui
si presenteranno sul mercato del lavoro per reclamare un posto che
oggi non esiste. La creazione di un numero così ingente di
posti di lavoro rappresenta sicuramente una delle grandi sfide, dall'esito
incerto, per i sistemi economici dei Paesi arabi. Oltre il 60% dei
posti da creare sarà concentrato nei Paesi arabi del Nord Africa:
nel solo Egitto l'offerta di lavoro sta crescendo al ritmo di mezzo
milione di nuovi potenziali lavoratori all'anno.
Per meglio valutare lo sforzo che le economie dei quattro Paesi nordafricani
dovrebbero compiere (10 milioni di posti di lavoro entro la fine del
secolo), ricordiamo che la stessa espansione occupazionale ha richiesto,
per i dodici Paesi attualmente membri della Cee, circa 24 anni: dal
1965 al 1989 gli occupati nei Paesi Cee sono saliti da 122,6 a 132,6
milioni (su un totale di popolazione più che doppio rispetto
alla popolazione nordafricana).
La drammatica affidabilità delle previsioni che abbiamo presentato
trova una conferma nel fatto che le migliaia di persone che si affacceranno
sui mercati del lavoro arabi nei prossimi quindici anni sono già
nate. A rigor di logica, non si dovrebbe nemmeno parlare di previsioni,
ma di lettura orientata al futuro della situazione attuale.
Quando si parla di migrazioni che coinvolgono le popolazioni arabe,
viene spontaneo pensare ai flussi di individui che approdano nei Paesi
europei alla ricerca di un lavoro. Meno note sono altre dinamiche
migratorie che, dal punto di vista quantitativo, non sono meno rilevanti
di quelle dirette verso la sponda Nord del Mediterraneo: ci riferiamo
ai fenomeni di mobilità connessi all'urbanesimo e alle migrazioni
di lavoratori all'interno del mondo arabo.
Le motivazioni che spingono milioni di individui ad abbandonare, almeno
temporaneamente, la regione di origine affondano le proprie radici
nelle difficoltà incontrate dal mondo arabo sulla strada dello
sviluppo. Ma alle spiegazioni di tipo economico (ricerca di occupazione
e di maggiori redditi, abbandono di aree depresse) - che fanno della
mobilità stessa il sintomo più evidente del generale
disagio - si affiancano tuttavia e si combinano motivazioni di altra
matrice; va infatti ricordato come la religione islamica attribuisca
un elevato valore alla mobilità delle persone: dalla pratica
del pellegrinaggio alla diffusione della fede musulmana attraverso
le grandi migrazioni, la mobilità è da sempre intimamente
legata alla storia dell'Islam.
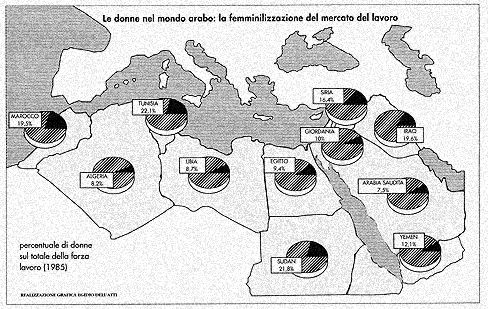
Urbanesimo
nei Paesi arabi
Abbiamo visto in precedenza come il tasso di crescita delle popolazioni
arabe sia stato, nel corso degli ultimi decenni, estremamente elevato;
ancora più alto, tuttavia, è stato il tasso di espansione
della popolazione urbana. In Marocco, ad esempio, si è registrato
un tasso superiore al 4,5% (che corrisponde al raddoppio della popolazione
urbana nel giro di sedici anni).
I problemi connessi all'urbanesimo sono noti: tutti i Paesi conoscono
o hanno conosciuto fasi storiche in cui si verifica una concentrazione
crescente della popolazione nelle aree urbane per effetto di flussi
migratori provenienti dalle campagne di persone che abbandonano l'attività
agricola per cercare lavoro nell'industria o nei servizi.
Nel caso dei Paesi arabi, tuttavia, si possono rilevare due "aggravanti"
che complicano il modello della crescita delle popolazioni urbane:
la fragilità dell'ambiente rurale di partenza e la velocità
alla quale si svolge il processo di urbanesimo. In primo luogo, l'abbandono
sistematico di alcune aree del territorio da parte di giovani uomini
(che mette in moto processi di femminilizzazione e di anzianizzazione
della popolazione locale) si traduce in un deterioramento fisico del
suolo. L'inaridimento di terre un tempo fertili costituisce una minaccia
costante per buona parte dei Paesi arabi: il rischio di desertificazione
è infatti estremamente elevato per l'entroterra maghrebino
e per vaste aree del Medio Oriente (il deserto avanza in tutti i Paesi
della penisola arabica, in Siria come nello Yemen); se si pensa che
la superficie coltivabile è pari al 3,2% dell'intero territorio
algerino, al 2,5% in Egitto e solamente allo 0,5% nell'immensa Arabia
Saudita, si capisce come l'erosione da parte del deserto possa suscitare
ben motivate preoccupazioni.
In secondo luogo, quando l'intensa mobilità interna si combina
con una rapida crescita demografica, l'ampliamento delle strutture
urbane (abitative, di trasporto, ecc.) per accogliere un numero così
elevato di nuovi abitanti, generalmente poco abbienti, avviene in
modo disordinato e si traduce sovente, come insegna l'esperienza latino-americana
e messicana, nello sviluppo di desolanti periferie (bidonvilles),
prive delle più elementari opere di urbanizzazione e che di
l'urbano" hanno solo l'elevata densità.
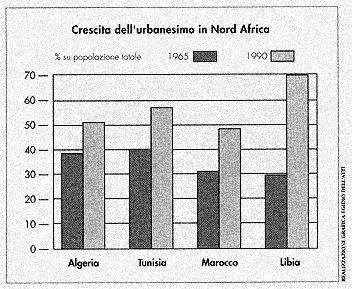
A titolo di esempio citiamo le previsioni delle Nazioni Unite relative
alla città del Cairo: nel 1950 non raggiungeva i 2 milioni
e mezzo di abitanti, alla fine del secolo supererà i 13 milioni.
L'esodo selvaggio verso la città non ha trovato, negli anni
recenti, un valido ammortizzatore nella crescita dell'economia e dell'occupazione.
Da possibile polo di sviluppo, la città nordafricana si scopre
invece fonte di dipendenza alimentare nei confronti dell'estero: su
ogni due calorie consumate dalla popolazione della riva del Sud del
Mediterraneo una è importata.
Non mancano, è vero, tentativi di potenziamento del settore
agro-alimentare per far fronte all'ingente domanda interna; ma questi
vengono ostacolati dall'esiguità della superficie disponibile.
L'ampliamento della superficie arabile grazie a grandi progetti di
irrigazione risulta estremamente costoso (e praticabile solo su scala
medio-grande), mentre la soluzione del disboscamento (il 3,4% della
superficie totale del Maghreb è coperta da boschi) può
provocare effetti a lungo termine controproducenti, in quanto priva
il suolo della sua più valida difesa contro l'inaridimento.
Un ulteriore grave vincolo allo sviluppo del settore agricolo nei
Paesi nordafricani è costituito dalla scarsità d'acqua.
La rapida urbanizzazione provoca un sensibile aumento della domanda
di acqua potabile. E' stato calcolato, ad esempio, che l'attuale consumo
di acqua potabile nell'intera Tunisia sarà in grado di soddisfare,
al 2000, le richieste della capitale.
Il soddisfacimento dei crescenti bisogni idrici dei cittadini (che
consumano, nel Nord Africa, 150 litri di acqua al giorno contro i
10 litri di un abitante delle campagne) rischia di ostacolare i programmi
di potenziamento dell'irrigazione sui quali si fondano le strategie
di rilancio dell'agricoltura.
A ciò si aggiunge il fatto che con la moltiplicazione delle
strutture turistiche (fenomeno che peraltro offre un canale irrinunciabile
di afflusso di valuta estera) si svilupperanno nuove e importanti
richieste di acqua potabile: un turista occidentale consuma in media
oltre 700 litri al giorno di acqua potabile.
Non va infine dimenticato l'impatto ambientale derivante dalla proliferazione
di periferie fatiscenti.
Migrazioni
interarabe
La povertà della terra e la carenza di opportunità occupazionali
hanno provocato da sempre importanti movimenti migratori a partire
dai Paesi arabi; all'inizio del secolo, nella fase di transizione
dall'egemonia ottomana a quella europea, circa 8 milioni di arabi
attraversarono l'Atlantico diretti prevalentemente in America Latina.
Al termine della seconda guerra mondiale si modificarono le destinazioni
scelte dai migranti arabi: un flusso consistente di lavoratori nordafricani
si diresse verso i Paesi industrializzati dell'Europa centro-settentrionale;
un secondo flusso, non meno importante, prese invece la direzione
dei Paesi del Golfo Persico che, con il boom petrolifero degli anni
Cinquanta, divennero forti importatori di manodopera.
Caratteristiche di tali Paesi erano le dimensioni estremamente ridotte
delle popolazioni locali: nel 1950 gli abitanti dei 7 Paesi esportatori
di petrolio (Arabia Saudita, Iraq, Oman, Qatar, Kuwait, Bahrain ed
Emirati Arabi Uniti) non raggiungevano i 10 milioni.
L'eccezionale richiesta di manodopera - derivante da un lato dall'elevata
domanda di greggio espressa dall'economia mondiale, dall'altro dal
boom delle costruzioni reso possibile dall'afflusso di enormi liquidità
- non poteva essere soddisfatta dalla popolazione autoctona (che non
solo era di dimensioni ridotte ma anche piuttosto benestante e poco
disposta a svolgere lavori faticosi o pericolosi; inoltre le note
barriere sociali hanno impedito un significativo maggiore coinvolgimento
della popolazione femminile nei processi produttivi) e, quindi, vennero
attirati lavoratori dall'estero.
Con la crisi petrolifera del 1973-1974, le opportunità lavorative
offerte dai sistemi economici più sviluppati subirono una sensibile
riduzione; i Paesi europei tradizionali importatori di manodopera
(in primo luogo Francia e Germania) inaugurarono politiche immigratorie
restrittive; per contro, il lavoro non venne certo a mancare nei Paesi
produttori di petrolio, ma anzi aumentarono le opportunità
di impiego: la presenza dei lavoratori stranieri nel Golfo assunse
quindi nel corso degli anni Settanta dimensioni ragguardevoli. Non
èfacile quantificare la presenza di manodopera straniera (araba
e non) nei Paesi produttori di petrolio: la condizione di clandestinità
è molto diffusa e i locali sistemi di rilevazione statistica
non consentono di disporre di dati di sicura affidabilità.
Una stima indica in oltre 5 milioni e mezzo i lavoratori stranieri
impiegati nell'anno 1985 nei Paesi del Golfo (escluso l'Iraq); se
a questi sommiamo il milione e mezzo di lavoratori stranieri presenti
in Iraq prima della guerra otteniamo una stima totale di 7 milioni
di lavoratori, rispetto ad una popolazione locale di circa 25 milioni.
1 lavoratori provenienti dai Paesi arabi poveri erano valutati all'inizio
degli anni Settanta pari al 77% della forza lavoro immigrata nei Paesi
del Golfo.
Recentemente la quota è scesa per effetto della crescente concorrenza
loro opposta da parte della manodopera asiatica (indiani e pakistani
in prevalenza, con minoranze di bangladeshi, coreani e indonesiani),
disposta a sopportare orari più gravosi (una media di 47 ore
alla settimana) in cambio di un salario inferiore (162 dinari kuwatiani
al mese contro i 224 ricevuti da palestinesi e giordani); non stupisce
quindi che la composizione etnica della forza lavoro immigrata sia
mutata a sfavore dei lavoratori arabi: dal 77% già citato dell'inizio
degli anni Settanta, la presenza di lavoratori arabi sul totale degli
immigrati è scesa al 57% nel decennio successivo.
Tra i Paesi arabi esportatori di manodopera spiccano la Giordania,
l'Egitto e la Siria. Oltre ai già citati Paesi produttori di
petrolio del golfo, un importante ruolo di attrazione di forza lavoro
viene esercitato dalla Libia, che ha richiamato consistenti flussi
di lavoratori dai Paesi confinanti (Tunisia, Egitto e Sudan) oltreché
dalla Turchia e dalla Giordania (prevalentemente palestinesi).
A differenza di quanto avviene in Europa, dove gli immigrati arabi
difficilmente sono riusciti ad occupare posizioni privilegiate nella
piramide occupazionale, nei Paesi produttori di petrolio la manodopera
araba immigrata è occupata a quasi tutti i livelli professionali,
dall'operaio generico fino alle posizioni medioalte di responsabilità
(direttori del personale, tecnici ad alta qualificazione). Solamente
i vertici dell'organizzazione (posizioni manageriali) vengono occupati
da persone provenienti dagli Stati Uniti e dall'Europa.
Non mancano i segni di disordine e di inefficienza: l'incapacità
dei sistemi locali di istruzione e di formazione di fornire alle economie
personale sufficientemente qualificato genera una situazione di cronica
carenza della forza lavoro dotata di un minimo di bagaglio professionale
e crea notevoli tensioni sul lato delle retribuzioni.
I produttori più ricchi attirano con salari elevati i lavoratori
dagli Stati poveri dell'area, i quali si trovano a loro volta a dover
richiamare forza lavoro dall'estero per colmare i vuoti creati. Così
la Giordania, la Cui forza lavoro era occupata nel 1975 per il 40%,
all'estero ha impiegato nel decennio successivo circa 130.000 immigrati
(prevalentemente egiziani) su una forza lavoro totale composta (la
circa 800.000 individui.
Negli ultimissimi anni l'atteggiamento dei governi arabi nei confronti
delle migrazioni di lavoratori è parzialmente mutato; i Paesi
importatori hanno rallentato la propria produzione di greggio e, soprattutto,
la riduzione del prezzo del petrolio sul mercato mondiale ha limitato
i profitti ed i nuovi investimenti; sono stati quindi imposti controlli
più rigidi all'ingresso di lavoratori stranieri ed i rinnovi
dei permessi di soggiorno e dei contratti di lavoro sono stati concessi
con sempre minore generosità. Per contro i Paesi esportatori,
un tempo nettamente favorevoli all'emigrazione, che riduceva la disoccupazione
e l'instabilità interna, sono sempre più consapevoli
dei rischi determinati da un'emigrazione selettiva, che impoverisce
la già fragile economia nazionale dei migliori elementi.
Ai citati motivi che lasciano supporre una futura contrazione dei
flussi migratori all'interno del mondo arabo (forte concorrenza dei
lavoratori asiatici e politiche immigratorie restrittive da parte
dei Paesi del Golfo) si sono aggiunte prepotentemente le tensioni
della recente crisi irakena e della guerra del Golfo, anche se è
ancora troppo presto per prevedere come i sistemi politici ed economici
arabi sapranno ricucire la ferita aperta.
L'interrogativo che scaturisce naturalmente dalle riflessioni precedenti
è il seguente: quali saranno gli effetti della progressiva
occlusione della maggior valvola di sicurezza per la pressione migratoria
dai Paesi arabi poveri?
Crediamo sia possibile azzardare due risposte: in primo luogo potrebbe
restringersi uno dei principali canali di redistribuzione della ricchezza
all'interno del mondo arabo.
I Paesi in difficoltà economiche, privi di risorse del sottosuolo,
vedranno probabilmente impoverirsi una delle voci attive della bilancia
dei pagamenti con l'estero, quella dell'ammontare globale delle rimesse
degli emigrati; i Paesi arabi più ricchi potrebbero quindi
contribuire in misura ancora inferiore di quanto non abbiano fatto
sinora allo sviluppo dei Paesi poveri.
In secondo luogo, si può ipotizzare una progressiva intensificazione
dei flussi diretti verso l'Europa occidentale, che rimane l'unica
destinazione alternativa offerta dalla mappa geoeconomica della regione.
I rischi per
l'Europa
L'Europa guarda perciò con una certa preoccupazione a questo
scenario e, consapevole del fatto che una strozzatura nello sviluppo
dell'area vicina costituisce una minaccia per i suoi stessi equilibri
sociali ed economici, si interroga sul ruolo che le compete.
Rispetto al recente passato, si è sensibilmente ridotta la
capacità di assorbimento di importanti flussi di immigrati
da parte dei mercati del lavoro europei: non lo dimostra tanto l'osservazione
dei tassi di disoccupazione (peraltro cresciuti, per i dodici Paesi
Cee, da un valore medio del 2,1% nel 1965 a valori prossimi al 10%
alla fine degli anni Ottanta) quanto Piuttosto l'analisi del tipo
di domanda espressa dal sistema produttivo, sempre più orientata
verso personale altamente istruito e qualificato.
Stiamo assistendo in questi anni, in Europa come nelle altre aree
a sviluppo avanzato, a una vera e propria rivoluzione occupazionale
trainata dal rapido mutamento tecnologico: un recente studio della
Commissione delle Comunità Europee sulle prospettive dell'occupazione
stima che entro il 2000 due impieghi su tre saranno direttamente interessati
dalle nuove tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni.
Anche se noi stentiamo ancora a rendercene conto perché siamo
protagonisti e non meri osservatori dei processi, la rivoluzione tecnologica
non soltanto ha modificato profondamente le regole di funzionamento
delle società europee, esaltando come mai prima il ruolo centrale
del sapere e delle risorse umane qualificate, ma nello stesso tempo
ha accentuato le distanze dell'Europa rispetto ad altre aree, segnatamente
rispetto ai Paesi in via di sviluppo dell'area mediterranea.
In questa prospettiva, le distanze con il mondo ex-comunista, pur
importanti, sono comunque minori e avranno probabilmente minori difficoltà
ad inserirsi nel mondo del lavoro comunitario gli immigrati provenienti
dai Paesi dell'Est europeo. I livelli di istruzione di questi ultimi
sembrano infatti meno distanti dalle richieste del sistema economico
di quanto non lo siano quello dei lavoratori africani ed asiatici.
La maggiore predisposizione di alcuni lavoratori dell'Europa centrale
a occupare alcuni nuovi posti che si verranno a creare nei Paesi della
Comunità costituisce un ulteriore elemento da tenere in considerazione
quando si propongono soluzioni ai problemi dell'arca mediterranea.
PROGETTARE LO
SVILUPPO
UN'ALTERNATIVA
ALLE MIGRAZIONI
L'Italia e l'Europa,
sistema politico e opinione pubblica sono stati colti di sorpresa
dalla modifica del modello migratorio, con nuovi flussi non più
richiesti ed auspicati dalle società di arrivo, ma invece indotti,
spinti dall'aggravarsi della situazione demografica, economica e talvolta
politica dei Paesi di partenza.
Forse inconsapevoli della distanza sempre più grande che a
livello demografico, economico e tecnologico ci separa dai Paesi in
via di sviluppo dell'Africa e dell'Asia mediterranea, noi europei
ci siamo trovati impreparati di fronte alla possibilità di
queste nuove e intense migrazioni provenienti soprattutto dai Paesi
arabi dell'Africa settentrionale.
Alla drammatica realtà di una crescente pressione migratoria
si è dunque aggiunta una seconda preoccupante realtà:
quella dell'impreparazione europea ad affrontarla. Non soltanto, si
badi, da parte dei Paesi, come l'Italia, che da poco conoscono il
fenomeno migratorio, stentano a gestirlo sul piano pratico e non ne
hanno ancora pienamente afferrato la complessità politico-culturale,
ma anche da parte di quei Paesi, come la Francia, che hanno ormai
una lunga consuetudine con il fenomeno, ma che, di fronte ai nuovi
termini del problema, sembrano oggi revocare in dubbio tutte le certezze
precedentemente acquisite.
Senza esagerare, si può dire che di fronte alle nuove migrazioni
e al modo di affrontarle l'Europa si trova oggi all'anno zero. Grande
il disorientamento culturale, poche le idee credibili, meno ancora
i progetti politici.
Lasciando per il momento da parte qualsiasi rigore prescrittivo, il
problema va analizzato su diversi piani: culturale, politico, tecnico-economico.
A. Dimensione
culturale.
Si tratta di acquisire una nuova consapevolezza del problema del sottosviluppo
e della povertà, restituendo credibilità alle politiche
di cooperazione allo sviluppo.
La polemica sulla inadeguatezza del contributo delle nazioni più
avanzate alla crescita di quelle più povere è nota,
e non serve insisterci, se non per ricordare che finché la
solidarietà internazionale vorrà fondarsi sul solo obbligo
morale continuerà ad andare purtroppo incontro, come provano
gli ultimi decenni, a delusioni ed insuccessi.
Poiché, tuttavia, la cooperazione internazionale allo sviluppo
resta per accordo unanime l'unica via percorribile per accorciare
le distanze fra Nord e Sud del mondo, allora vale forse la pena che
l'Occidente, e l'Europa in particolare, si interroghino per trovare,
accanto a quelle etiche, ragioni di convenienza per intervenire in
aiuto dei Paesi poveri.
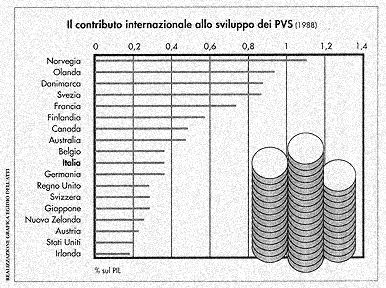
Quegli importanti
trasferimenti di ricchezza (che potrebbero essere necessari anche
in misura superiore a quell'1% di cui spesso si è parlato)
che il loro senso morale non è riuscito in questi anni a fare,
forse potranno farli la paura e l'interesse. Perché questo
avvenga occorre tuttavia che la scelta dei governi sia condivisa dall'opinione
pubblica. E perché l'opinione pubblica dia il proprio consenso
occorre giustificare politiche che non possono essere indolori, facendo
comprendere la lungimiranza di interventi la cui messa in pratica
comporta per le nazioni europee un'importante serie di rinunce e di
sacrifici con dei ritorni non immediatamente visibili. In altre parole,
i sacrifici di oggi devono essere valutati alla luce della convenienza
di evitare i costi che domani l'Europa rischia di dover sopportare.
Da questo punto di vista, vanno preventivati in primo luogo gli effetti
di una massiccia e incontrollabile immigrazione che, data la relativa
impermeabilità occupazionale europea, si tradurrebbero in tensioni
sociali di dimensioni non prevedibili e in costi a carico dei sistemi
di sanità, assistenza e previdenza sociale. La prospettiva
di un esodo di proporzioni gigantesche verso le città europee
(di gran lunga superiore numericamente agli 8-10 milioni di immigrati
che già oggi vivono nella Comunità, con tutte le note
difficoltà) è certo tale da incutere timori. Ma non
è l'unico rischio. Si affacciano, inoltre, dietro l'angolo
nuovi pericoli per la sicurezza dell'intera arca collegati all'instabilità
sociale e politica di alcuni Paesi (tanto a Sud quanto a Est). Ancora
vi è seriamente da temere il disastroso impatto ambientale
determinato dai processi di urbanizzazione selvaggia, che fenomeni
di mobilità accelerata e non razionalmente gestita inevitabilmente
comportano.
Sebbene non si possa dare un quadro esauriente dei rischi futuri derivanti
dalla pressione demografica ed economica dei Paesi poveri dell'area
mediterranea, i pochi esempi fatti dovrebbero già essere sufficienti
per convincere che esistono, al di là delle buone intenzioni
e degli obblighi di solidarietà, oggettivi interessi dell'Europa
ad impegnarsi con maggiore energia e sensibilità sul problema
dello sviluppo globale dell'area. Ci si riferisce, in primo luogo,
alla possibilità di realizzare con i Paesi nordafricani accordi
finalizzati ad interrompere i flussi migratori verso la Comunità,
in cambio appunto di un generoso sforzo in materia di cooperazione
allo sviluppo.
In questo campo occorre abituarsi a ragionare su orizzonti più
estesi, non solo sotto il profilo geografico ma anche temporalmente
utilizzando gli strumenti previsti maggiormente affidabili per speculazioni
di lunga gittata; occorre imparare a valutare gli effetti che si avranno
tra decenni a seguito delle azioni intraprese (o non intraprese) oggi;
preparare infine con debito anticipo quegli interventi che sappiano
ridimensionare le tensioni future.
Solo in questa ottica allargata sarà possibile individuare
le contropartite negoziabili intorno alle quali instaurare un accordo
internazionale, non più costruito intorno all'immagine romantica
delle società ricche che aiutano quelle più povere in
nome di una ipotetica solidarietà internazionale, ma incentrato
sulla più concreta consapevolezza del fatto che i contributi
allo sviluppo sono il prezzo da pagare per contenere le esternalità
negative indotte dalla straordinaria crescita demografica dei Paesi
mediterranei in via di sviluppo. Si tratta quindi di raggiungere una
nuova frontiera culturale, in cui l'aiuto allo sviluppo diventi un
elemento centrale, non marginale delle strategie politiche dei Paesi
comunitari, consapevolmente scelto anche a tutela degli interessi
europei.
B. Dimensione
politica.
L'impreparazione culturale ha conseguenze immediate sulla dimensione
politica: e infatti non esiste oggi alcun progetto credibile in tema
di rinnovamento dei rapporti con i PVS. Nell'area mediterranea qualcuno
parla di passare dall'assistenza allo sviluppo comune (fra sponda
Nord e sponda Sud): prospettiva condivisibile, ma per ora prospettiva
più culturale che politica, perché non ancora suffragata
da linee politiche precise. Anche qui siamo all'anno zero e il disorientamento
prevale. Bisogna osservare che la progettualità e l'attività
delle forze politiche e di governo europee è stata molto più
pronta a rispondere all'improvvisa novità ed emergenza del
collasso del sistema comunista, piuttosto che a reagire a un problema
ben conosciuto e a una crisi da tempo annunciata come quella dei Paesi
in via di sviluppo.
La prima richiesta da fare alle forze politiche e di governo è
allora che senza togliere spazio ai problemi dell'Europa centrale
e orientale, si cerchi uno spazio di progettualità per i problemi
dei PVS, uno spazio adeguato al dramma che essi vivono e ai problemi
gravissimi e drammatici che pongono e si apprestano a porre ai Paesi
europei occidentali. Ridata la necessaria priorità al problema
generale dei PVS, occorre procedere per linee politiche e, a questo
proposito, la Fondazione Agnelli, senza alcuna pretesa di essere già
alla conclusione di un lavoro appena iniziato, invita a riflettere
su alcune questioni cruciali, riservandosi di compiere futuri interventi
più puntuali e più argomentati.
1) Le grandi differenze fra i Paesi in via di sviluppo richiedono
che anche il problema dell'intervento in favore del loro sviluppo
sia disaggregato e differenziato. Se esiste infatti una dimensione
globale e mondiale del problema, al cui interno si colloca ad esempio
la questione del pagamento degli interessi del debito contratto dai
PVS, vi è una dimensione molto importante di accordo regionale,
che può in effetti riguardare anche l'arca mediterranea.
2) In questo senso, pur nel quadro di una strategia mondiale e nel
proseguimento dell'attenzione verso aree storicamente significative
per ciascun Paese (per l'Italia i Paesi sudamericani a causa del forte
insediamento di popolazione di origine italiana), non vi è
dubbio che vi sia un'oggettiva convergenza di interessi dei Paesi
comunitari a indirizzare i propri sforzi verso i Paesi arabi dell'Africa
settentrionale. Da qui la possibilità di dare un peso più
rilevante a questi Paesi, attraverso forme di cooperazione mirata,
sperimentando nel bacino mediterraneo la fattibilità della
partnership per lo sviluppo.
3) Una partnership per lo sviluppo del Mediterraneo postula, probabilmente,
formule, anche istituzionali, di cooperazione-multinazionale, interaraba
e euroaraba. Non vi è infatti dubbio che gli sforzi dei Paesi
europei potrebbero utilmente affiancarsi interventi e sacrifici anche
da parte dei Paesi arabi produttori di petrolio, tradizionalmente
poco propensi alla prodigalità nei confronti dei Paesi nordafricani
e invece più generosi con Siria, Giordania e Yemen.
A supporto dell'ipotesi che i Paesi arabi ricchi possono fare di più
per i loro vicini meno fortunati, ecco alcuni dati: gli aiuti pubblici
allo sviluppo sono stati, negli anni 1987-1988, pari al 3,1% del PIL
in Marocco, dello 0,3% in Algeria, del 3,4% in Tunisia e del 4,9%
in Egitto. Tuttavia, solo nel caso algerino la quota di aiuto proveniente
da altri Paesi arabi ha superato il 10%.
L'Europa comunitaria ha giocato con successo, in quarant'anni di vita,
la carta dell'ingegneria costituzionale: questa esperienza può
essere di stimolo per la cooperazione interaraba e, spogliata di ogni
significato politico e ridotta rigidamente alla dimensione economica,
anche per la cooperazione euroaraba.
4) Una maggiore chiarezza e incisività delle scelte politiche
comunitarie ènecessaria per regolare la dimensione degli scambi
internazionali. E' quest'ultima infatti probabilmente la dimensione
maggiormente conflittuale, entro la quale si confrontano gli interessi
dei produttori dei Paesi a sviluppo avanzato e quelli dei produttori
dei PVS.
La rimozione delle strozzature protezionistiche allo sbocco sui mercati
internazionali più solidi sembra essere una delle condizioni
per la crescita delle produzioni nei Paesi arretrati. Una generosa
opera di finanziamento (trasferimento di risorse) che non si accompagni
a una parziale rinuncia di garanzie degli interessi dei produttori
nazionali rischia di non recare gli effetti espansivi desiderati.
Le speranze di un effettivo sviluppo da parte di aree ancora arretrate
dipendono quindi dalla delicatissima operazione di composizione degli
interessi in gioco, che potrà compiersi solo ricercando un
equilibrato rispetto delle diverse posizioni. Occorre creare, in altre
parole, all'interno della Comunità i presupposti per il successo
degli interventi nei Paesi arabi: non si possono compiere interventi
nell'agricoltura maghrebina, usando risorse dei contribuenti europei,
e nello stesso tempo avere una politica agricola che penalizzi gli
esiti di quegli interventi: sarebbe tra l'altro un pessimo affare
anche per il contribuente europeo.
E' solo un esempio: procedendo nell'industrializzazione, questi esempi
dovrebbero moltiplicarsi. Gestire questi conflitti senza ricorso a
misure protezionistiche presuppone una grande maturità della
coscienza europea e può considerarsi un altro aspetto della
nuova frontiera culturale.
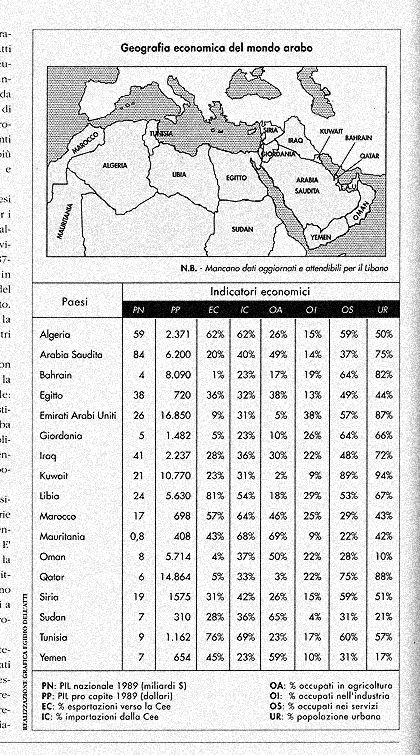
C. La dimensione
tecnico-economica.
All'interno di un quadro di riferimento complessivo che può
essere definito attraverso adeguati strumenti politici e culturali,
ad alcuni dei quali si è accennato nelle pagine precedenti,
la concreta articolazione dei progetti di cooperazione fra l'Europa
comunitaria ed i Paesi del Nord Africa deve muoversi a livello tecnico
ed economico secondo alcune direttrici fondamentali, tutte orientate
al medesimo obiettivo: offrire aiuti mirati che non siano di semplice
sollievo immediato alle disastrose condizioni economiche attuali,
ma realizzino con solidità nel tempo tutti i principali fattori
per uno sviluppo autonomo.
Certo, nella maggior parte dei Paesi arabi della sponda mediterranea
vi è la necessità di rafforzare la struttura economica,
puntando sulla creazione di un'attiva rete di piccole e medie imprese
e su un efficiente sistema cooperativo, all'interno dei quali ricavare
spazi occupazionali adeguati. Altrettanto importanti sono le infrastrutture
di trasporto e di comunicazione, per non parlare delle reti di distribuzioni
commerciali.
Ma forse si tratta di partire da qualcosa che è ancora più
importante e preliminare. Infatti, non vi è aiuto economico
o finanziario europeo che possa essere davvero efficace e risolutivo,
se prima non si creano le condizioni per riceverlo ed utilizzarlo
positivamente.
A monte di tutto si impone dunque l'esigenza di formare una cultura
favorevole al mutamento e, cioè, risorse umane qualificate
in grado di gestire un progetto di cooperazione di ampio respiro.
Non ci si riferisce soltanto alla creazione del personale tecnico
e del management della struttura produttiva, ma anche alla costruzione
di una burocrazia e di un'organizzazione dello Stato adeguate alla
modernità.
Prima di tutto, occorre allora creare un efficace sistema di formazione
che permetta di dotare la maggioranza degli individui di quel bagaglio
di conoscenze di base (matematica, lingue straniere) sul quale sia
possibile innestare specifiche conoscenze professionali e competenze
gestionali. Gli aiuti orientati alla diffusione e alla valorizzazione
della "risorsa sapere" hanno dunque un carattere davvero
prioritario, e in questa direzione l'Europa può e deve offrire
molto in termini di formazione e di strumenti didattici tecnologicamente
avanzati. Accanto alla crescita di risorse umane qualificate, le chances
future di decollo delle produzioni dei Paesi arretrati per una crescita
economica dipendono dai trasferimenti di tecnologie.
Ma forse ancora di più del mero trasferimento, la questione
veramente delicata resta quella della gestione delle tecnologie: in
quali processi produttivi esse vengano applicate, come esse vengano
impiegate e aggiornate nel tempo, quale incremento di efficienza derivi
dalla loro adozione.
Il discorso è naturalmente appena aperto e, come si è
già detto più volte, nessuno può avere ricette
semplici per problemi di così grande complessità. Tuttavia,
è possibile e realistico pensare che l'arca mediterranea possa
davvero costituire un banco di prova per l'avvio di una nuova stagione
nei rapporti politici ed economici tra i Paesi a sviluppo avanzato
e i PVS.
La realizzazione di un serio patto di cooperazione allo sviluppo fra
i Paesi europei e quelli dell'Africa Settentrionale può infatti
portare grandi benefici per entrambi i contraenti. Per i Paesi africani
si tratta, come si è detto, di un'occasione per rafforzare
tutti i principali fattori dello sviluppo (risorse umane e tecnologiche,
investimenti, migliori prospettive di competitività). Per i
Paesi europei si apre la possibilità di legittimamente richiedere
ed ottenere dai propri interlocutori le garanzie di misure efficaci
per arrestare all'origine i flussi migratori.
Transizione
demografica
Dieci miliardi...
un solo pianeta
L'osservazione
dell'evoluzione delle popolazioni degli ultimi due secoli ha portato
all'elaborazione della cosiddetta "teoria della transizione demografica";
secondo tale teoria, il processo di modernizzazione di ogni popolazione,
parallelo al percorso economico dell'industrializzazione, avviene
seguendo una successione di fasi storiche.
In sintesi, si possono localizzare quattro fasi distinte:
1) fase pre-transizionale, con tassi di mortalità e natalità
entrambi elevati; la popolazione si mantiene stabile o cresce leggermente;
2) prima parte della transizione propriamente detta, con declino dei
tassi di mortalità e natalità che rimane a livelli elevati;
la popolazione inizia a crescere rapidamente;
3) seconda parte della transizione p.d., in cui al declino della mortalità
si affianca il declino della fecondità; la popolazione è
sempre in espansione, ma a ritmi meno elevati;
4) fase post-transizionale, in cui i tassi di mortalità e di
natalità hanno ormai raggiunto livelli molto bassi; la popolazione
si assesta ad un nuovo livello di equilibrio.
Per l'Inghilterra ed i Paesi scandinavi, la dato di inizio della transizione
può essere collocata alla fine del XVIII secolo, mentre l'uscito
dalla transizione avviene nel secondo dopoguerra: l'intero processo
è durato circa un secolo e mezzo. In Italia il declino della
mortalità divento significativo solamente verso la fine del
secolo scorso; nonostante il rito iniziale rispetto ai Paesi dell'Europa
settentrionale, la transizione italiano si è completata con
gli anni Sessanta, con una durata totale di circa ottanta anni.
Il caso spagnolo è in tutto simile a quello italiano, con l'unica
differenza rappresentata da un rallentamento del declina della natalità
durante l'epoca di Franco, seguito da un'accelerazione a partire dalla
fine del regime franchista.
Pur con importanti differenze, il processo di transizione si è
ormai completato in tutti i Paesi a sviluppo avanzato. Nella maggior
parte dei Paesi in via di sviluppo, al contrario, il processo è
attualmente in atto. Una significativa differenza tra il modello transizionale
europeo e quello di molti PVS (tra i quali i Paesi arabi) consiste
nella diversa intensità di crescita delle popolazioni nelle
fasi centrali della transizione: il tasso di incremento naturale (dato
dalla differenza dei tassi di natalità e di mortalità)
più elevato registrato durante i primi anni dei secolo in Germania,
Belgio, Cecoslovacchia o durante gli anni Venti in Italia, Spagna
e Grecia (cioè nei periodi di massima crescita naturale) è
stato inferiore ad 1,5%, un valore che porta ad un raddoppio della
popolazione in circa 47 anni. In Messico (casi come in Brasile e in
altri Paesi dell'America Latina), dove la transizione è iniziata
verso il 1920, il tasso di incremento naturale durante gli anni Sessanta
è stato pari a 3,4%: in presenza di un così elevato
divario tra i valori di natalità e di mortalità. il
raddoppio della popolazione avviene in soli 20 anni!
Attualmente il declino della natalità nei Paesi dell'America
Latina lascia supporre un completamento del processo transizionale
entro il primo decennio del nuovo secolo. Meno facile prevedere un
termine per l'espansione demografica dei mondo arabo. La transizione
in quei Paesi si è avviato in tempi relativamente più
recenti: la lotta contro l'elevata mortalità ha infatti dato
i primi risultati solamente a partire dalla seconda metà degli
anni Quaranta. Una meccanica trasposizione al sistema demografico
arabo dei tempi transizionali misurati per le popolazioni dei Paesi
sviluppati (da 70 a 150 anni) - pur con tutti i limiti che una tale
operazione comporta - permette di ipotizzare la fine della transizione
araba tra il 2015 ed il 2090. Il XXII secolo potrebbe dunque aprirsi
con una stabilizzazione della popolazione mondiale attorno ai 10 miliardi
di abitanti.
Islam in Europa
Diversi ma
integrati
Gli immigrati
islamici in Europa sono oggi circa dieci milioni e la loro presenza
può considerarsi stabile e definitiva. L'Ipotesi di un Islam
europeo è dunque concreto. Come sarà? Sopra diventare
un Islam moderato e modernizzato? O sarò piuttosto un Islam
fondamentalista, gelosamente attaccato agli aspetti più radicali
della sua ortodossia? Sono interrogativi legittimi ed attuali, perché
già oggi l'islam rappresenta in Europa un nuovo importante
polo ideologico e religioso. Ed è bene che lo diventino anche
per l'Italia, in considerazione dei fatto che anche da noi la grande
maggioranza degli immigrati extracomunitari è islamica.
Esiste naturalmente una profonda relazione fra l'evoluzione dell'Islam
europeo e le strategie di integrazione degli immigrati. Un'analisi
delle esperienze dei principali Paesi europei mette in evidenza due
principali modelli d'integrazione: l'integrazione individuale e l'integrazione
comunitaria (la strategia adottata in Germania non può definirsi
di integrazione, poiché l'immigrato è sempre gastarbeiter,
lavoratore ospite che prima o poi deve andarsene).
L'integrazione individuale postula la laicità e l'indivisibilità
dello Stato e richiede l'accettazione di alcuni valori comuni a tutta
la società. Entro questo ambito, ciascun immigrato adotta strategie
personali di inserimento e definisce autonomamente i limiti della
propria appartenenza alla comunità etnica e culturale d'origine.
Ciò significa, nel caso dell'Islam, che il singolo individuo
può scegliere di continuare a seguire le leggi coraniche come
fatto privato o, comunque, non in opposizione alle norme della convivenza
sociale.
Radicalmente diversa è l'integrazione (o meglio l'inserzione)
comunitaria. In questo caso, la comunità immigrato vuole essere
messo nelle condizioni di preservare in toto la propria identità
etnica e culturale, mantenendone tradizioni ed usi. A questo fine
può richiedere uno speciale regime giuridico che riconosca
il suo statuto di minoranza etnica, tuteli la sua diversità
ed esiga dallo Stato politiche sociali conseguenti. L'estensione dei
diritti speciali per la comunità immigrata, vere e proprie
eccezioni alle regole sociali generali, può variare molto e
spaziare dai casi più marginali e curiosi (come l'esenzione,
in vigore in Gran Bretagna dal 1976, dall'obbligo del casco della
moto per i Sikh: non sta sopra il turbante rituale) fino a toccare
le strutture fondanti della convivenza. Ed è qui che la differenza
degli universi culturali si trasforma in complessi problemi sociali
e giuridici dei tutto nuovi per l'Occidente. Si pensi solo alle radicali,
incompatibili differenze che separano dalla nostra la concezione islamica
del diritto familiare (poligamia, rifiuto della parità dei
sessi) o quella dei rapporto fra religione e Stato.
Oggi in Europa la discussione sui due modelli è quanto mai
viva e riflette le difficoltà che i principali Paesi, Francia
e Gran Bretagna soprattutto, incontrano con le popolazioni immigrate.
La Francia da anni ha adottato consapevolmente il modello di integrazione
individuale, che però attraversa oggi una crisi profonda, alimentata
in particolare dalle pressioni della comunità islamica a favore
dei modello alternativo, l'inserzione comunitaria. In Gran Bretagna
sono state compiute scelte diverse e si è perseguito una forma
di integrazione che aveva molte caratteristiche dell'inserzione comunitaria,
ma non prevedeva il riconoscimento dello statuto di minoranza etnica
e l'istituzione di un vero regime giuridico particolare. Oggi le pressioni
delle comunità immigrate per conseguire anche questi ultimi
obiettivi stanno creando oltremanica tensioni sociali e discussioni
politiche.
In sostanza, le maggiori esperienze europee segnalano un accentuarsi
delle tensioni nel momento in cui aumento la pressione delle popolazioni
immigrate per Forme d'integrazione comunitaria. E' del resto comprensibile
che proprio questa strategia incontri grande Favore presso le popolazioni
e le comunità islamiche, anche Fra quelle insediate da più
lungo tempo. L'inserzione comunitaria è in effetti funzionale
all'obiettivo di rivendicare e conservare l'identità culturale
e religiosa, aspirazione connaturata alla storia di ogni popolo che
abbia conosciuto l'emigrazione. D'altra parte, è proprio sulla
legittimità e sull'estensione dei diritti speciali connessi
a questa forma di inserimento che nascono le perplessità dell'opinione
pubblica e delle forze politiche europee.
Non è irragionevole pensare che anche in Italia l'integrazione
individuale e l'inserzione comunitaria si presentino come le due possibili
alternative d'inserimento.
Bisogna dunque incominciare a chiedersi da che cosa dipende la scelta
dell'una o dell'altra. Intanto, bisogna ammettere che gran parte della
questione è nelle mani delle popolazioni immigrate. Come sarà
l'Islam in Europa dipende dagli immigrati islamici. Questo non significa
che l'Italia e l'Europa non abbiano voce in capitolo. Vi sono anche
altri Fattori in gioco e, Fra questi, il numero degli immigrati, che
senza essere condizione sufficiente può Fare la differenza.
In altri termini, finché il numero di immigrati rimane contenuto
in termini ragionevoli, è possibile discutere e contrattare
le possibili strategie di integrazione. Mantenere, cioè, la
presenza immigrata entro le dimensioni attuali permette di pensare
a strategie di integrazione individuale forse più adatte a
comporre le tensioni economiche, sociali e culturali che inevitabilmente
sorgono. E questo, nel lungo periodo, potrebbe incoraggiare (più
di un'ipotesi, è una speranza) un'evoluzione in senso moderato
e moderno dell'Islam europeo.
Se invece il numero degli immigrati dovesse raddoppiare o triplicare,
aumenterebbero le pressioni per una soluzione comunitaria all'integrazione.