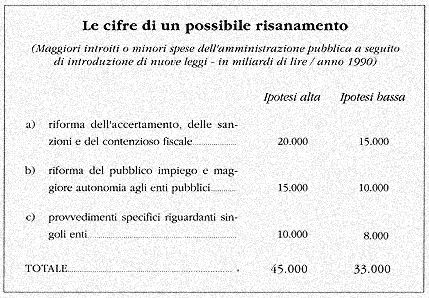Dimentichiamoci
le cifre, questi assillanti 130, 140 o 150 mila miliardi di fabbisogno
che incombono tutti i giorni sul ministero del Tesoro e che di certo
contribuiscono al suo aspetto sempre più invecchiato ed affranto.
Dimentichiamoci la necessità di dover ricorrere quasi ogni
settimana ai mercati finanziari, rigirando oltre mezzo milione di
miliardi di titoli all'anno per sopperire alle esigenze fameliche
del settore pubblico. Prendiamo invece il problema un po' più
alla lontana e, se sì vuole, con un po' di serenità:
apparirà chiara la necessità di incidere sulla struttura
dei conti pubblici, mentre finora ci si occupa del giorno per giorno
(o, al massimo, dell'anno per anno).
Come si fa a incidere sulla struttura? La risposta forse non sarà
così usuale: occorre modificare alcune norme di base della
finanza pubblica. Il problema da ragionieristico diventa costituzionale
e si inserisce a buon diritto nell'ambito di quelle riforme che tutti
invocano ma che non si fanno. Esponiamo una serie di proposte "eretiche",
ben sapendo che senza eresie il mondo non può camminare.
La prima eresia è veramente grossa e riguarda il lato delle
entrate. Secondo noi, occorre riformare in maniera radicale il sistema
di accertamento, riducendo le amplissime garanzie istituzionali di
cui i cittadini godono.
La logica che sovrintese all'introduzione dell'Irpef e alla riforma
fiscale di vent'anni fa fu infatti un enorme passo avanti sul cammino
della libertà, ma di queste libertà i cittadini non
si sono dimostrati all'altezza. Agli uffici delle imposte veniva tolto
quasi ogni grado di discrezionalità: sorteggiare gli accertamenti
significa cercar funghi in un bosco con gli occhi bendati. Tutto ciò
portò anche a una grande caduta di potere e di prestigio degli
uffici e al cronico malcontento dei loro addetti, i quali fuggono
dalle sedi più complicate (che sono poi le grandi città,
dove, tra l'altro, la vita costa cara e le abitazioni non si trovano)
per rifugiarsi nelle più tranquille sedi di provincia. I cittadini
hanno quindi vissuto vent'anni liberi da tassazioni induttive e da
indagini mirate e potenzialmente persecutorie. Non ne hanno fatto,
però, buon uso: la paura di essere scoperti in caso di evasione
si è ridotta a poca cosa e l'evasione stessa è probabilmente
molto aumentata, nella quasi certezza dell'impunità.
Il rimedio è semplice. Occorre restituire agli uffici fiscali
un po' dell'autonomia che avevano prima, cercando di evitare in più
possibile quel tanto di vessatorio che tale autonomia comportava.
Come in quel passato ormai lontano, l'ufficio fiscale dovrebbe poter
accertare chi vuole; dovrebbe poter decidere quale contribuente sarà
oggetto delle sue attenzioni. A differenza di quel passato e a garanzia,
almeno parziale, del carattere non persecutorio dell'azione dell'ufficio,
l'ufficio stesso dovrebbe rispettare certe procedure nell'accertamento,
aventi carattere generale, ed essere impegnato a ottenere certi risultati,
pubblicamente noti, in termini di redditi recuperati a tassazione;
da questi risultati dovrebbero dipendere parte della retribuzione
e della carriera dei funzionari.
In altri termini, in quest'ipotesi, il capo dell'ufficio potrà
stabilire a sua discrezione (resta da vedere se totale o parziale)
di accertare i redditi di determinate categorie (e in taluni casi,
su documenti indizi, del singolo contribuente) a livello locale, per
esempio dei notai o dei commercianti di pellicce. Se però l'accertamento
risulterà sbagliato (secondo il successivo giudizio di una
commissione tributaria) i funzionari "persecutori" saranno
personalmente penalizzati. E lo saranno anche se non raggiungeranno
un target prestabilito di imposte recuperate, mentre saranno premiati
con aumenti di stipendio o avanzamenti in carriera se il target sarà
superato.
Siamo consapevoli che in questo modo si perde una garanzia per il
cittadino, rappresentata dalla larga impersonalità con la quale
il fisco ora procede. Si possono però fare tre obiezioni: la
prima, alla quale si è già accennato sopra, è
che i cittadini, e in particolare certe categorie, con una evasione
sfacciata e crescente, questa garanzia non se la sono meritata. Va
poi considerato, ed è questa la seconda obiezione, che se non
si procedesse in questo modo, un prolungato deficit dell'amministrazione
pubblica condurrebbe alla perdita di ben altre libertà; infine,
si consideri che nell'ipotesi proposta non si restituirebbe discrezionalità
agli enti locali, dai quali provenivano in passato gli abusi più
odiosi.
Alla riforma dell'accertamento andrebbe unita la riforma delle sanzioni,
oggi così tremende da essere poco applicate, come quelle previste
dalle grida manzoniane di buona memoria. Ciò che oggi succede
è ben noto: il funzionario scopre infrazioni gravissime, spesso
di tipo formale (per esempio, il codice fiscale errato su tutte le
fatture emesse) e calcola la multa dovuta, che è in genere
elevatissima, tale da forzare l'azienda a chiudere. A questo punto,
ecco i pianti dell'evasore, e sovente il funzionario si lascia commuovere,
suggerisce le rettifiche formali possibili e limita l'accertamento
a infrazioni marginali.
Occorrerebbe poi reintrodurre il principio antico secondo cui, fino
a un certo limite (diciamo il dieci per cento), la differenza tra
reddito dichiarato non dà luogo a sanzioni ma solo al recupero
di imposta. Sull'evasione successiva, però, non si farebbe
alcuno sconto, o comunque uno sconto inferiore all'attuale; e le sanzioni
dovrebbero essere realistiche invece che demagogicamente terroristiche.
Di pari passo alla riforma delle sanzioni, occorrerebbe procedere
alla riforma del contenzioso, semplificando i gradi del giudizio,
collegando le commissioni provinciali via computer, in modo che si
possano conoscere le motivazioni di decisioni sui casi simili, ed
emanando direttive a livello nazionale sul casi più controversi
(per esempio: l'annoso problema del trattamento fiscale dei rimborsi
spese ai professionisti).
Infine, i condoni: in un certo senso, si può dire che occorrerebbe
farli senza dirlo. Con l'obiettivo di massimizzare il recupero d'imposta,
un ufficio autonomo nei suoi accertamenti si concentrerà naturalmente
sugli anni più vicini, i cui redditi sono generalmente più
elevati e per i quali è più facile contestare la mancanza
di congruità delle dichiarazioni. Ciò potrà essere
incoraggiato da una direttiva ministeriale che consigli di iniziare
dall'ultimo anno risalendo all'indietro, mentre oggi avviene spessissimo
il contrario: il fisco si concentra su anni lontani per paura di "perderli".
Quanto si recupererebbe con tutte queste misure? Naturalmente non
si può che avanzare qualche stima, o, meglio ancora, fissare
qualche obiettivo, senza il quale la tanto celebrata lotta all'evasione
rimane poco più che aria fritta. Pensiamo, come effetto di
queste riforme, a un incremento di gettito pari al 5 per cento del
gettito totale, pari cioè a 15-20 mila miliardi circa. Tale
risultato dovrebbe ottenersi a regime, ossia in 1-2 anni dall'entrata
in vigore di questo complesso di riforme, a parità di ogni
altra condizione. Sarebbe questo, secondo noi, un obiettivo ragionevole
e raggiungibile.
Veniamo ora alle eresie dal lato della spesa. L'idea che andiamo ripetendo
da tempo è che non appare comunque possibile rimettere ordine
nella finanza pubblica se non si cambia la legge sul pubblico impiego.
Di fatto, se consideriamo il ruolo originario dell'amministrazione
pubblica, che è quello della produzione di servizi, appare
impossibile procedere a un risanamento se non si recupera il controllo
su uno dei fattori produttivi, che è il fattore lavoro.
Recupero del controllo significa, prima di tutto, eliminazione di
numerose rigidità che sovente fanno del lavoratore pubblico
il principale, anche se indiretto, beneficiario dei servizi che egli
stesso produce. L'intero status giuridico del pubblico dipendente
va rivisto e qualche, ahimé troppo timido, passo in questo
senso è già stato fatto: vanno eliminate una serie di
pastoie alla moderna azione manageriale, dall'assunzione mediante
pletorici concorsi alla pratica impossibilità non solo di licenziare
ma anche di spostare il dipendente che non è d'accordo, di
promuovere i bravi e penalizzare coloro che bravi non sono, per non
parlare poi dei mutevoli e cospicui privilegi (orari di lavoro di
fatto più brevi del settore privato, minor controllo sulla
produttività, miglior trattamento pensionistico, più
miti controlli in caso di malattia, eccetera) di questo settore. Un
recente studio di Lionello Tronti e Renato Brunetta stima che la retribuzione
effettiva dei pubblici dipendenti, tenuto conto di tutti questi benefici,
sia circa tripla di quella del settore privato.
La nuova legge dovrebbe sovvertire questo stato di cose, sancire la
modalità tra amministrazioni, almeno a livello regionale, equiparare
il trattamento pensionistico, introdurre controlli di produttività
e reintrodurre le "note di qualifica", abolite sotto la
spinta del Sessantotto. Quest'ultima esigenza ne propone un'altra:
non ha senso una nuova legge sul pubblico impiego senza una legge
fondamentale sul settore pubblico che garantisca l'autonomia delle
singole unità dell'amministrazione, cioè un ampio grado
di libertà nell'organizzazione dei servizi, nonché l'introduzione
di premi e penalizzazioni pecuniarie collegate con il raggiungimento
di determinati obiettivi.
Per la scuola, per esempio, ciò significherebbe: a) la fine
delle zone" che obbligano l'iscrizione agli istituti scolastici
più vicini; b) un'ampia possibilità di sperimentazione,
variazione di orari e di programmi, eccetera; c) la determinazione
di una parte consistente della retribuzione in base ai risultati (pensiamo
a due parametri, la percentuale di studenti che sceglie quella scuola
invece di un'altra scuola pubblica "concorrente", e i risultati
agli esami). Proprio la scuola rappresenta la principale sfida-occasione
per la finanza pubblica. Il calo demografico implica che, su oltre
un milione di insegnanti oggi presenti negli istituti di istruzione
pubblica, 150-250 mila saranno resi superflui nel corso del decennio.
Finora le organizzazioni sindacali li hanno recuperati tutti, con
i metodi più fantasiosi (insegnanti "di sostegno",
eccetera), ma ciò non sarà più possibile. Come
abbiamo sostenuto altre volte, occorre pensare alla scuola come ad
un grande serbatoio di forza lavoro qualificata cui attingere, in
regime di mobilità, per le esigenze di molti altri settori,
dalle biblioteche ai musei, dagli uffici di quasi tutti i ministeri
alle poste, eccetera. Nella scuola, poi, sono possibili vistose economie
pubbliche. Basterebbe stabilire che il numero minimo di studenti per
classe è di 25 o 30; introdurre controlli più severi
contro l'incredibile assenteismo degli insegnanti; abolire i "distacchi"
che pongono diecine di migliaia di insegnanti pagati dallo Stato al
servizio di sindacati e di partiti; essere meno generosi con le esenzioni,
concesse per i motivi più vari (incarichi politici, eccetera).
Si potrebbe anche introdurre la figura dell'insegnante a tempo definito,
con retribuzione inferiore all'attuale. Le economie non si realizzerebbero
solo nella scuola ma in tutta l'amministrazione, per effetto della
mobilità (il trasferimento di personale ex scolastico ridurrebbe
la necessità di assumere). Anche qui, è difficile tradurre
in cifre l'azione di risanamento: riteniamo però che a regime,
ossia in due-tre anni, non sia irrealistico pensare di ridurre la
spesa del personale di circa 10-15 mila miliardi, una cifra che si
colloca tra il 5 e l'8 per cento del totale.
Stiamo conducendo pazienti ricerche per veder quali altri settori
della spesa pubblica potrebbero essere ridimensionati.
Riteniamo che i migliori risultati si potrebbero ottenere con enti
pubblici a carattere locale o distribuiti sul territorio. Non siamo
per una loro abolizione indiscriminata, come si è già
tentato senza fortuna, bensì per un loro graduale passaggio
a un'ottica intermedia tra pubblico e privato, con riduzione dei finanziamenti
pubblici.
Un primo esempio sono i contributi INPS ai padronati (di fatto un
finanziamento occulto ai sindacati e una pressione per l'aumento indiretto
della spesa pensionistica, là dove contribuiscono a procurare
pensioni non dovute, specie di invalidità). Attualmente tali
finanziamenti sono di 1.000 miliardi l'anno.
Un secondo esempio riguarda la spesa del ministero del Lavoro per
l'istruzione tecnica e professionale, elevata e ben poco produttiva.
Un terzo esempio sono le Camere di Commercio; la componente pubblica
del finanziamento potrebbe ancora essere ridotta mentre potrebbe esserne
incentivata la mentalità imprenditoriale, espressa nel considerare
i fruitori dei servizi come clienti anziché come utenti.
C'è molto spazio per tagli di spesa anche nelle Università:
per esempio, riducendo i contributi statali ai singoli atenei in misura
pari al costo dei corsi che hanno meno di 10 esami o 10 studenti promossi
all'anno (ce n'è una quantità enorme) o annullando quelli
all'Università di Camerino (costerebbe meno mandare i futuri
laureati a studiare nelle migliori università americane). Occorrerebbero
poi controlli sull'assenteismo dei docenti.
Infine, riteniamo che i servizi di numerosi enti potrebbero essere
resi più efficienti e fatti pagare più cari a chi li
usa. Gli enti o servizi in questione vanno dalla Gazzetta Ufficiale
a buon prezzo, mal stampata e poco reperibile, alle carte dell'Istituto
Geografico Militare (poco costose e difficili da trovare).
Obiettivo sensato è quello di ottenere dall'insieme dei provvedimenti
minori spese e/o maggiori incassi per circa 8-10 mila miliardi.
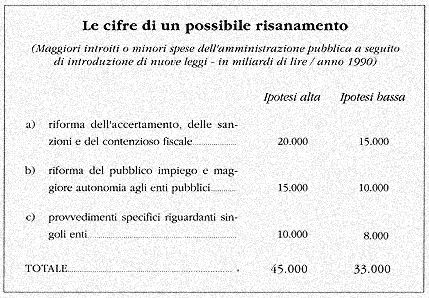
Complessivamente
quindi, come si può osservare dalla tabella qui sotto riprodotta,
si otterrebbe, nel giro di 2-3 anni, un miglioramento valutabile in
33-45 mila miliardi. E questo senza mettere in conto inasprimenti
fiscali, riforme pensionistiche, tagli alla sanità e privatizzazioni,
tutte cose in vario modo realizzabili.
Come si può vedere, la nostra Finanziaria sarebbe particolarmente
"comoda'' per un ministro del Tesoro. Sarebbe però molto
"scomoda" dal punto di vista politico perché inciderebbe
davvero sui rapporti di potere e sulla distribuzione dei redditi in
Italia. Taglierebbe rami secchi, imporrebbe cambiamenti. Ci sarà,
in questa legislatura, un governo in grado di muoversi lungo queste
linee?
Per i contribuenti di tutta la Cee, le novità non vengono più
solo dai governi nazionali ma anche, in misura crescente, da Bruxelles.
Il nuovo spettro fiscale che gira per l'Europa si chiama "ecotassa"
e consiste in un prelievo, ingentissimo, sui consumi di combustibili
fossili di tutta l'area comunitaria: addirittura 10 dollari al barile
di petrolio greggio (o quantità di altri combustibili che producono
energia equivalente). L'ecotassa potrebbe passare in fretta dai tavoli
degli uffici studi alle colonne della Gazzetta Ufficiale Europea e
diventare obbligatoria per tutti con pochissima discussione: piace,
infatti, a molti.
Piace, in primo luogo, ai futuri beneficiari. L'euroburocrazia si
trova infatti a disporre di risorse finanziarie assolutamente inadeguate
alle proprie necessità (qualcuno potrebbe dire: alle proprie
ambizioni), soprattutto perché largamente divorate dalle spese
di sostegno all'agricoltura. Queste, nel 1990, hanno assorbito ben
il 54,7 per cento del totale, lasciando spazi esigui alle cosiddette
l'azioni strutturali", ossia alla politica industriale, con interventi
in materia di trasporti, ricerca scientifica e tecnologica, alla politica
regionale, eccetera. La preoccupazione per le esiguità del
bilancio si proietta poi pesantemente sul futuro, in quanto le risorse
derivanti dai dazi alle frontiere esterne - l'entrata caratteristica
delle finanze comunitarie - tenderanno strutturalmente a decrescere
con i progressi del Gatt e lo sperabile accordo mondiale sulla libertà
dei commerci che dovrebbe scaturire dall'Uruguay Round. L'ecotassa
farebbe piovere in un colpo solo e in maniera relativamente semplice
una notevolissima massa di risorse finanziarie su Bruxelles. Considerando
che il consumo comunitario di petrolio e carbone è di circa
4.500 milioni di barili equivalenti annui, il prelievo corrispondente
sarebbe di 37,5 miliardi di Ecu, quasi 60.000 miliardi di lire, portando
le entrate da 46,5 a 84 miliardi di Ecu, ossia raddoppiando circa
l'eurobilancio.
In secondo luogo, l'ecotassa piace agli ambientalisti. Essa si inquadra
nel piano per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica,
tipiche dei combustibili fossili, dai quali pare derivare il temuto
effetto serra. Tale piano ha già portato Bruxelles ad approvare
norme tassative che limitano le emissioni di ciascun Paese della Comunità
e obbligano le imprese a importanti investimenti. Il piano dovrebbe
risultare già sufficiente di per sé, ma l'idea di appoggiarlo
con lo strumento fiscale, come ulteriore incentivo all'uso di altre
fonti di energia, è indubbiamente benvenuta in questo segmento
dell'opinione pubblica, che sovente nutre forti pregiudzi anti-industriali.
L'ecotassa può però, in terzo luogo, piacere non solo
agli ambientalisti ma all'opinione pubblica in generale, in quanto
può essere presentata come strumento in grado di migliorare
la qualità dell'ambiente e prevenire l'autodistruzione della
specie umana. I temi tecnologici toccano una corda molto sensibile
nel cuore degli europei, come dimostra il successo commerciale di
molti prodotti "verdi", dai detersivi agli alimenti. Inoltre,
come per tutte le imposte indirette, la parte attiva della popolazione
nutre ragionevoli speranze di riuscire a ribaltarla, almeno in parte,
su altri. Noi invece guardiamo a questa prospettiva con notevole diffidenza
per almeno quattro buoni motivi.
Siamo scettici nei confronti della burocrazia di Bruxelles. Pur senza
condividere le posizioni estreme della signora Thatcher, che considerava
gli euroburocrati più o meno come incarnazioni del demonio,
riteniamo che un aumento senza controllo del loro potere sia comunque
da evitare. Prima di introdurre l'ecotassa vorremmo veder ridurre
i sussidi all'agricoltura. Riteniamo che nel breve periodo non ci
sarà alcun effetto positivo sull'ambiente. Tutti gli studi
in materia sono concordi nel dimostrare che l'aumento dei prezzi energetici
non fa assolutamente calare il consumo di energia. C'è quindi
la prospettiva che si continui a bruciare carbone e petrolio come
prima, semplicemente pagandoli il 40 per cento in più.
Nel lungo periodo le emissioni si ridurranno solo se l'ecotassa sarà
accompagnata da importanti interventi istituzionali, ossia da programmi
di investimento in energie rinnovabili e soprattutto nel settore nucleare.
Se davvero si decidesse per l'ecotassa occorrerebbe dedicare ampie
risorse del bilancio Cee (rispetto all'1,5 per cento appena di oggi)
alla ricerca energetica e ai controlli di sicurezza nucleari. E andrebbero
conclusi accordi internazionali, altrimenti gli eventuali buoni risultati
ambientali derivanti dagli sforzi europei sarebbero resi vani dall'aumento
di emissioni inquinanti in altre parti del pianeta.
In media, ogni consumatore sarà gravato di una maggiore spesa
di 110 Ecu. Il carico fiscale per una famiglia media europea corrisponderà
a circa mezzo milione di lire l'anno, un importo paragonabile a quello
di una "normale'' stangata di bilancio italiano, che rischia
di passare senza sostanziali opposizioni. Dal punto di vista dei produttori,
l'ecotassa penalizzerà la posizione competitiva delle imprese
che esportano nei mercati esterni alla Comunità; all'interno
dello stesso mercato europeo, colpirà maggiormente i Paesi,
come l'Italia, più dipendenti dalle fonti fossili, rispetto
a quelli che hanno sviluppato il nucleare.
Non vogliamo far sorgere equivoci: anche noi riteniamo che l'ambiente
vada salvaguardato. Le soluzioni semplicistiche, come l'introduzione
di un'imposta di questo tipo, si limitano però a sottrarre
risorse e libertà di scelta ai cittadini, lasciando la questione
ambientale fatalmente e perpetuamente irrisolta.