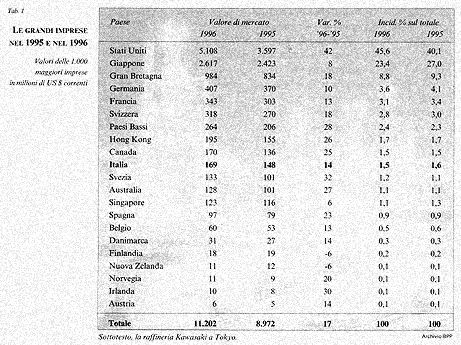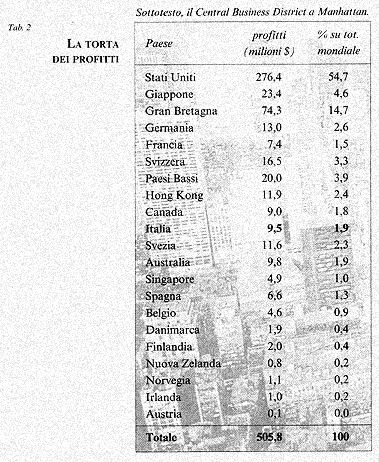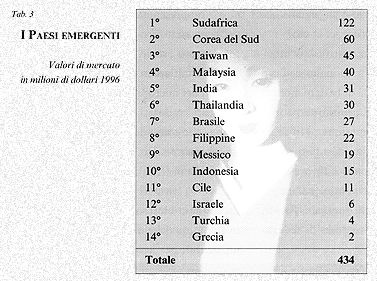Nome:
Jeffrey Vinik. Età: 37 anni. Professione (fino a poco più
di un anno fa): responsabile del Magellan Fund, il gioiello della Fidelity
Funds, l'impresa familiare del Massachusetts numero uno al mondo nel
campo del mutual funds con ben 400 miliardi di dollari di patrimonio
amministrato, pari a un terzo del debito pubblico italiano. All'interno
della Fidelity, il Magellan da solo gestisce, impiegandoli soprattutto
in azioni, 56 miliardi di dollari; le sue quote figurano nei patrimoni
familiari di 4,5 milioni di americani.
Dal '92 al '95, Vinik è riuscito in un'impresa quasi incredibile:
mentre i fondi di grandi dimensioni tendono a risultati prossimi alla
media degli indici di Borsa, il Magellan ottiene incrementi annui superiori
di 7,5 punti all'indice più diffuso di Wall Street, lo Standard
& Poor's 500. Chi ha investito nel Magellan in questo periodo ha
realizzato aumenti patrimoniali del 16% medio annuo. Un risultato eccezionale,
che ha fatto delle strategie borsistiche di Vinik l'oggetto di studio
da parte di concorrenti e ammiratori.
Poi, la caduta: Vinik, convinto sostenitore delle possibilità
di crescita del settore hitech, cambia cavallo. Pensa che si sia toccato
il massimo e si ritira dal comparto, puntando sul reddito fisso. Il
mercato obbligazionario, però, segna il passo, mentre le nuove
prospettive di Internet trascinano i titoli elettronici ad altezze vertiginose.
Risultato? Da capoclassifica, Magellan precipita all'812° posto
su un totale di 820 fondi. Vinik è costretto a dimettersi. La
sua è una parabola esemplare che consente cinque considerazioni
importanti.
1) Le trasformazioni del mercato. Lo sviluppo parallelo dei mutual funds
e delle tecnologie dell'informazione hanno fatto dei mercati finanziari
un "gioco" totalmente nuovo rispetto agli anni '80. A fine
'95, per ogni lira investita in azioni dai mutual funds se ne contavano
due investite in obbligazioni. Ora è vero l'opposto: la facilità
di raccolta di capitale di rischio sta favorendo la nascita di piccole
e medie imprese, fa esplodere i collocamenti in Borsa, favorisce il
rilancio dell'imprenditoria, ma anche la sua vulnerabilità in
caso di risultati non favorevoli, come mostra proprio la parabola professionale
di Vinik.
2) L'eclissi delle banche. E' il noto fenomeno della disintermediazione,
l'altra faccia dei collocamenti diretti in Borsa delle piccole imprese,
in alternativa, appunto, alla richiesta di finanziamenti o di consulenze
finanziarie bancarie. In Borsa, le imprese devono confrontarsi con i
programmi di investimento dei fondi e sempre più il gestore prende
il posto del banchiere. Il fenomeno acquisterà dimensioni ancora
maggiori se, come pare, il sistema pensionistico americano sarà
autorizzato a destinare almeno una parte dei propri investimenti al
settore privato.
Nel '96, poi, la Sec (la Consob americana) ha dato via libera all'offerta
diretta di azioni al pubblico addirittura senza passare attraverso la
Borsa. Il primo caso, coronato da successo, è stato quello di
un pastificio del Massachusetts che ha collocato le proprie azioni stampando
la pubblicità sui pacchi della propria pasta. Nel maggio partì
poi la prima offerta in titoli tramite Internet.
3) La "rivolta" degli azionisti. I mutual funds, ma anche
altri azionisti, si rendono sempre più conto del loro potere.
Lo si vede dal caso Vinik: chi non realizza i risultati sperati, va
a casa. Da occasioni celebrative, le assemblee societarie diventano
campi di battaglia. Da questa crescente, intollerante pressione del
mercato per risultati a breve deriva, in definitiva, la tendenza delle
imprese alle massicce riduzioni di forza-lavoro di questi anni.
4) L'importanza della trasparenza. Dal maggio '96 tutte le società
quotate degli Usa devono fornire in forma elettronica tutte le informazioni
e i documenti richiesti per legge. Questo immenso materiale è
disponibile a tutti nel sito Internet della Sec (http://www/sec.gov).
Alla trasparenza delle società deve far riscontro la trasparenza
degli investitori. Da settembre, la Sec ha imposto la pubblicazione
di un grafico con i rischi di ogni singolo fondo e il confronto con
i rendimenti complessivi del mercato, oltre a un'indicazione che spieghi
all'inizio dello stesso prospetto "che cosa potrebbe non funzionare
in quello specifico fondo".
5) I pericoli di un crollo. La salvaguardia dalla eventualità
di un crollo sta nel fatto che, in un mercato così diffuso e
aperto, in cui non vi è alcuna possibilità di manipolare
le cifre al momento del controllo, non vi sono più mostri sacri.
Nessun grande operatore, neppure Vinik, ha sufficienti poteri di manipolazione
e di previsione. Questo dovrebbe aumentare le possibilità di
tanti crolli parziali relativamente piccoli e salvaguardare invece il
mercato da un collasso generale. Di fatto, le 'reazioni del mercato
appaiono nuove, ancora tutte da studiare, e c'è il sospetto che
i tradizionali strumenti della politica monetaria - e persino la misura
della massa monetaria - debbano essere rivisti.
Nome: Leo Kirch. Età: 71 anni con diabete. Professione: proprietario
di un gruppo privato di mezzi di comunicazione tra i più grandi
e i meno visibili (nel senso della trasparenza) del Vecchio Continente.
Da fine luglio '96 una sua società, la DF-Uno, prima tv digitale
tedesca, diventa uno strumento per far entrare nelle case fino a 54
canali televisivi e radiofonici con le versioni europee di programmi
americani e una payper-view cinematografica alimentata dai diritti esclusivi
per l'Europa che questo signore bavarese si è assicurato su circa
15.000 titoli di film americani.
L'introduzione della tv digitale in Europa, che sembrava dover dipendere
dalle scelte congiunte dei monopoli pubblici France Télécom
e Deutsche Telekom e, per quanto riguarda la pay-tv, dalla francese
Canal Plus e dalla tedesca Bertelsmann, con garanzia del primato francese
in Francia e tedesco in Germania, ne esce rivoluzionata.
Kirch rappresenta la quintessenza di una nuova supremazia tedesca in
Europa. Ha costruito in silenzio, pezzo dopo pezzo, nel giro di 10 anni,
un impero audiovisivo mentre i concorrenti europei di analoghe dimensioni
(o più forti di lui, come la Rai di una decina di anni fa) si
dilaniavano in scontri periferici di squisita natura politica.
La "linea Maginot" dell'ufficialità franco-tedesca
non ha retto al blitz di aggiramento di Kirch. Questi si è improvvisamente
alleato con Rupert Murdoch, il media mogul anglo-australiano dotato
di una visione totalmente planetaria, per cui l'Europa non è
che un pezzo nel quadro mondiale. E' quasi simbolico che l'alleanza
tra la BSkyB di Murdoch e la DF-Uno di Kirch sia stata firmata nello
stesso giorno in cui in Italia i presidenti di Senato e Camera raggiungevano
l'intesa su un altro punto, di rilevanza quasi esclusivamente politica:
la composizione di un ennesimo Consiglio di amministrazione Rai. L'episodio
potrebbe rivelarsi come la più importante evoluzione del capitalismo
europeo. L'impresa di Kirch riflette molto chiaramente continuità
e rinnovamento nel "modello renano" del capitalismo. Dal lato
della continuità, va sottolineato il suo accentuato carattere
familiare, insofferente a una lettura quotidiana dei conti e delle strategie
da parte di auditors esterni o di indiscreti gestori di capitali. La
sua avanzata coincide con nuove regole per le emittenze televisive in
Germania, frutto di faticosi compromessi, a base di commissioni d'indagine
e misura dell'audience, tra Stato centrale e governi locali.
Dal lato del rinnovamento, mostra il capitalismo europeo alla ricerca
di nuove occasioni economiche per sfuggire al clima di recessione, impegnato
nella costruzione di nuovi equilibri dopo la ritirata degli Stati nazionali
dalla gestione dell'economia, teso a mettere a punto nuove regole comuni
per far funzionare i mercati del XXI secolo. Questo rinnovamento presenta
tre tendenze forti.
1) RISTRUTTURAZIONI EUROPEE (E FRAGILITA' ITALIANA)
La prima tendenza è strettamente legata alla congiuntura economica
e genera una corrente di fusioni ben diverse da quelle degli anni
Ottanta. In una situazione di crisi, con la spesa pubblica in ritirata
e i consumi delle famiglie in rallentamento, due terzi dei comparti
industriali presentano, negli ultimi anni, tassi di crescita nettamente
inferiori a quelli del Pil.
Di qui la necessità di nuove ristrutturazioni ed economie di
scala, con fusioni come quelle tra le società farmaceutiche
svizzere Ciba e Sandoz, o, nel settore degli additivi, tra Exxon e
Shell.
Si tratta di una risposta fisiologica ad una clientela sempre più
mobile e a un mondo finanziario che riconosce un premio a chi può
vantare dimensioni, distribuzione geografica e gamma di prodotti più
ampia. Non stupisce perciò che in una recente inchiesta della
società di revisione Price Waterhouse, relativa a 500 grandi
imprese europee, il 45% si sia detto disposto a compiere almeno un'acquisizione.
Si noti per inciso che, tra le imprese italiane intervistate, la quota
è appena del 26%.
E' un indice sia della fragilità finanziaria del mondo imprenditoriale
italiano, sia soprattutto dell'incertezza strategica seguita alla
grande "vacanza" della svalutazione competitiva. E va anche
notato quanto sia difficile avviare una politica del genere senza
un assetto adeguato, con l'opportuna flessibilità del management.
2) LA RIVOLUZIONE DELL'EURO (E LA DEBOLEZZA DI MILANO)
Il ruolo si gioca sullo sfondo del movimento verso la moneta unica
che modificherà in maniera irreversibile la finanza europea.
Scompariranno i contratti nelle valute nazionali, i futures del tipo
lira/marco o marco/franco. I prodotti finanziari tenderanno alla standardizzazione,
da Amburgo a Palermo saranno denominati nella stessa valuta con le
stesse opportunità. Al mercato parigino del Matif i contratti
a termine sul Pibor, il tasso interbancario francese, verranno espressi
in Euro a partire dalla scadenza del marzo '99 e nella stessa direzione
si sta muovendo il londinese Liffe.
Purtroppo, torniamo a sottolineare che in questo quadro Milano sembra
destinata a un ruolo periferico.
3) LE "NUOVE" PRIVATIZZAZIONI
Secondo la società di consulenza americana Morgan Stanley,
nei prossimi dieci anni le dismissioni di società sotto controllo
pubblico raggiungeranno un valore di 200 miliardi di dollari e riguarderanno
soprattutto l'Europa continentale e latina. Saranno però operazioni
diverse dal recente passato, anche perché il processo di globalizzazione
dell'economia ha fatto molti passi avanti. I "noccioli duri"
e le golden shares non potranno non aver minore peso anche perché,
sempre secondo Morgan Stanley, i fondi di investimento e i fondi pensione,
specie quelli americani, dovranno assumersi il peso di almeno il 55-60%
del collocamento e non è realistico pensare che i gestori intendano
limitarsi a far da portatori d'acqua di imprese che non diano sufficienti
garanzie di controllo o impongano troppi vincoli alla loro libertà
di movimento.
Di fronte a questi sviluppi, il dibattito in corso in Italia su chi
debba esercitare il potere nelle imprese appare singolarmente inadeguato,
e questo perché il tema del potere sembra marginale di fronte
ai movimenti in atto. In altri termini, non sembra esserci una risposta
univoca all'interrogativo tradizionale, denso di implicazioni ideologiche,
su chi debba comandare nelle imprese. Occorre invece un esame di coscienza
dopo le tribolazioni inflitte ai mercati (da vicende come SuperGemina
o Cir-Olivetti) e agli azionisti (dalla carenza di controlli in Gemina);
o da patti di sindacato, come quello di Falck, più impenetrabili
e costrittivi di un carcere di massima sicurezza.
L'età delle fusioni e privatizzazioni offre grandi opportunità
per le riforme vere, quelle sul campo, e non a tavolino: allargare
il mercato, organizzare un circuito efficiente dei capitali con garanzie
effettive per i risparmiatori; creare nuove figure di amministratori
indipendenti con effettive possibilità di controllo. L'agenda
è ricca e poco importa se la sfoglierà il manager di
una public company, il supermanager designato da un nucleo duro o
un rampollo di antica nobiltà industriale. L'importante è
che qualcuno cominci a sfogliarla davvero.
Un sistema economico non deve essere misurato solo in base a dati
quantitativi, ma anche qualitativi. Perché abbia peso, infatti,
non è sempre necessario, e neppure sufficiente, che sia di
grandi dimensioni; occorre, invece, che sia collocato nei punti rilevanti
dell'economia mondiale, che chi è sul ponte di comando possa
prendere decisioni importanti, decisioni che spostano, determinano,
condizionano quelle di altri.
Per costruire una "mappa" che dia un conto autentico della
forza delle varie componenti del capitalismo contemporaneo occorre
fare riferimento a uno degli aspetti più caratteristici del
sistema attuale, cioè all'espandersi e all'articolarsi dei
mercati azionari. Su di essi, infatti, questa capacità di decisione
assume un valore economico e può essere misurata. Si può
considerare, per quanto in maniera sommaria e imprecisa, che il valore
di mercato rifletta, in una società di mercato, l'importanza
economica e che questa dia un posto rilevante al potere di decisione.
E' questa la base dell'esercizio che proponiamo, effettuato su dati
- da noi rielaborati - pubblicati dalla rivista americana Business
Week.
La rivista ha messo a punto un elenco delle 1.000 società quotate
di maggior valore, prendendo come punto di riferimento le quotazioni
sulle Borse valori dei vari Paesi, del 31 maggio '96; ha convertito
questi valori in dollari, al cambio di quel giorno (le Borse considerate
escludono i c.d. Paesi emergenti, per i quali è stato redatto
un elenco a parte). Simili classifiche vengono normalmente usate per
valutare la posizione di singole società. Hanno però
anche un notevole significato geo-economico: proprio perché
basate su prezzi di mercato, implicitamente contengono le valutazioni
espresse dagli investitori tanto sulle singole società quanto
sull'andamento della Borsa (e quindi dell'economia) di un Paese. Consentono
pertanto di valutare indirettamente l'importanza di singoli centri
imprenditoriali e di specifici Paesi, la loro capacità di aggregare
capitali, il loro peso decisionale.
Naturalmente il numero di 1.000 società scelto è convenzionale
(il Financial Times compila una classifica analoga basata su 500 imprese
soltanto), del resto tutte le carte geografiche sono rappresentazioni
convenzionali e in qualche modo distorte. Si può peraltro correttamente
pensare che sulla "mappa del potere" del capitalismo moderno
conti di più un Paese con una decina di grandi imprese, capaci
di elaborare strategie, che non migliaia o decine di migliaia di imprese
minori che complessivamente arrivano allo stesso fatturato.
Sommando i dati per singolo Paese, si arriva alla determinazione del
"peso" dei vari Paesi nel capitalismo di mercato (Tab. 1).
Alla data prescelta, il valore di mercato di queste 1.000 imprese
era pari a oltre 11.000 miliardi di dollari, circa 17 milioni di miliardi
di lire, (per confronto, il Pil italiano si avvicina ai due milioni
di miliardi di lire, quello mondiale intorno ai 25-28 milioni di miliardi).
I profitti erano pari a circa 750 mila miliardi: più di quanto
incassa in un anno lo Stato italiano.
In questo quadro, il valore di mercato delle grandi imprese Usa risulta
pari a circa il 45%, ben di più del peso di quell'economia
sul totale della produzione mondiale (un po' meno di un quarto del
Pil del pianeta ha origine negli Usa). Questa differenza può
essere considerata come una misura, sia pure rozza e grossolana, del
"potere" americano. Questo potere risulta aumentato sensibilmente
rispetto all'anno precedente: l'effetto congiunto dell'espansione
produttiva, dell'andamento delle Borse negli Stati Uniti e del cambio
del dollaro hanno fatto salire di ben cinque punti il peso delle grandi
imprese americane nel capitalismo mondiale. Cinque punti largamente
guadagnati a spese del Giappone, passato dal 27 al 23,4%, un valore
sostanzialmente in linea con l'importanza della produzione nipponica
sul totale mondiale. Questo "spostamento dei pesi" all'interno
del sistema capitalista corrisponde del resto a una percezione comune
della maggiore vitalità delle imprese americane nel corso degli
ultimi anni, con i loro grandi progressi nelle applicazioni elettriche
e nelle telecomunicazioni.
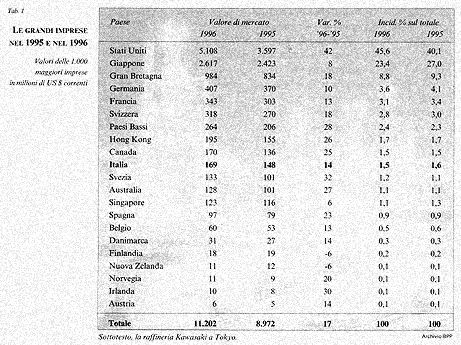
Fin qui, la gerarchia dei Paesi in base al potere espresso dalle Borse
rispetta il loro ordine di importanza macroeconomica. Se però
si scende nella classifica, le cose cambiano radicalmente. Al terzo
posto troviamo infatti la Gran Bretagna, con un peso più che
doppio rispetto alla Germania e pari a quasi tre volte quello della
Francia, i due Paesi che la seguono direttamente, mentre invece la
precedono nella graduatoria della produzione. Che cosa significa?
Che la capacità dei mercati inglesi di aggregare denaro attorno
ad alcuni grandi progetti economici è ben maggiore di quella
dei mercati francesi e tedeschi. E' questo un aspetto non trascurabile
di quell'impalpabile, ma molto reale potere inglese nel mondo. E'
in ogni caso significativo che il peso di questi tre Paesi sia leggermente
diminuito nel giro di un anno, passando nel complesso dal 16,8 al
15,5%.
Scendendo ulteriormente, la classifica in base al potere del mercato
si discosta sempre più marcatamente da quella della rilevanza
produttiva: dopo la Francia infatti troviamo Svizzera, Paesi Bassi
e Hong Kong, ossia tre nazioni piccole ma molto "potenti"
in quanto sede di società che contano, come Roche, Nestlé
e Sandoz (prime tre società elvetiche per valore di mercato),
oppure. Royal Dutch, ING e Unilever (prime tre società olandesi).
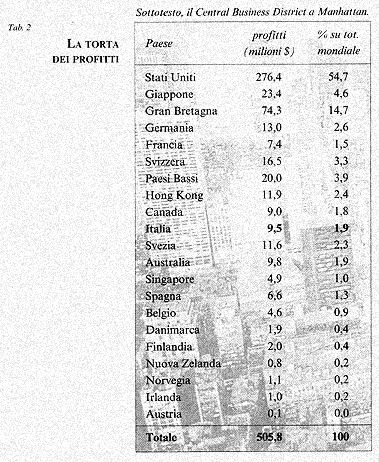
L'Italia viene solo al decimo posto (Tab. 2), mentre è al quinto-sesto
posto in quanto a peso produttivo. E il valore di mercato delle sue
grandi imprese è pari appena all'1,5% del totale dei grandi
centri mondiali: è un altro segno di quella debolezza della
piazza di Milano cui abbiamo già accennato. Si verifica così,
per vie insolite, quello che ha detto di recente un presidente del
Consiglio: che l'Italia conta pochissimo, che il suo peso in termini
decisionali è nettamente inferiore alla sua importanza economica.
Va notato che, senza la privatizzazione dell'Eni e lo "spacchettamento"
dell'ex Sip (divisa, con grande vantaggio di mercato, in Telecom Italia
e Tim, che si occupa di telefoni mobili), il risultato sarebbe stato
ancora peggiore.
Il valore di mercato tiene conto, fra l'altro, dei profitti realizzati
e distribuiti dalle società (al netto di proventi eccezionali),
e qui il predominio americano è ancora maggiore. Il 54,7% dei
profitti complessivi delle 1.000 principali società viene realizzato
da imprese Usa; la percentuale è pertanto maggiore della loro
incidenza sul valore complessivo di mercato. Che cosa significa?
Forse che le imprese americane sono gestite meglio, forse che sono
orientate a rendimenti di breve periodo, più sensibili alle
esigenze degli azionisti. Uno squilibrio analogo e nella medesima
direzione riguarda tutto il mondo anglosassone (canadesi, australiani
e neozelandesi presentano quote sul totale dei profitti superiori
alle rispettive quote sul totale del valore). La stessa cosa vale,
in misura minore, per le imprese olandesi, spagnole, svizzere e di
Hong Kong.
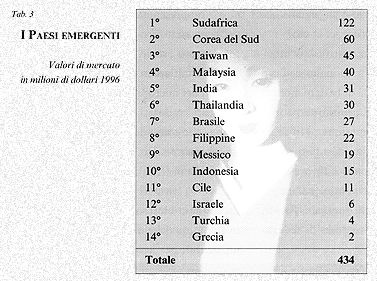
Per contro, il Giappone e il grosso dell'Europa continentale si contraddistinguono
per un'incidenza sui profitti totali inferiore all'incidenza sul valore
di mercato. Così il Giappone, le cui imprese pesano per il
23,4% sul valore di mercato complessivo del sistema, pesano appena
per il 4,6% sul totale dei profitti distribuiti. Le società
nipponiche sono arcinote per la loro tendenza al reinvestimento interno,
così come lo sono per un controllo societario molto solido
che le rende non scalabili. La stessa cosa vale per la Germania e
la Francia, le quali congiuntamente totalizzano appena il 4,1% dei
profitti complessivi contro il 6,7% del valore di mercato e quasi
il 15% del prodotto mondiale lordo.
Fin qui non abbiamo tenuto conto dei c.d. Paesi emergenti e abbiamo
considerato che Hong Kong e Singapore siano integrati nel grande circuito
capitalista. Un circuito più piccolo ma significativo comprende
invece una quindicina di Paesi le cui Borse (meno sviluppate di quelle
dei Paesi maggiori) sono state alimentate dalle recenti privatizzazioni.
Business Week li registra in un elenco separato in cui la prima impresa
- una società elettrica coreana - si collocherebbe al 52°
posto dell'elenco generale. Complessivamente, il valore di mercato
delle loro imprese supera i 400 milioni di dollari, ma va detto che
la parte del leone la fanno le imprese sudafricane che pesano per
circa un terzo.
Il Sudafrica, com'è noto, è largamente anomalo, a cavallo
tra capitalismo tradizionale (dal quale ha ereditato una struttura
borsistica di tutto rispetto) e capitalismo emergente; il valore di
mercato delle sue imprese (che comprendono colossi minerari come Anglo
America e De Beers) supera i 120 milioni di dollari. A grande distanza
seguono Corea, Taiwan e Malaysia: questa piccola "tigre",
che comincia a mostrare le unghie di imprese molto dinamiche, ha mercati
azionari con imprese che presentano complessivamente valori superiori
a quelli indiani. Molto piccolo è il peso dell'America Latina
con Messico, Cile e Brasile; la Turchia è l'unico Paese dell'area
medio-orientale.
Il valore di mercato delle grandi imprese dei tre blocchi avanzati
- Nordamerica, Europa e Giappone - si avvicina al 95% del totale.
Su questo, l'Italia è un Paese mingherlino, le cui grandi imprese
hanno un valore di mercato pari a poco più di metà della
Svizzera. I Paesi, consolidati ed emergenti, dell'Oriente cominciano
ad avere una presenza apprezzabile, pari a circa il 6% del valore.
Tutti gli altri hanno solo una presenza di bandiera. Il vecchio "Terzo
Mondo", comincia, però, a comparire nelle statistiche
del capitalismo: è un segnale importante del quale occorre
tener conto.
Poveri Stati! Le loro prerogative "sovrane" sono, oltre
a quella del monopolio dell'uso della forza armata, quelle di battere
moneta e di esigere imposte sul proprio territorio. Col Trattato di
Maastricht, gli Stati dell'Unione Europea sono destinati a perdere
la sovranità monetaria a favore di un ente che opererà
a livello continentale; e vedono in pericolo anche la sovranità
fiscale, in quanto la diffusa domanda di federalismo è tesa
a interpretare in senso molto lato il potere delle regioni di sostituirsi
all'autorità centrale. In questo mondo scosso dall'innovazione
tecnologica, però, le cose non stanno mai ferme; e mentre tutti
dibattono di moneta europea e di imposte regionali, proprio la tecnologia
sta cominciando a mettere in mano ai cittadini d'Europa (e in realtà
del pianeta) i mezzi sia per sottrarsi al monopolio della moneta sia
per depistare gli obblighi fiscali.
Cominciamo dalla moneta. Da tempo esiste quella che viene definita
"moneta elettronica", rappresentata dalle carte di credito
e dal bancomat, le cui prestazioni divengono sempre più estese,
a mano a mano che è possibile infilare in questi pezzi di carta
plastificati dei microprocessori sempre più "intelligenti"
e dotati di sempre maggior memoria, che consentono sempre più
funzioni (le c.d. smart-cards, che cominciano a circolare anche in
Italia).
La moneta elettronica è di difficile controllo: in qualche
modo, chi emette "carte" utilizzabili per acquistare a credito,
comprese per esempio alcune catene di supermercati, emette moneta
in maniera indipendente dall'autorità monetaria. Per questo,
da tempo i banchieri centrali la tengono sotto osservazione, pur ritenendola
ancora troppo marginale per risultare pericolosa.
Il vero pericolo è che la tradizionale moneta elettronica si
trasformi o si colleghi al cybercash, la moneta virtuale che può
nascere da emittenti disseminati su Internet, via via che questa rete
di collegamento elettronico si diffonde a singoli individui e famiglie
e viene utilizzata per proporre merci, trasformandosi in un mercato.
Con Internet, insomma, si può fare shopping direttamente da
casa; e, ciò che è ancor peggio dal punto di vista dell'autorità
monetaria, il monitor del computer può trasformarsi nello sportello
di una banca.
Gli esempi di questo nuovo sviluppo sono ancora a livello largamente
teorico, ma la velocità del cambiamento è tale che potrebbe
diventare realtà nel giro di mesi. Si supponga, ad esempio,
che una compagnia telefonica si faccia pagare le bollette via computer
e utilizzi questi "accrediti" per pagare a sua volta fornitori;
oppure che emetta la propria moneta elettronica e che questa venga
utilizzata da terzi dietro la garanzia della società.
L'Istituto monetario europeo (Ime) di Francoforte - l'embrione della
futura autorità monetaria dell'Ue - ha preso la cosa molto
seriamente, in quanto si può usare Internet per raccogliere
e prestare fondi, per accreditare interessi, ecc.; e per questo ha
stilato un regolamento che vieta l'attività di raccolta e prestito
tramite Internet. Succede però per l'attività bancaria
qualcosa di analogo alla pornografia: il controllo si rivela arduo
se non impossibile, e una recentissima sentenza americana ha assolto
i diffusori di Internet (i c.d. providers) dall'obbligo di controllare
il contenuto del materiale accessibile o diffuso attraverso i loro
cavi e computer.
Si pensi a un'altra prospettiva: è ragionevole supporre che,
entro il 2001, pressoché tutti gli azionisti delle società
quotate negli Usa avranno un computer collegato a Internet. Si tratterà
magari di un network computer, ossia di un modello progettato dalla
Oracle proprio per allargare a basso costo (500 dollari) la platea
degli utenti della rete. A quel punto, non solo gli intermediari finanziari
correranno il rischio di essere abbandonati da risparmiatori-investitori
"fai da te", ma la raccolta di capitali, così come
gli investimenti finanziari, non conosceranno alcun tipo di confine
fisico. A quale giurisdizione bisognerà assogettare i relativi
proventi?
Si tratta, ovviamente, di un caso dalla risoluzione assai difficile
e, quand'anche si stabilissero accordi interstatali, chi mai li potrebbe
far rispettare? Già oggi alcune banche off shore allettano
i "navigatori" di Internet con proposte di on-Iine banking,
offrendo a tutti l'opportunità di domiciliare il proprio gruzzolo
in un paradiso fiscale.
Stanno per aprirsi così, anche ad operatori che dispongono
di importi modesti, opportunità analoghe a quelle fino a ieri
riservate a pochissimi, spesso anonimi e malvisti, "gnomi"
della finanza. Non sono però le sole imposte sui redditi da
capitale ad essere in pericolo per l'erario. Alla defezione fiscale
può accompagnarsi la competizione tra Stati per l'esazione
delle imposte sui consumi. Già oggi alcuni providers di Internet
sono in visibile imbarazzo per le transazioni che dovrebbero essere
soggette a imposte sui consumi, come l'Iva in Europa o la Sales Tax
negli Stati Uniti (diversa da Stato a Stato all'interno dell'Unione).
Si pensi al caso di un soggetto che:
risiede nel Paese A;
- si abbona - cosa del tutto lecita - ai servizi Internet offerti
da una società con sede nel Paese B;
- grazie a quei servizi, approda a una delle c.d. malls (siti Internet
in cui vengono effettuate offerte di vendita) e qui aderisce all'offerta
di vendita di un'impresa domiciliata in un Paese C;
- quest'impresa gli invia la merce da un Paese D;
- la stessa impresa gli chiede di pagare su un conto corrente bancario
del Paese E.
A questo punto, chi dovrebbe pagare quali imposte, e a chi? E non
si creda che il caso presentato sia particolarmente complesso. Situazioni
di questo tipo cominciano a presentarsi nei normali affari di tutti
i giorni. La vicenda si trasformerebbe poi da complicata in insolubile
se l'oggetto della transazione fosse un servizio (ad esempio, informazioni
mandate dall'impresa al cliente elettronico) che transita sulla rete
in forma digitale, rendendo difficile l'identificazione del suo valore
e la stessa effettuazione della transazione.
Ci si rende facilmente conto che a rischio, in questo caso, sarebbero
le stesse imposte sul reddito, normalmente prelevate in base alla
residenza del produttore. Al limite, nel caso di un servizio del tutto
smaterializzato, il pagamento dell'imposta sul reddito percepito in
un Paese X ma pagato su un conto in un Paese Y diventa del tutto dipendente
dalla buona volontà del percettore.
Si giunge così ad una conclusione importante: chi produce servizi,
consulenze, know-how, avrà sempre maggiore libertà di
scegliere la propria residenza ufficiale in qualsiasi Paese del mondo.
E uno degli elementi cruciali della scelta sarà il sistema
fiscale in vigore in quel Paese.
Siamo certi così di avere offerto a quanti hanno a cuore il
problema della tassazione qualche buon motivo di meditazione e qualche
argomento in più per alleggerire e semplificare le pretese
fiscali soprattutto dello Stato italiano. La diffusione della telematica
renderà sempre più difficile la vita ai ministri delle
Finanze. E a chi contasse sulla speranza che il cronico ingorgo di
Internet finisca per frenarne la crescita, suggeriamo di non farsi
troppe illusioni: una società americana, la CAI Wireless System
Inc., ha già brevettato un sistema di diffusione "senza
fili" otto volte più veloce della rete telefonica, e con
le tv via cavo stanno per arrivare servizi Internet diffusi via cable
modems che assicureranno, con un'attrezzatura del valore di 300 dollari,
una velocità di trasmissione cento volte superiore all'attuale.
La tecnologia sta preparando un mondo dai confini fiscali sfumati,
in cui il monopolio della moneta sarà tutt'altro che assicurato,
in cui governi e parlamenti vedranno sensibilmente ridotta la propria
sovranità, almeno in certe materie, in cui magari i cittadini
saranno un po' più liberi. In epoche di riforme istituzionali,
sarebbe opportuno tenerne conto per evitare di disegnare vestiti,
non solo fiscali ma anche relativi alla qualifica di cittadino, i
quali poi risulterebbero così stretti da essere impossibili
da indossare.
|