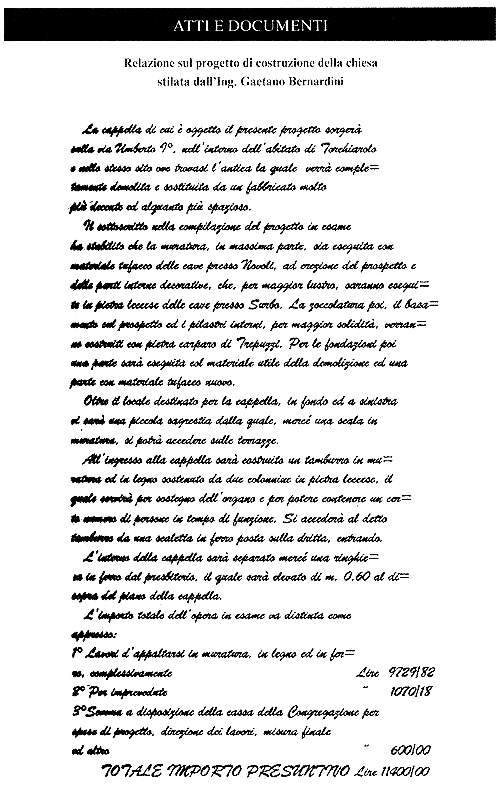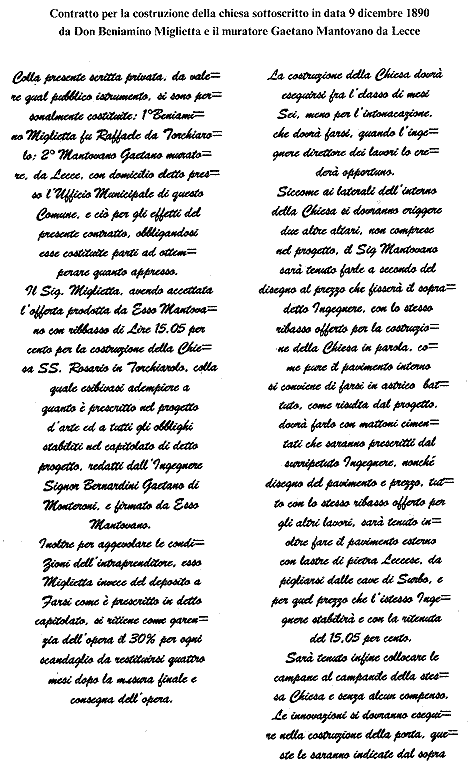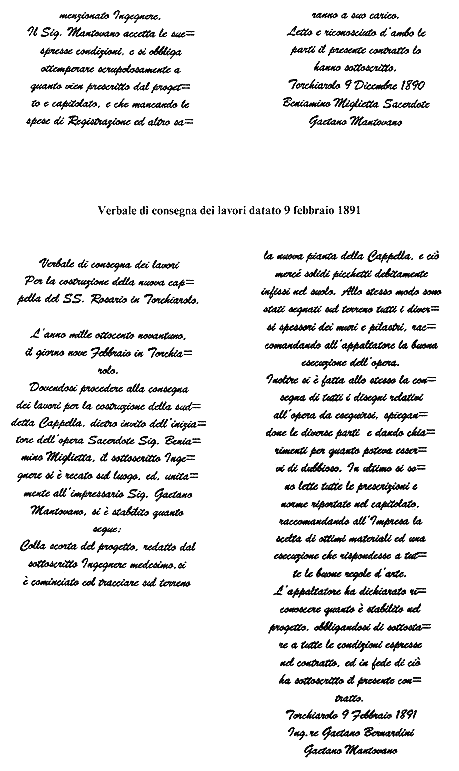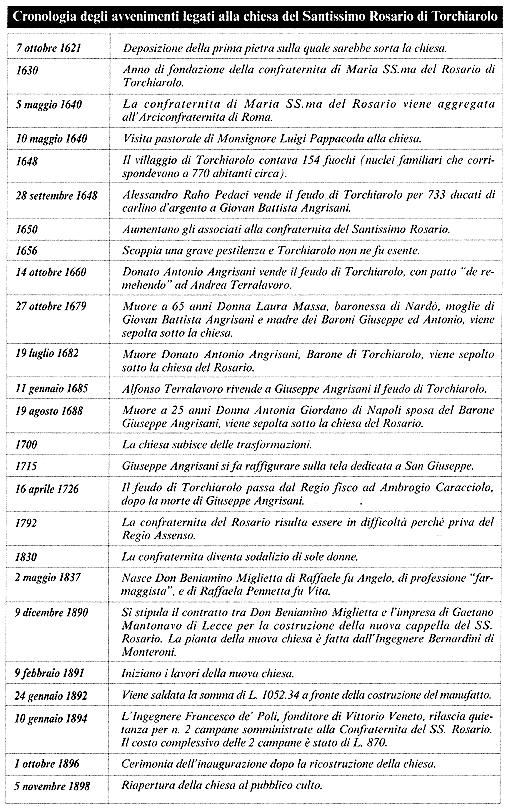Riscoprendo
Raffaele Gentile
Ho davanti a me un grosso volume rilegato, di pagg. 255, uscito presso
la Tipografia di Matino l'anno 1973, a cura di Aldo Bello per la Banca
Agricola Popolare di Matino e Lecce. Titolo: Raffaele Gentile (1830-1904).
E' una nient'affatto minore scoperta bibliografica (sono e rimango
"felicemente insabbiato" nel Salento, per quest'inattesi
incontri culturali che, di tanto in tanto, mi riempiono di gioia):
interessa eccezionalmente l'esemplare vita del Personaggio descritto
e la rara capacità - del suo biografo - di far cultura nei
più disparati campi, tramite una limpida pur se concettosa
divulgazione, la quale, in certi momenti di particolare impegno, assurge
al ruolo di prosa letteraria, elegante quanto razionale, senza fronzoli.
Da anni, leggo con gusto e profitto, senza confronti, tutto quello
che scrive Aldo Bello, malignamente domandandomi se questo ritroso
giornalista abbia (N.d.A. Gli scrissi in redazione, senza ottenere
risposta) sempre posseduto una simile chiarezza espositiva oppure
se l'abbia affinata nel tempo, non foss'altro che per aggiungere altri
pregi ad Apulia, secondo me la più bella, in tutti i sensi,
pubblicazione di varia umanità che (troppo umilmente detta
"Rassegna Trimestrale della Banca Popolare Pugliese") vede
la luce nell'intera Italia centro-meridionale e - vorrei aggiungere!
- ben oltre...
No; Aldo Bello scrive così da sempre ed è appunto questa
breve rilettura di questo dotto profilo di Raffaele Gentile, che dovrebbe
fornirmi elementi idonei ad una doppia conoscenza e dell'illustrato
e dell'illustrante. Basti un passo, che riporto da pag. 10, a farci
subito accertare che grazie al Dio delle Lettere ritmo e gradevolezza
ottocenteschi sussistono e resistono.
Sussistono e resistono, con in più un nostalgico rispetto (oggi
insolito per un secolo, caduto vittima dei nuovi iconoclasti), che
ci sembra orecchiabile nell'elegante prosa di Aldo Bello:
"Raffaele Gentile, come non poche altre figure di uomini di scienza
italiani, era in tutto e per tutto figlio della propria epoca. Fu
modellato dal tempo in cui visse e a sua volta, nella misura in cui
poté esprimere e realizzare studi, indagini e ricerche applicate,
contribuì a dare a quella splendida età, che tra il
1850 e il 1900 gettò le basi della scienza e della cultura
moderne, un'impronta irripetibile inserendosi a buon diritto nel novero
di quei savii, uomini di studio e di pensiero, che Croce additò
al mondo come coloro che, nel profondo Sud, compirono quanto di bene
si fece in questo paese, all'anima di questo paese, quanto gli conferì
decoro e nobiltà, quanto gli preparò e dischiuse un
migliore avvenire...".
Raffaele Gentile, nato a Matino il 26 febbraio 1830, ingegnere, astronomo,
cosmografo e letterato di vaglia. Fu Giambattista del Tufo ad iniziarlo
alla cultura umanistica e Ferdinando II ne ebbe alta considerazione.
Insegnò per alcuni anni Scienze Matematiche e Fisiche presso
l'Abbazia di Montecassino, dove aveva preso gli ordini semplici, con
il nome di Don Pietro Archimede.
Rientrato nella sua terra, fu per vari trienni sindaco di Matino su
nomina regia e vi morì, rimpiantissimo, il 17 marzo 1904.
In una semplice monografia potrebbe esser bastevole conoscere che
i momenti del suo maggiore impegno di ricercatore furono quelli degli
studi sui metodi di misurazione delle botti e quelli sui metodi di
misurazione delle volte; due attività scientifiche non certamente
comuni, la cui importanza non supposta emergerà più
oltre.
Ma non è qui che si sofferma il biografo. Se voglio, così
come mi proposi, non per motivi accattivanti nei confronti di quest'ultimo,
bensì per render giustizia ad una maniera di studiare l'Uomo,
della quale provo anch'io nostalgia (questo il motivo della presente
relazione binata). Mi piacerebbe, infatti, illustrare in una volta
sola, parallelamente, il Gentile e il Bello; ma occorre ch'io abbondi
in citazioni sintomatiche e indicative, sia per l'uno che per l'altro.
Come questa:
"Al pensiero filosofico di Rosmini era subentrato quello di Ardigò.
Si costruiva l'Unità nazionale e dalle ceneri della Restaurazione
spuntava un nuovo Paese europeo, che la natura aveva disegnato con
tratto assai preciso, dalla corona alpina al cuore del Mediterraneo.
Ma quanto dei fermenti europei venne recepito? Solo la letteratura
sembrò tenere il passo dei tempi".
Segue una magistrale nota di geografia in situazione, che va da un'agricoltura
"estensiva e sitibonda" alla "morfologia piuttosto
uniforme dell'entroterra", alla "uniformità delle
coste, ora dirupate e compatte, ora basse e paludose", fino al
"trasporto su lunghe distanze ed in condizioni disagevoli"
dell'olio e del vino, prodotti pregiati.
Siamo giunti alla botte, elementare mezzo di contenimento, al cui
studio (per noi distratti, in verità, assai strano e, qualche
volta, addirittura buffo) Raffaele Gentile si dedicò.
Ed ecco Aldo Bello, che, in poche righe, riassume un originale passaggio
storico, assai curioso per chi non conosce certi usi e costumi: "A
colmatura avvenuta, [la botte] costituiva la sintesi della stagione
agraria, l'essenza della fortuna o della sventura climatica, la disponibilità
di un bene che aveva valore di moneta pregiata in corso legale [...].
Quando la botte decadde, per l'economia meridionale e salentina si
chiuse un'epoca".
Bene, in questa rivisitazione di un lavoro dedicato ad un personaggio
"che rifiutò tutti i metodi fino ad allora adottati (in
ispecie il Nuovo Manuale pe' Misuratori delle Botti) s'incrociano
la novità di uno studio, credo, ignorato dai più e la
curiosa arte del presentarcelo così, quasi a farci finalmente
intendere che non ci sono grandi ricerche e piccole ricerche, bensì
un unico atto di scienza rivelatrice.
La maestrìa di Aldo Bello nello spiegare che il matinese Gentile,
nella fondamentale Regola per misurare le botti, Stamperia Vitale,
Napoli 1865, considera questo recipiente protagonista come il complesso
di due segmenti eguali di paraboloide circolare, è semplicemente
meravigliosa.
Meravigliosa per la facilità con la quale un uomo di ariosa
cultura umanistica si muove tanto a suo agio nel bel mezzo d'una materia
rigida a base di precise regole aritmetiche, in queste prime tesi
dell'opera presa in esame. Niente è incomprensibile e da saltare,
dalla pagina 38 a quella 118, quando l'argomento passa ad analizzare
ogni tipo di volta, con un linguaggio nutrito di archi circolari,
semiellittici, gotici, o della semiovale di Bossut, etc., che sbigottisce
il profano; a mio avviso, più ignorante del non addetto ai
lavori. La terminologia e gli stessi disegni e le stesse tavole vanno
facendosi di più in più ermetici per il lettore "comune".
Eppure, anche qui Aldo Bello non dimentica di regalarci pregevoli
passaggi, ciò nonostante, a dimensione uomo; magari citando
Bonaventura Tecchi:
"...Perché la cosa più singolare di questo mondo
salentino è appunto la luce: sulle case e soprattutto nella
campagna... Quella luce che, come in Sicilia, scandisce le cose, con
chiarezza, ma forse con più grazia...".
E della luce l'arco e la volta sono infatti lo scrigno.
E della noia che affligge il contemporaneo proprio la geometria gentiliana
potrebbe essere guarigione - perché no? - sotto forma di possibili
divertissements trigonometrici.
Perché anche Raffaele Gentile ebbe il dono della chiarezza
espositiva, al pari dello stesso relatore. Basti una delle sue Definizioni,
leggibile senza difficoltà:
"Un solido ha per termine una superficie; due parti contigue
di una superficie, tali cioè che l'una finisce dove l'altra
comincia, hanno per termine comune una linea; due parti contigue d'una
linea hanno per termine comune un punto... Piana è quella superficie
su cui cade tutta una linea retta che ne congiunge due punti dovunque
presi... L'angolo è lo spostamento di una retta la quale sopra
un piano gira intorno ad una estremità; la prima e l'ultima
posizione della retta mobile sono i lati dell'angolo, il punto fisso
è il vertice".
Le Definizioni, continuerebbero, caratterizzate da immediatezze e
concatenamenti inconfutabili. Un vero godimento logico.
Siamo giunti alla Geometria Elementare, che l'autore pone "sotto
la salvaguardia delle Leggi della Badia di Montecassino". Il
nostro Don Pietro Archimede, al pari dei frati benedettini, allarga
la sfera delle proprie cognizioni ad ogni branca dello scibile, convinto
che il sapere è un'arte enciclopedica, applicata alla vita.
Lo testimonia il materiale epistolare tramandatoci dal Gentile, al
quale "le massime autorità religiose del tempo gli concedevano
di leggere e consultare testi, di regola proibiti ad ogni altra persona".
E qui Aldo Bello inserisce, da par suo, due ghiottissime chicche biografiche:
la vicenda della supplica a Pio IX per ottenere, come ottenne, il
prestito di testi che andavano dal Diritto Canonico ai trattati di
Hegel, fino addirittura alle Fêtes et courtijanes de la Grèce
Nouvelle del Casti; nonché la richiesta di proscioglimento
dai voti semplici, rivolta al medesimo Mastai Ferretti nel 1867.
Ad averne lo spazio, sarebbe interessante riprodurre letteralmente,
come nella nostra monografia, ricca di nitidi documenti "fotografati",
il carteggio circa quest'ultima richiesta, diplomaticamente portato
avanti dall'Abate montecassinese, Don Carlo Maria De Vera, cui spettava,
per conto del Pontefice, la concessione del supplice permesso di tornare
allo stato laico.
L'attestato "solutorio" giunse al Gentile, rimasto peraltro
cattolico osservante, il 2 giugno dell'anno seguente.
La serenità studiosa di Matino, oramai, attende il Nostro.
Una vera pace non può essere che libera, quando ci si vuol
dedicare con l'indispensabile equilibrio ad una vita di studio. Mi
sembra che questo possa essere considerato il messaggio esistenziale
di Raffaele Gentile.
C'è un gusto tutto particolare nel "riscoprire" pubblicazioni
datate.
In questo caso, che la necessità del riassumere, forse rende
confuso, ho trovato un doppio motivo di gratitudine culturale; poiché
esiste anche quella. Da un lato, ho letto cose edificanti, che da
tempo non leggevo; dall'altro, ho avuto conferma di quanto la ricerca,
anche intorno ad un presunto minore, sia pedagogicamente opportuna.
La firma ora a me più cara, del direttore di Apulia venuta
fuori dietro la descrizione del silenzioso e poco noto Personaggio
matinese, si imbatte a sorpresa, sul finire dell'opera dal sottoscritto
saccheggiata, in un secondo grande salentino da studiare, meglio e
di più: proprio colui - la chiusura è meravigliosa!
- nel cui castello, io, venuto da molto distante, scelsi di vivere
e studiare. La vera cultura incappa spesso in questi fortuiti incontri.
Cedo la parola, con gratitudine, ad Aldo Bello:
"Un'ultima lettera (è del 1897) proveniente da Roma, Palazzo
Orsini, è rivelatrice di altri interessi di Gentile. Chi la
scrive non ha bisogno di presentazioni: è il massimo esponente
del libero-scambismo italiano, il leccese Antonio De Viti De Marco,
autore di quei Saggi di economia e finanza e di quella Scienza delle
finanze che rappresentarono uno dei massimi momenti del meridionalismo
militante. Si era infatti in un'età in cui il meridionalismo
realizzava le sue tesi più salienti, in una evoluzione storica
che andava sempre più distanziando le regioni italiane e che
avrebbe poi trovato in Salvemini, in Dorso e in Gramsci i più
consapevoli interpreti e depositari di un pensiero politico destinato
a giungere fino a noi come lezione di comportamento, matrice prima
e insostituibile di ogni concreto disegno operativo".
Chiedo scusa per questa lunga citazione; ma, come niente fosse, il
pubblicista da me preso ad esempio procede ad incastro e fa florilegio
di utili storie. Il fatto è che mi commosse leggere in queste
pagine, iniziate con lo studio della botte (non trovo altro modo per
dirlo), pensieri alti come questo, da una lettera di De Viti De Marco
al Gentile;
"...Io non desidero di lasciare la scienza per la politica militante,
la cattedra per la Camera dei Deputati; ammeno che non mi si dica
che io posso essere utile agli altri...".
Insomma, avrei mai pensato d'incontrare il mio storico padrone di
casa (abito nel castello di Casamassella) in queste pagine?
Ancora non sono terminati gli "effetti collaterali" di questa
occasionale lettura, nient'affatto encomiastica come sembrerebbe.
Lettura densa e cangiante. Una lettura, per il sottoscritto, lucchese,
particolarmente generosa di un'ultima sorpresa non solo culturale,
ma anche emotiva; la seguente, che sa di magìa:
"Quando morì, il 17 marzo del 1904, il Sole era nella
costellazione dei Pesci, la stessa in cui cadeva il giorno in cui
Gentile aprì gli occhi alla luce del mondo... Gli uomini grandi
non sono mai soli. Quello stesso giorno, in una stanza lontana, un
musicista sedeva al pianoforte: le cronache dicono che c'era nel cielo
grigio un'immobilità dolente, quando sulla tastiera Giacomo
Puccini scandì le prime note per un inno alla morte, per un
malinconico addio al mondo...".
Insomma, Voi non mi crederete; sotto queste solenni volte salentine,
un coro muto, più che altrove, è improvvisa preghiera...
florio santini
Il Rosario
di Torchiarolo
La storia della chiesa del Santissimo Rosario è legata alle
famiglie nobili e notabili del paese. Queste, nel corso degli anni,
hanno provveduto alla manutenzione ed all'ammodernamento del luogo
di culto, che all'origine era parte integrante di un modesto feudo,
come si evince dalla sua vicinanza al palazzo baronale.
La prima pietra, sulla quale sarebbe sorta la chiesa, fu posta il
7 ottobre 1621 in un angolo della gran piazza (1).
La sua costruzione, che fu portata a termine nel corso di pochi anni,
si deve alla devozione del barone Alessandro Raho Pedacia (2), discendente
di una nobile famiglia di origine alessanese-otrantina.
Alla famiglia Raho-Pedaci il casale di Torchiarolo era pervenuto dopo
il matrimonio di Marco Antonio Raho Pedaci con Vittoria delli Falconi,
la quale, ereditato il feudo come dote di nozze, dopo la morte del
padre (19 agosto 1589) lo lasciò al figlio Alessandro, che
ebbe in sposa Donna Erina Guerini di Lecce (3).
Questi fu sempre attento alla conservazione ed al decoro della chiesa,
che in occasione della visita pastorale di Monsignor Luigi Pappacoda
alla parrocchia, avvenuta il 10 maggio 1640 (4), è così
descritta: "E' ben disposta, muri puliti e bianchi, tetto a canne.
Ha due porte le cui chiavi sono custodite dal Barone Alessandro Pedaci
e dal cappellano. Ha tre sepolture: una per sé, per i figli
e le loro famiglie, la seconda per i suoi servi e le loro famiglie,
la terza per gli altri. Il pavimento è in cemento. Ha tre altari:
l'altare maggiore con un grande quadro della Madonna del Rosario dipinto
su tela, quello a sinistra dedicato a Sant'Antonio di Padova e quello
a destra dedicato a San Vito Martire".
La chiesa, dunque, anche se piccola, era completa e funzionale al
culto mariano dei fedeli e nelle sue sepolture accolse gli appartenenti
alla famiglia Pedaci fino al 1670, quando questa si estinse definitivamente.
Nella prima metà del secolo XVII il villaggio di Torchiarolo
contava 154 "fuochi" (5) pari a circa 770 abitanti. La piccola
comunità, dedita all'estenuante lavoro dei campi, spinta forse
dal bisogno di aggregazione sociale, ma sicuramente da fervidi sentimenti
religiosi diede vita alla confraternita di Maria SS. del Rosario.
Il sodalizio, nato per promuovere una più perfetta vita cristiana,
per incrementare il culto mariano, per esercitare opere di pietà
e di carità, fu aggregato all'Arciconfraternita di Roma con
diploma del 5/V/1640 (6).
Del sodalizio, formato inizialmente da sole donne, incominciarono
a far parte negli anni successivi anche uomini. Intorno al 1650 il
numero degli associati era già notevolmente aumentato, per
cui si avvertì la necessità di eleggere un priore, che
rimaneva in carica un anno e si occupava della gestione amministrativa
e disciplinare; gli aspetti formativi e più specificatamente
religiosi erano affidati, invece, ad un padre spirituale, responsabile
dell'attività della confraternita presso il vescovo dal quale
aveva ricevuto la nomina. Nel 1648, con Regio Assenso del 28 settembre,
Alessandro Raho Pedaci vendette il feudo di Torchiarolo per 733 ducati
di carlini d'argento a Giovan Battista Angrisani (7). Alla morte di
Giovan Battista succedette il figlio Donato Antonio che con Regio
Assenso del 14 ottobre 1660 vendette il feudo, con patto de remehendo
(8) ad Andrea Terralavoro, il cui figlio Alfonso, con il consenso
del fratello primogenito Pietro, lo retrovendette, con Regio Assenso
dell'11 gennaio 1685 a Giuseppe Angrisani, fratello ed erede di Donato
Antonio, il quale era morto il 19 luglio 1682.
Al Barone Giuseppe Angrisani si devono ulteriori interventi per rendere
più accogliente la chiesa e più rispondente alla necessità
del culto ed alla devozione dei fedeli.
Lo stesso Angrisani volle lasciare una traccia visibile di sé
facendosi ritrarre, in atto di devozione ai piedi di San Giuseppe,
su una tela da lui commissionata e tuttora esistente, anche se provata
dall'usura del tempo.
Da una visita pastorale fatta nei primi decenni del 1700 la chiesa
si presentava pressappoco con queste caratteristiche: "lunga
circa 15 metri e larga 7 col pavimento ad astrico, ebbe ad avere 5
altari invece di 3: sempre al centro l'Altare Maggiore dedicato alla
Vergine del Rosario; sul lato destro, guardando dalla porta principale
d'ingresso, più in là l'Altare dedicato a S. Giuseppe
Patriarca con una tela del Santo, fondato dal Barone Giuseppe Angrisani
alcuni anni prima della sua morte, e più in qua l'Altare a
S. Antonio di Padova con un quadro su tela, mentre sul lato sinistro
l'Altare di S. Vito, e più in qua l'Altare di Santa Caterina
Vergine e Martire eretto per devozione di Caterina Tarantini. I suddetti
Altari hanno dei Legati o su terre o su denaro per Messe da celebrare.
In specie per l'Altare di S. Giuseppe D. Leonardo Pennetta nel 1743
ha pensato per un buon Legato" (9).
Alla morte di Giuseppe Angrisani, che non ebbe figli, il feudo di
Torchiarolo cadde nelle mani del Regio fisco che il 16 aprile 1726
investì dello stesso Ambrogio Caracciolo dei principi di Avellino,
il quale il 9 novembre del medesimo anno ricevette su Torchiarolo
il titolo di principe da Sua Maestà Imperiale Carlo VI (10).
Da questo momento, e per più di 150 anni, la chiesa del Rosario
non contò più sugli interventi di manutenzione ed ammodernamento
di qualche devoto benefattore.
L'edificio, pertanto, con la sua struttura in muratura, ma con il
suo tetto a canne fu soggetto al deterioramento, risultando così
sempre più inadeguato al regolare e decoroso svolgimento delle
funzioni sacre.
Bisognava aspettare fino al 1890, perché qualcuno ritornasse
ad interessarsi della chiesa, ormai in stato di abbandono.
Questa volta fu un religioso, il sacerdote Don Beniamino Miglietta,
che a proprie spese provvide ad avviare i lavori della ricostruzione
dell'edificio sacro a maestranze locali, esperte nella lavorazione
della pietra leccese.
Nel giro di pochi anni la stessa veniva restituita al culto dei fedeli,
totalmente rinnovata nella sua architettura.
La cerimonia della sua inaugurazione si celebrò il 1° ottobre
del 1896, ma la riapertura al pubblico culto avvenne solo il 5 novembre
1898, come è testimoniato dalla lapide incastonata all'interno
della chiesa sul portone centrale.
cosimo stefanelli
NOTE
1) M. Ciccarese, Religiosità di Torchiarolo in quattro secoli
di storia dal 1590 al 1982, Galatina, Editrice Salentina, 1983, pag.
83.
2) A. Foscarini, Armerista e notiziario delle famiglie nobili, notabili
e feudatarie di Terra d'Otranto, Lecce, Arnaldo Forni Editore, 1927,
pag. 235.
3) M. Ciccarese, Religiosità di Torchiarolo, cit. pag. 82.
4) Curia Vescovile di Lecce, Relazioni delle Sante visite fatte in
Torchiarolo dai Vescovi, Monsignore Luigi Pappacoda, 10/V/1640.
5) G. Arditi, La corografia fisica e storica della provincia di Terra
d'Otranto, Arnaldo Forni Editore, 1979, pag. 615.
6) C. Maci, Le confraternite della città e della Diocesi di
Lecce, Schena Editore, 1991, pag. 110.
7) L. A. Montefusco, Le successioni feudali in Terra d'Otranto - Le
province di Brindisi e Taranto II, Istituto araldico salentino "Amilcare
Foscarini", Lecce, 1996, pag. 90.
8) Patto per la vendita a garanzia di un credito, con riscatto del
bene una volta che il debito è soddisfatto.
9) M. Ciccarese, Religiosità di Torchiarolo, cit., pagg. 91-92.
10) A. Foscarini, Armerista e notiziario..., cit., pag. 30.
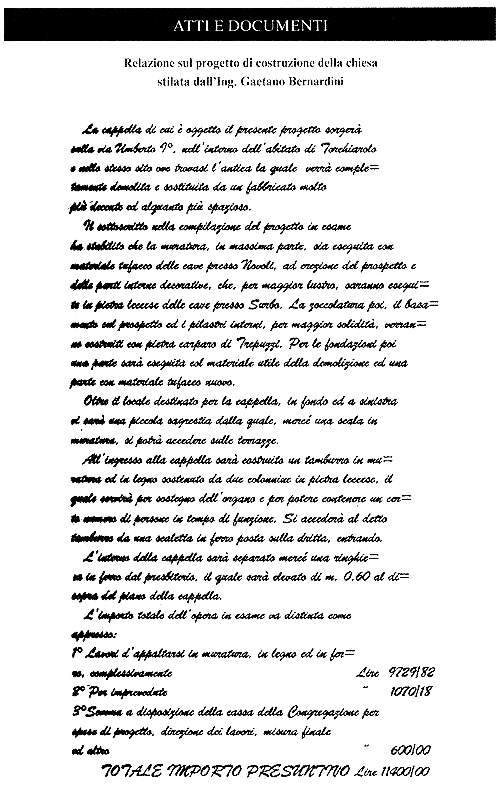
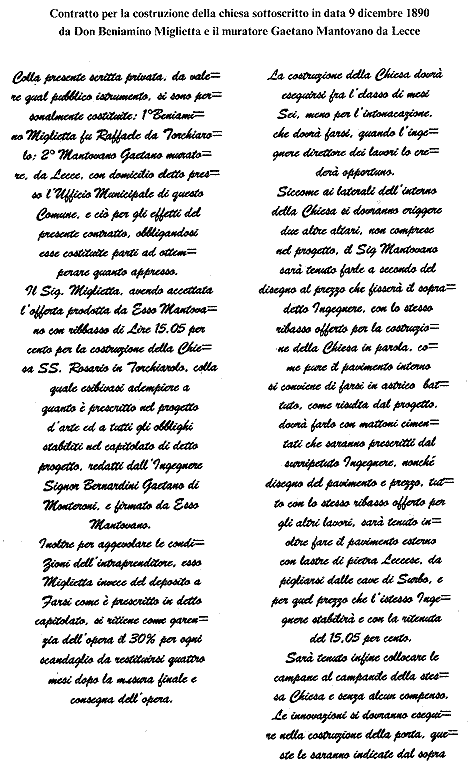
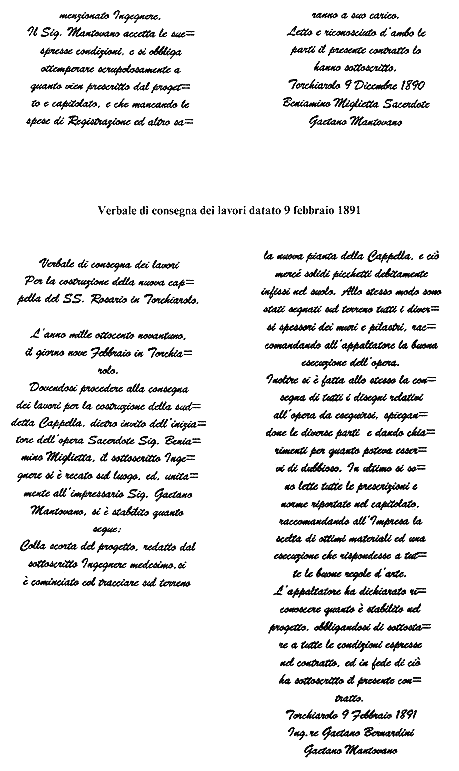
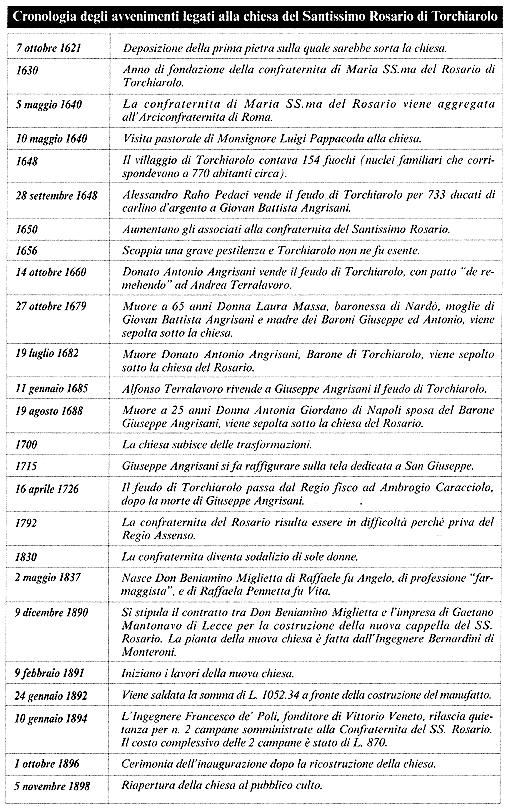
Suite per Paoloiacopo e Alessandra
Biagia Marniti
Luna Lu
la filastrocca di Paoloiacopo
Luna Lu dice
il bimbo
che saluta e chiama la luna.
Mamma dammi la luna
la luna piccola
non ancora cresciuta,
il suo spicchio di luce
che indugia sul mio cuscino,
prendila mamma
sospira con forza il bambino.
La luna è di tutti
risponde la mamma
è tua, è mia,
degli altri piccini
e nel cielo mai stanca
cammina, cammina.
Luna Lu
allora ritorna,
grida stupito il bambino.
Ad un anno e mezzo Paoloiacopo...
Come un percòco
sei precoce
bimbo biondo e riccioluto,
amoroso della luna e della luce
dell'armonica che suoni
dolcemente.
Non conosco mani più attente
che già muovono lo sterzo
di un'auto ferma, non accesa.
Battono le mani
e poi salutano dal vetro chiuso
chi passa e guarda disatteso.
Paoloiacopo e Alessandra
per Albertina e Lucia
Se la maternità
sia un dono
o altro tormento d'amore non so,
ma tu essere nascosto
a me pronta a partire forse dirai:
"Desidero conoscere ciò che tu ami,
il cielo, gli alberi,
lo sciabordio delle onde,
la sfera del sole,
il cerchio della luna,
cogliere l'essenza dei mondi
e vivere sulla terra".
Questo mi dirai
piccolo essere nascosto?
Nobildonne d'altri tempi
Nella silenziosa camera dove, da qualche anno, dormo nel mio letto
cinese, al piano terreno del castello di Casamassella, in comune di
Uggiano La Chiesa, sulla grande parete bianca che fronteggia il giardino
dell'ingresso, cui si accede non dal portone centrale in pesantissimo
legno, sotto il maestoso terrazzo, bensì dall'alto cancello,
seminascosto tra gli antichi rampicanti, divenuti enormi e nodosi,
tali da intrecciarsi a morte con le sbarre appuntite dell'inferriata,
nella camera evocatrice, sotto le volte leccesi, v'è il profilo
suggestivo d'una dama in bianco e nero, diciamo il ritratto a carbone
su calce, rappresentante la piccola testa con cuffia d'una vecchia
signora, china a ricamare.
E' un ritratto appena accennato, quasi un'apparizione, nell'angolo
in basso dello spazio rettangolare d'una specie di primo schizzo d'un
quadro, per il resto, ancora tutto vuoto.
Mi dissero di proteggerlo, quel diafano quadro, quel delicato disegno,
quel ritratto d'altri tempi, dagl'imbianchini e dai restauratori...
Mi raccomandarono gentilmente di non toccare quell'immagine, pur se
accennata, che fa parte della storia del castello dove decisi, ultimo
capriccio di nomade, d'abitare per qualche anno, allo scopo di scrivere
cose diverse in un ambiente mai sperimentato.
Le fantasiose malignità dei pigri, a base di spettri e persino
d'un pazzo che viveva nella torre, non riuscirono ad impedirmi di
conquistare il beneficio di quei silenzi; soprattutto, in seguito,
il sincero rispetto che sentii di dovere verso quello strano affresco,
iniziato e mai finito.
Un po' come gl'itinerari, d'un certo addetto culturale. La stanchezza,
oramai, consigliò di semplicemente coprire quella visione da
romanzo gotico con un'enorme tela ad olio.
Me l'ero portata dall'Indonesia, ultima sede, e risultò adatta
alla bisogna.
Le prime notti, per la verità, temevo che la patrizia immagine
del muro respingesse quel coperchio invadente e profano: nei castelli,
non si sa mai.
Tre volte, infatti, quel pittorico schermo, con cui nascondevo ai
miei paurosi sonni il profilo della vecchia nobildonna, cadde a terra,
staccandosi dal muro con sinistro fragore, nel bel mezzo della notte.
Alla fine, mi accorsi che, per appendere pesanti cornici alle umide,
stratificate pareti dei manieri, necessitano lunghi chiodi d'acciaio,
non i consueti gancetti d'ottone, da salotto buono.
Dimenticate, poi, le invidiose, irrazionali fole, mi abituai a dormire
con il cuscino a contrasto dell'incombente parete bianca: tranquillo,
nell'acquisita sicurezza che Lei era lì, aristocratica, ospitale,
comprensiva, generosa e discreta, come di sicuro lo era stata da viva...
Ogni tanto, sollevavo la tela sovrapposta e l'immagine misteriosa
dal profilo gentile, vera anima di quella camera antica, non si era
mossa.
Cosicché pensavo, ancora una volta, d'aver fatto bene a scegliere
quel mio angolo privato, quel mio comodo pensatoio, quel mio finale
modo di vivere in penombra, nelle stanze d'uno storico castello, sperduto
nel profondo Sud.
Ma la curiosità dell'intellettuale volle saperne di più
e prese il sopravvento. Quel palazzo (così lo trovai meglio
definito in un libro, che citerò in nota) sembrava aver visto
castellane eccezionali, in contrasto con il luogo comune delle meridionali
vestite di nero, capaci soltanto di virtù domestiche e non
certo di amministrazione fondiaria. Basti il seguente esempio di coraggiosa,
anche se femminile, gestione d'un patrimonio terriero; esempio del
quale ero venuto a conoscenza, dopo che un gruppo di giovani come,
oggi, pochi se ne registrano, aveva chiesto il mio parere: troppo
tempo stava passando.
Come utilizzare una tal lungimirante fondazione, nel pieno rispetto
delle volontà d'una signora, la quale aveva amato il tranquillo
centro agricolo di Casamassella, così come io, forestiero sopraggiunto,
già lo stavo amando?
Procediamo con ordine.
Il fatto è che a farmi ulteriormente interessare a Donna Carolina,
la ricamatrice instancabile di camera mia, fu proprio quest'altra
illuminata Donna Giulia, morta ottantaduenne, dopo un'esistenza esemplare.
Il documento notarile, fattomi avere da quei giovani in copia conforme
a titolo informativo, mi aveva "presentato" un'aggiornata
latifondista-riformista, nata a Maglie il 18 luglio 1895 e morta in
Uggiano La Chiesa il 21 gennaio 1984, capace di lasciare disposizioni
testamentarie, del tutto insolite come le seguenti:
"... Il mio desiderio è che questo Centro sia sorgente
di bene per gli abitanti di Casamassella ed anche oltre se possibile,
incoraggiando i giovani ad interessarsi ai lavori agricoli, alle attività
artigianali e culturali, offrendo loro la possibilità di sviluppare
la propria personalità coi suoi talenti e di indirizzare sanamente
la loro vita di lavoro e di famiglia. Tale Centro dovrebbe essere
un incoraggiamento per la popolazione del Mezzogiorno, così
dimenticata, a rimanere nella terra natìa con dignità
e serenità" (1).
Non ero avvezzo a leggere testamenti, però questo di cui alla
suddetta Fondazione, considerandone i nobili scopi, evidenziati nel
testo da un ricorrente "appena possibile" (che, purtroppo,
ancora attende l'agognata attenzione!), meritava d'essere riletto.
Ribaditi in cinque chiarissimi punti i fini dell'opera, Giulia Starace,
firmando a Le Costantine in data 1 novembre 1981, terminava con un
secco, dignitoso e sereno: "Mi perdonino tutti" (2).
Interessante pure l'invito a non modificare il rapporto quantitativo
tra bosco, uliveto e terra seminativa, "proporzione che dobbiamo
alla visione così chiara di mia Madre...".
Eccoci, di nuovo, alla nobildonna di camera mia.
Quei ragazzi, dunque, mi hanno fatto scoprire una donna nobile di
nome e di azione che, per tornare al disegno della parete sovrastante
il mio letto cinese, rimandava all'altro, al primo incontro femminile,
quello della grande parete bianca.
Chi era, dunque, la castellana intenta a ricamare, nell'angolo di
quel disegno intoccabile?
Ecco, la figlia ne aveva appena accennato, nel testamento.
Due donne, due storie parallele.
Ora lo so chi fu Donna Carolina, questa volta grazie anche alle pagine
d'un diario. Vi si descrive una certa amicizia, la quale, a me, ex
professore di filosofia passato alle Relazioni Culturali, conferma:
se non fai scelte di vita, non conosci personaggi. Bene, pensate a
quante volte la mia generazione d'insegnanti avrà spiegato
Benedetto Croce.
Ecco, ora abitavo nel castello dove la moglie del filosofo veniva
a trascorrere giornate tranquille. Ancora una volta, l'insipido titolo
d'un mio vecchio libro sembrò indovinato; il mondo è
piccolo. Procedendo a ritroso, insomma, ero giunto a scrivere di Carolina
De Viti De Marco, morta a Casamassella (Lecce) all'età di 102
anni, il 24 giugno 1965, sorella del famoso economista marchese Antonio
De Viti De Marco, e madre della sopracitata Donna Giulia Starace.
A questo punto, cedo ad altri, testimoni diretti, la parola:
"In serata Croce si è recato a far visita a Donna Carolina
De Viti De Marco, ospite del genero prof. Donato Gargasole. Mia moglie
e mia figlia vi si trovavano. Croce ha parlato molto della sua famiglia.
Tra l'altro ha detto che la sua biblioteca conta 50.000 volumi e che
conserva libri da lui acquistati quando aveva quindici anni"
(3).
Un P.S. del 1966, a proposito della non più misteriosa figurina,
aggiunge:
"... Numerose erano le persone che quotidianamente si recavano
a trovarla per il piacere di conversare con lei, sempre sensibile
ai problemi dello spirito.
Tra i tanti che le facevano corona, il più assiduo fu certamente
l'avvocato Michele De Pietro, principe del Foro leccese, ex Senatore
ed ex Ministro Guardasigilli, ma soprattutto umanista di rara intelligenza.
Donna Carolina, così la chiamavano tutti, è stata attivissima
durante la sua lunga esistenza. Particolarmente importante la scuola
di merletti fondata a Maglie, che ebbe fama internazionale. Donna
Carolina era molto amica della moglie di don Benedetto, Adele Croce,
la quale spesso si recava a Casamassella e di volta in volta vi passava
alcuni giorni in piena solitudine e comunione di spiriti" (4).
Basta questo, per sentirmi felice ed onorato di quel dormire vicino
al suo ritratto in bozza.
Spesso sollevo il quadro zavorra, la guardo e, compiaciuto, mi metto
a pensare dove m'ha condotto il destino e quanto sia ricco l'aristrocratico
Sud di cose e persone da scoprire (5).
Quei fogli di diario, per esempio, furono scritti da un attento e
colto giornalista negli anni 1941-'42. Quanti li conoscono?
Comunque, dall'incontro galeotto, come da altre concomitanze di queste
riflessioni confuse, tuttavia soddisfatte e meravigliate in una, esce
la gioia d'aver proposto all'attenzione dei ricercatori locali, per
meriti differenti ma sempre lodevoli, due intelligenze femminili,
che riscattano la donna meridionale dalle troppo facili definizioni
nordiste, a base di religione codina, di tradizionale assenza di voce
in capitolo, civile e politica, soltanto perché femmina sei...
Cosicché: "Viva Loro! e le due querce, che nel cortile
dell'austero palazzo portano i nomi, secondo la gente del contado,
di Donna Carolina e Donna Giulia ed inquadrano simmetricamente il
tramonto, in fondo al parco, d'un gran sole rosso, che promette bene!"
(6).
f.s.
NOTE
1) Dalla copia conforme del verbale di pubblicazione di testamento
olografo, redatto dal Dott. L. M. Coppola, Notaio in Copertino, ritengo
utile riprodurre alla lettera gli scopi della fondazione:
I - Svolgere un'attività agricola biodinamica sul terreno delle
Costantine. Faccio presente il pensiero di un Perito agrario, che
apprezzò molto la felice proporzione fra bosco, uliveto e terra
seminativa. Prima di modificare questa proporzione, che dobbiamo alla
visione così chiara di mia Madre, prego di tener conto di questa
osservazione. Mi oppongo fermamente alla vendita, completa o parziale
delle Costantine, create con tanto amore da mia Madre.
II - Appena possibile, organizzare Corsi con applicazioni pratiche
di Agricoltura biodinamica (o, in mancanza, biologica) per i giovani
di Casamassella.
III - Appena possibile, prevedere un'assistenza Sociale-Sanitaria
a domicilio, per sani e handicappati.
IV - Prevedere l'apertura di un piccolo Giardino d'infanzia.
V - Studiare, appena possibile, l'artigianato locale tradizionale
per ridargli vita.
2) Le Costantine sono una tenuta agricola, secondo il documento notarile,
in agro di Uggiano La Chiesa di circa Ha. 33 (di cui Ha. 2.42 in agro
di Giurdignano) "con tutti i fabbricati ivi esistenti".
3) Da Fogli di diario di Luigi De Secly in Studi di Storia Pugliese
in onore di Nicola Vacca (V. a pag. 154), Galatina, Mario Congedo
Editore, 1971, pag. 591.
4) Sulla benefica tranquillità di questo piccolo paese del
basso Salento già scrissi, nel dicembre 1989, sul mensile Espresso
Sud, con il titolo E si scoprì l'agriturismo dello spirito
(V. a pag. 46).
5) V. il mio studio Antonio De Viti De Marco, marchese salentino e
maestro di Scienza delle Finanze.- un personaggio da riscoprire a
pag. 83 di Studi etno-antropologici e sociologici, Atena 2000 Editrice,
Napoli, Anno 1990.
6) sul gusto della tradizione da queste parti, vedasi Quando si diceva
boffetta con tiraturi e la poesiola dedicata alla Madonna della Scala,
a pag. 233 del lu Lampiune, Quadrimestrale di cultura salentina (Anno
VI, N. 2, agosto 1990).