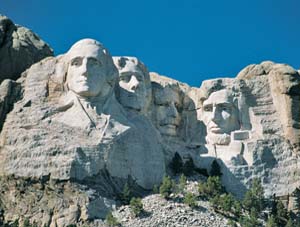|
Scioccante vedere oggi il dollaro
imbarcare acqua, speronato dall’euro, dalla sterlina, dal
franco svizzero, persino dall’umile dollaro canadese, considerati
poco più di tagliandi
per il gioco del
Monopoli.
|
|
Dollaro. La parola ha il suono dei talleri d’argento boemo
ai quali deve il nome. Evoca sogni di ricchezza, ma soprattutto
di sicurezza, di forza, di egemonia, come una nave inaffondabile
tra la flotta di barchette e navigli monetari sballottati dai marosi
delle periodiche tempeste valutarie.
Vederlo oggi imbarcare acqua speronato dall’euro, dalla sterlina,
dal franco svizzero, persino dall’umile dollaro canadese, che
gli statunitensi avevano sempre considerato come tagliandi per il
gioco del Monopoli, è molto più che un problema finanziario
o una questione di commerci e di scambi internazionali. È
lo shock di scoprire che una supremazia in apparenza inattaccabile,
espressione e strumento nello stesso tempo della supremazia dell’America
sul mondo, sta rischiando di colare a picco.
Il dollaro è stato per oltre settant’anni molto più
di uno strumento valutario, di una moneta-rifugio o di una riserva
custodita nei forzieri delle nazioni, o nei conti numerati dei despoti
e dei trafficanti: è stata la bandiera che i marines e i
fanti sbarcati nelle isole del Pacifico e sulle spiagge della Normandia
piantarono, anche acquistandola con le loro vite, sul mondo.
Agli elettori americani che guidano Chevrolet e Ford, che fanno
acquisti negli hangar commerciali della più grande catena
di discount al mondo, la Wal-Mart Stores, che mangia carne macellata
in Nebraska, patate raccolte nell’Idaho e indossa camicie cucite
in Cina pagate pochi centesimi all’ora, l’affondamento
del dollaro interessa ben poco. È l’America della “costa
blu” e della “riva sinistra”, delle sponde oceaniche
dove milioni di Sans Papier sudano sangue per mandare a casa dollari
con i quali si compra sempre meno; è l’America dove
si calzano scarpe italiane, si guidano auto tedesche e si sogna
la vacanza in Toscana; eccola, questa America, dove l’anemia
della valuta statunitense pesa.
E qualcuno insinua, come il finanziere James Cramer, conduttore
di uno show in Borsa, che al Presidente non dispiaccia molto punire
gli snob che comunque non voterebbero mai per i repubblicani o far
calare il valore delle rimesse di quegli emigrati che in California
votano per i democratici. Ma né a Manhattan né a Omaha,
né a San Francisco né a Cincinnati, né a Los
Angeles né a San Diego, ci sono quei segnali di panico che
avrebbero travolto l’Italia, se avesse visto la vecchia lira
affondare.
Sono i centri-studi, gli osservatori che cercano di guardare oltre
l’orizzonte dei soliti cicli di boom and crash, come quelli
che stanno squassando il mercato degli immobili e dei mutui, quelli
che annusano il cambio epocale di clima. «Ormai il mondo ha
due monete di riferimento, l’euro e il dollaro», avvertiva
già nel 2003 il Cato Institute di Washington, e solo perché
la Cina, che insieme con il Giappone possiede la massima quantità
di cambiali del Tesoro americano nelle proprie riserve, puntella
ancora la valuta Usa, il “Signore onnipotente” non tracolla.
Ma l’universo statico dei cambi, costruito a Bretton Woods
sopra l’egemonia politica, militare e culturale degli Stati
Uniti dominanti, è divenuto una galassia fluida, un sistema
con due soli. Almeno finora. Almeno finché la Cina non deciderà
di calare il proprio asso, cioè lo yuan-renminbi, e di commerciare
utilizzando la propria moneta.

Di questa rivoluzione, che sta portando a conseguenze forse inevitabili,
quel che accadde nel 1971, quando l’America fu costretta ad
abbandonare la parità fra dollaro e oro per impedire il saccheggio
dei lingotti di Fort Knox compiuto soprattutto dalla Banque de France,
la gente sa poco o nulla. I grandi media popolari, e anche i giornali
più autorevoli, ignorano il fatto che il dollaro americano
si sia dimezzato di valore rispetto all’euro nell’arco
di cinque anni, da quando cioè bastavano 75 centesimi di
dollaro per comperare un euro. E lo stesso universo di Internet
dorme al cospetto del colossale debito statunitense, ai miliardi
di buoni del Tesoro accatastati nelle casseforti di Pechino e di
Tokyo, al rischio d’inflazione che sempre la svalutazione della
propria moneta comporta.
Tutto questo è stato definito l’autismo valutario di
una nazione abituata a considerare appunto “Dio” la propria
moneta, che resiste anche alle voci terrificanti di un possibile
passaggio in massa dei produttori di greggio dal dollaro all’euro;
o alle non più tanto velate minacce dei cinesi, che meditano
di passare dal dollaro alla valuta europea come principale strumento
di riserva. Nel clima di persistente autoreferenzialità che
continua a dominare negli Stati Uniti, ipotizzata dalle sirene del
“nuovo secolo americano”, non si alza una voce autorevole,
né alla Federal Reserve né al Tesoro, che inviti a
riflettere su quale fondamentale ruolo abbiano giocato il dollaro,
la sua centralità assoluta, il suo essere il denaro del commercio,
delle riserve, dell’ultimo rifugio, nel creare il secolo americano
vero, il Ventesimo. La fissazione della forza militare ha fatto
dimenticare che, senza l’egemonia culturale e l’egemonia
finanziaria, le armi da sole non bastano a sostenere un Impero,
neanche se lo si ritiene un Impero del Bene.
È stato ricordato che è necessario tirar giù
dagli scaffali Hemingway e Fitzgerald per ricordare che cosa fu
ai suoi bei tempi il dollaro. Bisogna leggere un brano di Festa
mobile, e un altro di The Sun Also Rises (Fiesta, nella celebre
traduzione einaudiana), e poi un altro di Tenera è la notte
o di Babilonia rivisitata. Ed ecco affiorare, in pochi capoversi,
la grandezza della moneta americana, e il suo favoloso potere d’acquisto.
Negli anni immediatamente successivi alla Prima guerra mondiale,
Hemingway vive a Parigi, insieme con la prima moglie, Hadley. Dagli
Usa riceve la piccola pensione che lo Stato assicura ai reduci (Ernest
è stato autista di ambulanze sul fronte italiano, con esperienze
che gli ispireranno Addio alle armi), e dal Canada gli pervengono
i magri compensi che il “Toronto Star” gli paga, in dollari
americani, per i suoi articoli. Eppure vive come un re. Nel 1920
un dollaro vale infatti 15 franchi, nel ‘23 ne vale quasi 17,
nel ‘24 supera i 19. E con diciannove franchi – come emerge
dalle pagine di Festa mobile – si possono avere moltissime
cose: un pranzo alla Closerie des Lilas, vari bicchieri di Bordeaux
e di Sancerre, altrettante tazze di café-crème, persino
un viaggio ogni tanto fino in Andalusia, a pescar trote dalle parti
di Ronda.
Stessa storia quando giungono nella capitale francese Harry e Mary
Crosby, Scott e Zelda Fitzgerald, e tutte le altre celebri coppie
americane di quegli anni: grandi alberghi, fiumi di champagne, notti
di follie. A New York, i guadagni che Fitzgerald ha ricavato con
Di qua dal paradiso e con Belli e dannati, e i generosi compensi
che le riviste americane gli passano per i racconti non basterebbero
a garantirgli una vita così dorata. Ma a Parigi, quando si
cambia un traveller’s cheque, si esce da qualsiasi banca con
le tasche colme di franchi.
Non si tratta soltanto di costoro. A godere del dollaro pesante
fu l’intera “lost generation”, da Pound a Dos Passos,
da Anderson a Ford Madox Ford, tutti nella capitale francese, tutti
senza grandi mezzi, ma tutti tenuti a galla da un cambio tanto propizio
da sembrare miracoloso. E a dir la verità, senza il dollaro
a diciannove franchi non ci sarebbe stata la “lost generation”,
non ci sarebbero stati gli “expatriates” americani sulle
rive della Senna, Gertrude Stein non avrebbe mai potuto parlare
di «una generazione perduta».
La festa mobile durò parecchi anni. Ancora nella seconda
metà dei Venti, quando se ne erano già andati Hemingway,
Fitzgerald e molti altri scrittori americani, dagli Stati Uniti
continuavano ad approdare a Parigi coppie celebri e aspiranti artisti.
Era in genere gente ricca (e basterebbe pensare al Maugham de Il
filo del rasoio) che non abitava a Montparnasse ma all’Avenue
Foch, resa ancora più ricca e prodiga proprio dalla potenza
del dollaro. Poi, all’improvviso, sopraggiunse il terremoto
del ‘29: il crollo di Wall Street trascinò nel gorgo
anche il valore del dollaro, la vita a Parigi si fece costosa, e
gli “expatriates”, salvo Henry Miller, che viveva con
molto poco, scomparvero.
Ma si trattò di un allontanamento temporaneo, perché
il legame dollaro-Parigi-letteratura si riprodusse, senza variazioni
degne di nota, alla fine del Secondo conflitto mondiale. A partire
dal ‘48-‘49, dal momento che il dollaro aveva ritrovato
la sua imbattibile forza, mentre il franco della Quarta Repubblica
zoppicava vistosamente, la capitale francese si affollò di
nuovo di scrittori americani, titolari di piccole rendite in valuta
statunitense. Punto di ritrovo, questa volta, Saint Germani-de-Prés,
dove andarono ad abitare William Styron, James Jones, Richard Wright,
James Baldwin, William Gardner Smith… Più in là,
dalle parti del boulevard Saint Michel, alcuni anni dopo si attestarono
William Burroughs e Allen Ginsberg.
Oggi il dollaro sbanda pericolosamente, sembra un ferito che si
stia lentamente ma inesorabilmente dissanguando. Ma allora metteva
il vento nelle vele persino della letteratura. E non era soltanto
questione di scrittori americani a Parigi. Dagli anni Cinquanta
sino alla fine dei Novanta, il biglietto verde è stato un
passe-partout per ogni tipo di viaggio in ogni angolo del mondo.
È stato un talismano per chi doveva muoversi con una maggiore
sicurezza personale nell’Asia, in Africa, nel Vicino, Medio
ed Estremo Oriente, nella vecchia Urss e nei Paesi satelliti, dove
si poteva essere fermati alla dogana con un pretesto qualsiasi (macchina
fotografica con scatti su presunti obiettivi militari, traffici
di diamanti, possesso di sostanze stupefacenti, provenienza da Paesi
con scarsa igiene e dunque necessità di quarantena) e altri
fantasiosi ricatti, che venivano superati senza eccezione, ovunque,
facendo scivolare un biglietto da 20 dollari nelle mani della guardia
di frontiera. È stato un talismano per ottenere una colazione
in camera a Mosca; per farsi dare sigarette americane a Bucarest
o un vino discreto a Baghdad o una camera decente in un albergo
a Varsavia; o per far trasmettere per telefono un servizio registrato
a Delhi o al Cairo o a Dacca o a Pechino o a Islamabad o a Bangkok;
per girare in taxi dopo le 20 a Tripoli o per bere un whisky dry
in Kuwait...
Oggi che il dollaro “cede, retrocede e periclita” può
venire in mente un’ultima immagine di quella che fu la sua
leggendaria potenza: le processioni nei paesi del nostro Sud, trenta
o quarant’anni fa, quando le Madonne procedevano portate a
spalla, e sulle loro vesti si appuntavano – oltre alle nostre
lire e alle monete europee – anche i biglietti verdi dei devoti
emigrati oltreoceano: anime lontane, che volevano rivendicare radici,
fede, e segni della propria fortuna.
Chi ha fatto, negli anni scorsi, una scommessa rialzista sull’oro
e sulle materie prime, oggi può solo esser felice. Il valore
del metallo giallo è salito oltre misura, superando addirittura
la soglia dei 1.000 dollari l’oncia. Nel 2001 valeva attorno
ai 300 dollari, e dopo l’11 settembre delle Twin Towers l’intera
comunità degli analisti finanziari riteneva il prezzo già
spropositato. Alle grandi banche l’oro non piace, si sottrae
alle manipolazioni, e di conseguenza viene derubricato a bene-rifugio.
Tuttavia, chi ne avesse acquistato all’inizio degli anni Duemila,
oggi vedrebbe sostanzialmente triplicato il valore investito.
Il barile del petrolio e le materie prime sono spinti al rialzo,
determinato anche dalla caduta del biglietto verde. Un analogo trend
si è avuto per gli immobili, ma c’è una differenza,
e non da poco: per gli immobili si era in una bolla scatenata dalla
politica monetaria della Federal Reserve. Ad un certo punto, la
crisi subprime ha rotto gli equilibri. Ma che i prezzi fossero artificialmente
troppo alti era evidente. E non solo in centro, a Manhattan.
L’oro è diverso: perché si è apprezzato
andando controvento. Si è apprezzato sostanzialmente in virtù
della politica della Fed: ha detto agli osservatori di mercato,
prima di qualsiasi altro indicatore, che c’era troppa moneta
in giro. Quando la moneta è troppa, come del resto qualsiasi
altro bene, perde valore. L’oro ce lo ha detto e ce lo continua
a dire, anche se Ben Bernanke nega e continua a tagliare i tassi.
Intanto, stime di buona fonte suggeriscono che l’inflazione
americana veleggi intorno al 7 per cento.
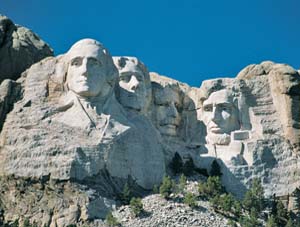
La crescita è pressoché ferma. Non siamo certo alla
stagnazione, ma a una vera e propria recessione, in base all’analisi
della maggioranza degli economisti interpellati: siamo in una crisi
analoga a quella degli anni Settanta. Quella crisi fu generata dall’abbandono
anche formale della convertibilità aurea (il “Gold Exchange
Standard”), con conseguenti spinte inflazionistiche, alle quali
si sommava a livello internazionale una situazione geopoliticamente
turbolenta (nel Medio Oriente).
È evidente che il clima odierno ci ricorda da vicino l’inizio
degli anni Settanta. Ora come allora, la Cina è in una fase
di grandi mutazioni, (ricordiamo che l’inizio del processo
di liberalizzazione, voluto da Deng, è del 1978). Ora come
allora, il Medio Oriente può tornare ad essere una polveriera,
dalla quale dipendiamo fortemente per via del petrolio (che, come
l’oro e le altre commodities, vede il proprio prezzo impennarsi).
Ora come allora, la Banca centrale americana è andata avanti
(e purtroppo va avanti) iniettando liquidità nell’economia,
sia in maniera diretta sia indiretta (per esempio, con spettacolari,
e illiberali, salvataggi di grandi istituzioni finanziarie, come
è avvenuto in queste ultime settimane quando è intervenuta
a soccorso di Fannie Mae, Freddie Mac e Aig).
Che cosa c’è di diverso? Alcune novità interessanti
e importanti. C’è l’euro, che sarà pure
gestito con tigna teutonica dalla Banca centrale europea, ma rispetto
al quale il vincolo di contenere l’inflazione potrà
certo danneggiare le imprese esportatrici, ma salva il valore del
denaro e i risparmi di noi tutti. C’è che l’economia
americana resta l’ombelico del mondo, ma i Paesi emergenti
non sono più una novità: quanto, piuttosto, una quotidiana
conferma, e un grande mercato bisognoso di merci, di servizi e di
infrastrutture.
C’è che la ricchezza del mondo è cresciuta, e
sono non pochi gli operatori di peso che sono pronti a subentrare
nel capitale delle istituzioni finanziarie che traballano, quando
il gioco si farà duro davvero e partirà un chiaro
segnale circa l’opportunità di fare profitto. C’è
che sono cambiati i modi e i tempi dell’intervento pubblico:
e per tutto il male che si possa pensare dei fondi sovrani, senza
alcun dubbio è preferibile uno Stato che si comporta da grande
investitore a uno Stato che si comporta da piccolo imprenditore.
In ultima analisi, la crisi c’è e deve esserci: perché
quando i banchieri centrali sbagliano, il conto inevitabilmente
lo paghiamo tutti. Ci sono pure elementi nuovi, però, che
rendono difficile fare previsioni. Quel che è chiaro è
che un’economia con i fondamentali comunque solidi, come quella
americana, pagherà dazio, ma poi tornerà a crescere.
E il dollaro potrà risalire sul trono.
|