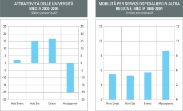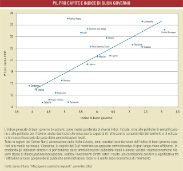|
|
Dicono gli osservatori più sensibili dei problemi delle aree arretrate del nostro Paese che gli scontri armati di Rosarno sono destinati ad azzerare i termini convenzionali del dibattito sulla questione dell’immigrazione in Italia, «strappando il velo di diatribe partitiche e ideologiche – scrive Mauro Calise – e mettendo violentemente sul tavolo (anzi, in piazza) la crudezza sociale del problema». Cioè: nel Sud della disoccupazione montante, del dilagante degrado civile, dei cartelli del crimine sempre più feroci, gli immigrati non hanno veste politica. Sono un’emergenza razziale. Le discussioni sulla cittadinanza, sull’istruzione, sulle libertà religiose semplicemente latitano, come fossero scienze d’un altro pianeta: «A Rosarno, come in tante altre parti del Sud, la lotta è quella primordiale e micidiale tra bianchi e neri».
Dentro la “Vucciria”,a Palermo. In epoca angioina, vi sorgeva un macello (“boucherie”, in francese), da cui proviene il nome. |
 |
Maria Ada Pisa |
Non erano mancati i segnali, anche se molti hanno cercato di far passare Castelvolturno (rivolta degli immigrati del settembre 2008) come una faida locale, o un fatto marginale. Né erano mancate le denunce, come quella – sferzante – della televisione britannica che all’inizio dell’anno documentava le condizioni bestiali in cui erano e sono costretti a vivere i lavoratori di colore proprio nella cittadina calabrese.
Ma, per cecità o per tornaconto, è prevalsa l’abitudine a considerare l’immigrazione come un pezzo del puzzle nordista, un problema legato in tutto e per tutto alla sottocultura leghista: un’ipoteca conservatrice sull’azione di governo, cui contrapporre quella progressista da parte dell’opposizione. Dopo Rosarno, proprio questa visione schematica è saltata. Come sempre, quando la società si riprende prepotentemente il posto che la politica tenta di usurparle.
La realtà è che le leggi che si varano, o delle quali si discute nelle aule parlamentari, sono lontane anni luce dalle piaghe che il Sud continua a portarsi addosso, e per le quali nessuno sembra avere risposte pronte, plausibili, utilizzabili. La realtà, che tutti cercano di esorcizzare, è che il Sud è stato reso sempre più un’appendice opaca e indigesta del Paese. Merito (si fa per dire!) bipartisan: delle forze conservatrici, dal momento che l’ipoteca leghista sul governo ha messo il Nord come ispiratore e motore di ogni decisione rilevante; e delle forze progressiste che, a valle di una lunga stagione di governo di molti enti locali meridionali, presentano un bilancio eufemisticamente definibile contrastato. E non si è saputo o voluto trovare la formula giusta per fronteggiare ritardi ed errori, senza cadere nella tentazione di gettare una volta per tutte la spugna. Con il risultato che oggi il Mezzogiorno si ritrova stracolmo di rappresentazioni di routine, quasi senza eccezioni negative, ed è privo di una rappresentanza politica radicata nei suoi problemi e decisa a provare a risolverli, o quanto meno a volgerli in positivo.
E l’orizzonte è sempre più buio. Tutti sanno che, sul fronte della crisi economica, il 2010 risulterà più duro dell’anno precedente. Quasi certamente si rafforzeranno i segnali di ripresa, ma questo riguarderà soprattutto il Nord, che sarà sempre più deciso a tirare i remi in barca (si veda il caso Termini Imerese, e non solo), in nome della difesa di uno statuseconomico cui non intende rinunciare, anche a costo di tornare a predicare minacciosamente la secessione. In un quadro così disgregato, aumenta il pericolo che crescano anche a Sud quelle pulsioni che da tanto tempo nel Nord leghista hanno alimentato il vento dell’antipolitica. Ma con un potenziale ben più alto di sfida alla fragilissima impalcatura statale, con un miscuglio esplosivo di qualunquismo e di ribellismo che potrebbe improvvisamente creare un’onda d’urto micidiale, sfociando in un movimento, più o meno spontaneo, di protesta, per poi entrare in una spirale di rivolta incontrollata, o peggio ancora torbidamente manipolata. A un secolo e mezzo da un’Unità mai di fatto realizzata.
Tutti sconfitti: leggi, meridionali, Stato, irregolari-clandestini. Di fronte all’impossibilità di regolarizzare la propria posizione, per questi ultimi non c’era via d’uscita se non un lavoro in nero, un ricovero “inaccettabile” o un affitto in nero, una vita che comporta l’impossibilità di formarsi una famiglia, o di richiamarne la propria da terre lontane, la ridotta possibilità di muoversi alla ricerca di una vera occupazione e persino di tornare alla propria terra d’origine, nessuna interazione sociale o culturale, nessuna difesa contro la xenofobia…
Da parte sua, l’Italia fa bene a respingere i migranti al di là dei propri mari, avendo ormai una capacità di assorbimento ridotta ai minimi termini. Ma è pura utopia pensare che l’immigrazione clandestina possa essere fermata del tutto. Fino a che vi saranno esseri umani così disperati che in un viaggio affrontano il rischio, tutt’altro che teorico, di perdere la vita e i pochi averi messi insieme da loro e dalle loro famiglie, fino a che vi saranno ignobili trafficanti di carne umana che lucrano sulla fame dei diseredati, fino a che vi saranno governi degli Stati d’origine che incoraggiano cinicamente il deflusso miserabile di manodopera generica, fino a che vi saranno datori di lavoro italiani pronti ad offrire lavoro nero o a bassissimo costo, fino a che vi sarà la possibilità per gli irregolari-clandestini di spostarsi da un Paese all’altro dell’area di Schengen, si capisce benissimo come sia impossibile non avere in casa torme di uomini allo sbando.
Si dice che di fronte a tutto questo le strategie di intervento siano quattro: si fa finta di niente, come accade quasi dappertutto, almeno fino a quando non si determinano gli tsunami per rabbia stratificata nel tempo; o si rispediscono al di là delle nostre frontiere coloro i quali non hanno permesso di soggiorno, senza tuttavia che si possano attuare espulsioni di massa; si penalizzano duramente i datori di lavoro e gli affittuari, anche se questo avrà un considerevole costo economico; si procede a periodiche sanatorie, con il rischio di indurre nuove correnti di migranti, attratti dalla prospettiva di una facile regolarizzazione. Altro non sembra esser dato.
Un secolo e mezzo di Italia unita, e per il Mezzogiorno si è trattato di un’unica, lunga Stagione all’inferno, come Rimbaud intitolò il suo celebre poema. Come il protagonista rimbaudiano, ancora oggi continuiamo a nutrirci volontariamente di menzogne, facendo finta di non vedere qual è il paesaggio autentico del Sud maculato dall’arretratezza, dalla corruzione, dalle mafie: allo stesso modo di decenni fa, prima che fiumi di denaro pubblico finissero nelle tasche sbagliate, e senza che mai una rivolta culturale e morale abbia scatenato i giorni dell’ira descritti da John Steinbeck in un libro emblematico, Furore. Scritto nel ‘39 durante la Grande Depressione, il romanzo poteva sperare, almeno, nel New Deal di Roosevelt, che il nostro Sud non ha avuto, e ancora non ha, pur avendone un estremo bisogno. Le grandi crisi si affrontano con grandi scommesse iniziali, fondatrici di nuove società. Pensare in grande e agire di conseguenza prepara il futuro.
Ebbene: Einaudi, De Gasperi, Menichella pensarono in grande, e per qualche anno sembrò che il Sud potesse risollevarsi. Cristo voleva andare oltre Eboli, radendo al suolo l’ossificata cultura contadina, alzando tralicci tra gli ulivi – come fu scritto – e introducendo le tute blu.
Alcuni si lamentarono: così il Mezzogiorno perde la propria identità, rinuncia alle radici. Come se il Sud fosse stato innocente e non avesse scritto una storia più tragica che grande! Anche questa, dunque, era menzogna. Perché la mutazione era già avvenuta dal secondo dopoguerra, quando l’emorragia demografica aveva portato milioni di meridionali a salire al Nord e a valicare le Alpi, e a scoprire che mondo faceva oltre i confini dei minifondi improduttivi e dei latifondi coltivati alla meno peggio; e a farsi nello stesso tempo negri-bianchi nei cantieri europei, accaniti risparmiatori, fonti di pregiate rimesse, eppure vittime della farisaica politica italiana, che se molto concedeva attraverso gli organi di intervento straordinario, molto di più riceveva fra ritorno di benefìci e rastrellamenti di valute pregiate.
Gran parte dell’Europa ha una cupa reputazione, ma questo non giustifica i misfatti, le miserie, i silenzi italiani. Perché anche il nostro Paese dà di sé un’immagine se possibile ancora più cupa, che impaura, dal momento che somma quel terribile sovrappiù che è il potere malavitoso. Difficile parlare diversamente, quando gli scenari sono delineati con estrema nettezza da un’archeologia industriale che avanza, da fabbriche abbandonate, da stabilimenti obsoleti, da campagne lasciate a se stesse; e tutt’intorno il vuoto pneumatico: vite prive di senso, giovani senza speranze, università con precari centri di ricerca, commerci che arrancano, treni che hanno ripreso a partire da gran tempo…
L’identità che abbiamo perduto la recuperiamo solo se non tradiamo quella vera inventandone una falsa, solo se sblocchiamo le nostre memorie e riscopriamo che il problema dell’Italia è, insieme all’identità nazionale, quella umana, solo se insegniamo che dobbiamo entrare tutti insieme, e non i privilegiati soltanto, nel mondo che continua a mutare, lasciandosi alle spalle quei territori dell’immobilismo che proiettano fino ai nostri giorni l’antico inferno di Rimbaud, senza un Cristo che apra le porte e valichi il limite delle attese, delle disillusioni, delle umiliazioni. Degli inganni di sempre.
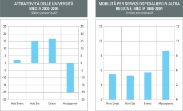 |
Qual è la situazione attuale delle regioni meridionali? Un gran volume di ottocento pagine, centinaia di tabelle e di slides: il “Dossier Mezzogiorno” presentato dalla Banca d’Italia alla fine di novembre del 2009 ha pochi precedenti. E rappresenta un’analisi impietosa della drammatica attualità della questione meridionale. Questa volta, però, gli indicatori scelti non sono soltanto quelli tradizionali relativi al reddito o alle infrastrutture. Nel mirino degli analisti ci sono soprattutto i servizi, dalla sanità all’istruzione. In sostanza, gli elementi fondamentali di quel “capitale sociale” da ricostruire invocati a gran voce dal Governatore Draghi.
Sanità. È il buco nero del Mezzogiorno, il modello da evitare. In genere, fa sapere l’Istituto di emissione, si spende di più per avere di meno. E le differenze non sono tanto nei valori assoluti, ma nella composizione della spesa. Spendiamo 50 euro pro capite in più per le medicine e 80 euro per gli ospedali. E non basta. Perché, sempre secondo l’indagine in esame, il Sud offre un servizio peggiore, obbligando i pazienti ad emigrare in altre regioni per avere un’assistenza migliore. Colpa anche della maggiore frammentazione della spesa ospedaliera. In Campania ci sono 23,5 ospedali per milione di abitanti, in Puglia 16,7, mentre la media del Mezzogiorno è pari a 24,6. Nel Centro-Nord la media scende intorno a 18,5.
Scuola. Anche qui il divario è evidente, soprattutto nella fascia d’età fra i 25 e i 64 anni. I diplomati sono il 30,4, contro il 35,3 del Centro-Nord, e i laureati l’8,9 contro il 9,7. Gli analfabeti (o i cittadini privi di titolo di studio) rappresentano ancora il 5,5 per cento della popolazione rispetto all’1,7 della restante parte del Paese. Ma c’è un gapanche nella qualità dell’istruzione e nella preparazione media degli studenti meridionali. Un gapche in alcune materie (come la matematica) comincia già dalla seconda elementare. Il ritardo è precoce anche nella comprensione di un testo italiano. Su un campione di 480 istituti superiori, nel passaggio tra la prima e la terza classe, le scuole del Sud perdono posizioni sia per quanto riguarda l’insegnamento della matematica che per la scienza. Nel Sud, infine, c’è una minore selettività nelle valutazioni interne.
Spesa pubblica. Il dossier smentisce il luogo comune di un Mezzogiorno che ha fatto il pieno dei fondi pubblici. Tra il 2004 e il 2006 la spesa prima ha assorbito 200 miliardi di euro, contro i 408 del Centro-Nord. La spesa regionale è pari al 5 per cento.
Banche. Il Governatore Draghi sostiene che nel Mezzogiorno ce ne sono a sufficienza, e che erogano il credito indispensabile per lo sviluppo delle aree regionali, in questo modo prendendo esplicitamente le distanze dal progetto di creazione di una Banca del Sud, che invece sta a cuore al ministro dell’Economia, Giulio Tremonti.
Rifiuti urbani. Anche in questo caso il giudizio è negativo. La percentuale della raccolta differenziata è abbondantemente sotto il 10 per cento in tutte le regioni meridionali. In Campania siamo al 15 per cento. Ma sempre molto al di sotto del 42 per cento del Piemonte o del 45 per cento della Lombardia. Con punte che arrivano al 50 per cento in Trentino e in Friuli. In compenso, il Sud presenta le percentuali più elevate di smaltimento in discarica.
Capitale sociale. Si tratta di una variabile che considera essenzialmente le norme di tipo informale che agevolano la cooperazione. In questo campo il ritardo del Sud è considerevole: -20 per cento per la produttività, -40 per cento per l’imprenditorialità, -22 per cento per la partecipazione femminile. Alcuni studi indicano che se il Mezzogiorno avesse le stesse dotazioni di capitale sociale del Centro-Nord, una parte consistente del ritardo verrebbe annullata.
Incentivi. Fra il 2003 e il 2008 sono arrivati alle casse delle imprese 33,2 miliardi di incentivi. Ma gli investimenti addizionali determinati dagli aiuti sarebbero pari solo al 6 per cento delle somme erogate dallo Stato.
 |
Sì, è un altro Sud, con numeri che sconfortano tutti. Confindustria ha confermato che se qualcosa è cambiato, è stato in peggio: fatta 100 la media nazionale degli indicatori sintetici di sviluppo economico e sociale, (un indice che combina al Pil pro capite altri indicatori della situazione socio-economica di un territorio), il Centro-Nord sfiora 115 punti, mentre il Sud si ferma a quota 72. Confindustria trova la cosa «preoccupante», anche perché nota che il distacco tra la regione più avanzata (la Val d’Aosta) e quella più arretrata (la Calabria) è salito di altri cinque punti, o che le ultime 22 province della classifica sono tutte meridionali, mentre le prime 22 sono tutte inesorabilmente a nord di Roma.
È la solita solfa: il Nord va, il Sud arranca, se possibile con maggior fatica di prima. Si leggano i dati Censis: in Italia ci sono un milione e 50 mila famiglie in condizione di “povertà alimentare”, con persone costrette a risparmiare sull’acquisto di cibo. Di queste, il 51,9 per cento è al Sud, dove abita un italiano su tre. Su 100 famiglie, in Sardegna 10,8 hanno questo problema, in Sicilia e in Basilicata più di 9. La media nazionale è del 4,4 per cento, ma al Nord l’unica regione che ci va vicino è il Piemonte (4,2 per cento). Si chiama povertà alimentare, ma non è molto diversa dall’altra povertà, quella assoluta, che – dati Istat – colpisce un milione e 120 mila famiglie: tasso medio nazionale 4,6 per cento; nel Nord 3,2 per cento; al Centro 2,9 per cento; al Sud 7,9 per cento. In altri termini, al Sud un milione e 700 mila persone si possono considerare povere. E lo sono perché non hanno lavoro. Il Rapporto dell’Isfol mostra come il tasso di occupazione nel Sud nel corso del 2009 sia sceso di altri due punti, passando dal 47 al 45 per cento rispetto all’anno precedente. Per i giovani va anche peggio: nel Mezzogiorno un giovane su due è inattivo, contro il 33 per cento del Centro e il 30 per cento del Nord.
Il divario tra le due parti del Paese si apre però ben prima del momento di lavorare: il 7,7 per cento dei giovanissimi del Sud – adolescenti che hanno tra i 14 e i 17 anni – ha smesso di andare a scuola e non fa più nulla. In Italia sono 126 mila i ragazzi in questa situazione. Ma il Nord-Est ha un tasso minimo: il 2,8 per cento.
E non basta. Perché chi lavora, se lo fa al Sud, incassa meno. L’estate scorsa la Banca d’Italia ha confrontato le retribuzioni lorde 2008 tra le varie aree del Paese. Era agosto, l’Italia era tornata a parlare di “gabbie salariali”, cioè di stipendi legati al costo della vita, come proposto dalla Lega e non disdegnato dal ministro dell’Economia: tradotto in pratica, sarebbe stipendi più alti al Nord e più bassi al Sud. I dati della Banca centrale erano questi: di due italiani che fanno lo stesso lavoro, quello che lavora al Sud prende in media tra il 15 e il 16 per cento in meno del suo collega settentrionale. A dimostrazione che per gli stipendi, e molto probabilmente non solo per quelli, il Mezzogiorno la sua gabbia ce l’ha già. Storicamente.
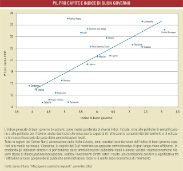 |
«I bar sono nuovamente affollati», dice un alto dirigente della Svimez. «Per colpa dei rientri», aggiunge. Nel 2008 si erano contate 170 mila persone che avevano mantenuto la residenza a Sud, ma vivevano e lavoravano a Nord. Poi il 20 per cento di coloro i quali avevano i contratti a termine, dopo appena sei mesi, sono stati costretti a tornare indietro, a tornare a vivere con i genitori, in attesa di nuove occasioni: è nata così la categoria dei “meridionali pendolari”, di coloro i quali difficilmente trovano lavoro nella terra d’origine, essendo specializzati nei servizi, settore pressoché inesistente nel Mezzogiorno. Svimez ricorda che per i lavoratori meridionali la crisi è più dura, che il sistema produttivo è meno coperto dagli ammortizzatori sociali, che l’avvio non correttamente incentivato di nuove iniziative resta nel limbo delle buone intenzioni e delle eterne, ed eternamente caduche, speranze. |